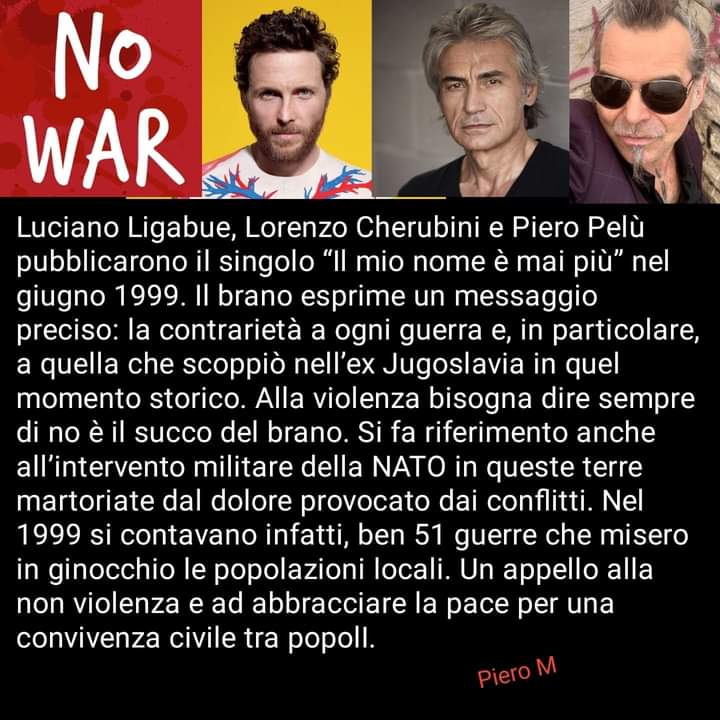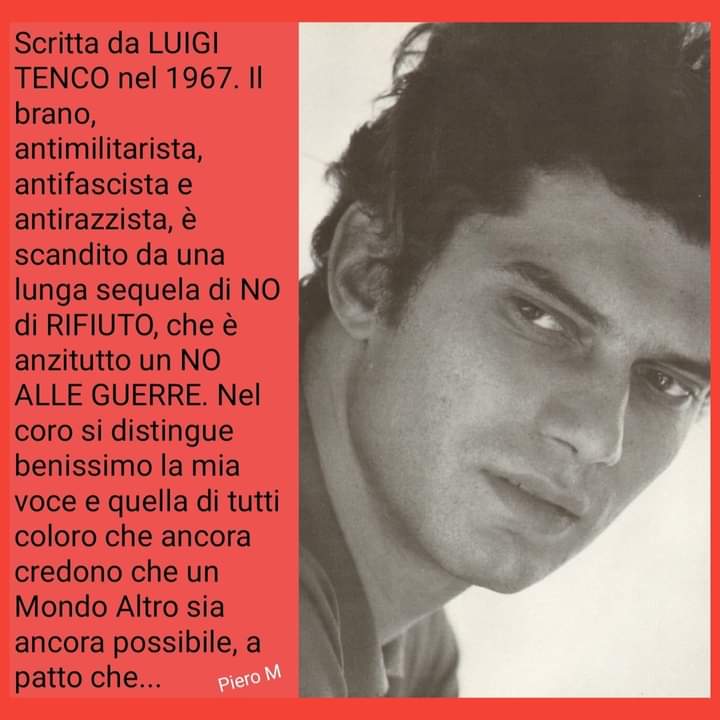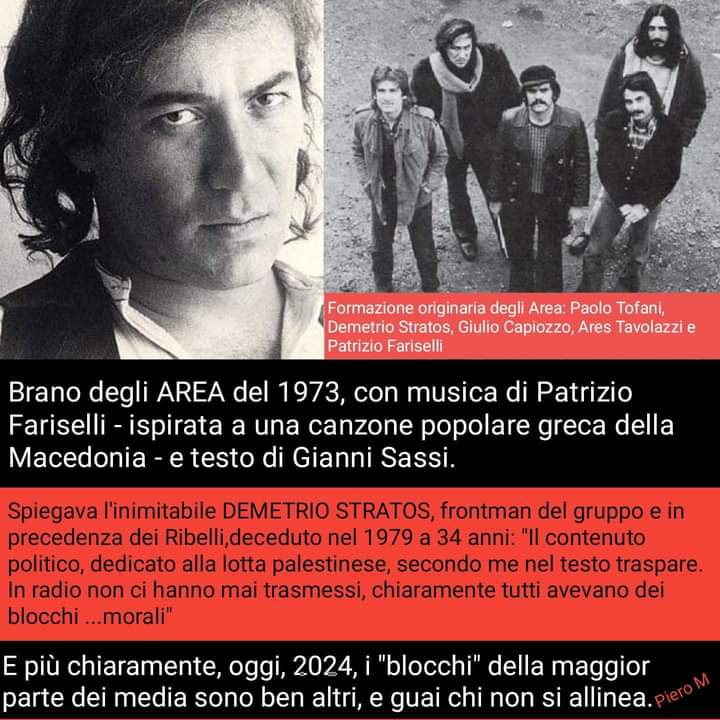Musica per la Pace
Siamo tutti solidali?
E Allora Dai
Questa è una canzone di protesta, che non protesta contro nessuno. Anzi, siamo tutti d’accordo.
Tu m’insegni quanto vale
incontrare un vero amico
Un amico è un tesoro
dice quel proverbio antico
Ed ognuno l’ha provato
quando solo si è trovato
la parola di un amico
ti può dar quel che non hai
E allora dai e allora dai
le cose giuste tu le sai
e allora dai e allora dai
dimmi perché tu non le fai
Il denaro non è tutto
è una frase che si dice
nella vita c’è ben altro
che può renderti felice
Te lo dicon tutti spesso
ricchi e poveri è lo stesso
il denaro non guarisce
e non da felicità
E allora dai …
Ogni uomo è uguale a un altro
quando viene dalle stelle
non importa la sua lingua
o il colore della pelle
Lo diceva anche il vangelo
già duemila anni fa
finalmente siam d’accordo
questa si che è civiltà
E allora dai …
Tu m’insegni che la guerra
oggi non si può più fare
che le bombe ed i cannoni
sono cose da evitare
Lo si scrive sui giornali
siamo tutti solidali
che la pace in tutto il mondo
salverà l’umanità
E allora dai …
https://youtu.be/mbXCsINdcrk?si=8p0MxuUIHMaRqoXS
“Cercare pace è l’unica vittoria”
IL MIO NOME È MAI PIÙ
Io non lo so chi c’ha ragione e chi no
se è una questione di etnia, di economia,
oppure solo pazzia: difficile saperlo.
Quello che so è che non è fantasia
e che nessuno c’ha ragione e così sia,
a pochi mesi ad un giro di boa
per voi così moderno.
C’era una volta la mia vita
c’era una volta la mia casa
c’era una volta e voglio che sia ancora.
E voglio il nome di chi si impegna
a fare i conti con la propria vergogna.
Dormite pure voi che avete ancora sogni, sogni, sogni
Il mio nome è mai più, mai più, mai più
Il mio nome è mai più, mai più, mai più
Il mio nome è mai più, mai più, mai più
Il mio nome è mai più…
Eccomi qua, seguivo gli ordini che ricevevo
c’è stato un tempo in cui io credevo
che arruolandomi in aviazione
avrei girato il mondo
e fatto bene alla mia gente
fatto qualcosa di importante.
In fondo a me, a me piaceva volare…
C’era una volta un aeroplano
un militare americano
c’era una volta il gioco di un bambino.
E voglio i nomi di chi ha mentito
di chi ha parlato di una guerra giusta
io non le lancio più le vostre sante bombe,
bombe, bombe, bombe, BOMBE!
Il mio nome è mai più….
Io dico si dico si può
sapere convivere è dura già, lo so.
Ma per questo il compromesso
è la strada del mio crescere.
E dico si al dialogo
perché la pace è l’unica vittoria
l’unico gesto in ogni senso
che dà un peso al nostro vivere,
vivere, vivere.
Io dico si dico si può
cercare pace è l’unica vittoria
l’unico gesto in ogni senso
che darà forza al nostro vivere.
Il mio nome è mai più…
La prima vittima delle guerre è l’infanzia
LA CROCIATA DEI BAMBINI
Partirono all’alba in crociata i bambini
Le facce gelate, chi li troverà?
Partirono in fila, sepolti di neve,
i soli scampati alle bombe ed ai soldati
Volevan fuggire dagli occhi la guerra,
volevan fuggirla per cielo e per terra
un piccolo capo, la pena nel cuore,
provava a guidarli e la strada
non sapeva trovare.
Una bambina di undici, ad una di quattro, come una mamma portava per mano ed un piccolo musico, col suo tamburo,
batteva sordo, al timore di farsi trovare
E poi c’era un cane, ma morto di fame
che per compassione nessuno ammazzò,
e si faceva scuola tutti alla pari
sillabavan maestri e scolari
C’era Fede e Speranza ma né pane, né carne non chiamate ladro chi deve rubare,
per dare alle bocche, di cosa mangiare
farina ci vuole e non solo bontà
Si persero in tondo, nel freddo di neve
nessuno più vivi li poté trovare,
soltanto il cielo, li vede vagare
nel cerchio dei senza meta dei senza patria
E cercano insieme una terra di pace
non come quella che hanno lasciato,
senza fuoco e rovina di Colosseo
ed immenso dietro di loro…diventa il corteo
Il cane nel bosco fu trovato una sera
al collo portava un cartello con scritto:
qualcuno ci aiuti, abbiam perso la strada
seguite il cane, e vi prego,non gli sparate
La scritta infantile, trovò un contadino
ma non la mano che la tracciò
un anno è passato, e nessuno è venuto
il cane soltanto è restato
a morire di fame
Il cane soltanto è restato
e si muore di fame
Errori nelle guerre? No, la guerra è tutto un Tragico Orrore
E SE CI DIRANNO
E se ci diranno
che per rifare il mondo
c’è un mucchio di gente
da mandare a fondo,
noi che abbiamo troppe volte
visto ammazzare
per poi sentire dire
che era un errore
noi risponderemo
noi risponderemo
NO NO NO NO NO !
E se ci diranno
che nel mondo la gente
o la pensa in un modo
o non vale niente
noi che non abbiam finito
ancora di contare
quelli che il fanatismo
ha fatto eliminare
noi risponderemo
noi risponderemo
NO NO NO NO NO !
E si ci diranno
che è un gran traditore
chi difende la gente
di un altro colore
noi che abbiamo visto
gente con la pelle chiara
fare cose di cui
ci dovremmo vergognare
noi risponderemo
noi risponderemo
NO NO NO NO NO !
E se ci diranno
che è un destino della terra
selezionare i migliori
attraverso la guerra
noi che ormai
sappiamo bene che i più forti
sono sempre stati
i primi a finir morti
noi risponderemo
noi risponderemo
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO ….
Le crociate americane? Unicamente ipocrisia e sete di potere
C O N T R O
CONTRO i fucili, carri armati e bombe
CONTRO le giunte militari, le tombe
CONTRO il cielo che ormai è pieno di tanti ordigni nucleari
CONTRO tutti i capi al potere che non sono ignari
CONTRO i massacri di Sabra e Shatila
CONTRO i folli martìri dell’Ira
CONTRO inique sanzioni, le crociate americane, per tutta la gente che soffre e che muore di fame
CONTRO chi tiene la gente col fuoco
CONTRO chi comanda ed ha in mano il gioco
CONTRO chi parla di fratellanza, amore e libertà e poi finanzia guerre e atrocità
CONTRO il razzismo sudafricano
CONTRO la destra del governo israeliano
CONTRO chi ha commesso stragi, pagato ancora non ha,per tutta la gente ormai stanca che vuole verità
CONTRO tutte le intolleranze
CONTRO chi soffoca le speranze
CONTRO antichi fondamentalismi, nuovi imperialismi
CONTRO la poca memoria della storia
CONTRO chi fa credere la guerra un dovere
CONTRO chi vuole dominio e potere
CONTRO le medaglie all’onore, alla santità
PER TUTTA LA GENTE CHE GRIDA
L I B E R T Á
Il terrorismo è anche un prodotto dell’interessata “esportazione di democrazia” e dell’arrogante prepotenza della superiorità delle armi
LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE (NERO)
Giocare col mondo facendolo a pezzi
Bambini che il sole ha ridotto già vecchi
Non è colpa mia se la tua realtà
mi costringe a fare guerra all’omertà
Forse un dì sapremo quello che vuol dire
affogar nel sangue con l’umanità
Gente colorata quasi tutta uguale
La mia rabbia legge sopra i quotidiani,
legge nella storia tutto il mio dolore
Canta la mia gente che non vuol morire
Quando guardi il mondo senza aver problemi cerca nelle cose l’essenzialità
Non è colpa mia se la tua realtà
mi costringe a fare guerra all’umanità
A tutti griderò di non partire, di non obbedire…
IL DISERTORE
In piena facoltà,
Egregio Presidente,
le scrivo la presente,
che spero leggerà.
La cartolina qui
mi dice terra terra
di andare a far la guerra
quest’altro lunedì.
Ma io non sono qui,
Egregio Presidente,
per ammazzar la gente
più o meno come me.
Io non ce l’ho con Lei,
sia detto per inciso,
ma sento che ho deciso
e che diserterò.
Ho avuto solo guai
da quando sono nato
e i figli che ho allevato
han pianto insieme a me.
Mia mamma e mio papà
ormai son sotto terra
e a loro della guerra
non gliene fregherà.
Quand’ero in prigionia
qualcuno m’ha rubato
mia moglie e il mio passato,
la mia migliore età.
Domani mi alzerò
e chiuderò la porta
sulla stagione morta
e mi incamminerò.
Vivrò di carità
sulle strade di Spagna,
di Francia e di Bretagna
e a tutti griderò
di non partire più
e di non obbedire
per andare a morire
per non importa chi.
Per cui se servirà
del sangue ad ogni costo,
andate a dare il vostro,
se vi divertirà.
E dica pure ai suoi,
se vengono a cercarmi,
che possono spararmi,
io armi non ne ho.
Cercarsi un nemico, unico obiettivo che dà motivazione all’esistenza di poveri esserini meschini
RE FEDERICO
C’era un grand’uomo sulla terra
chiamato Re Federico
che andava alla guerra,
cercando il nemico..
ma il nemico era andato a comprare un gelato e se n’era fregato del grand’uomo soldato
Nemico, nemico.. vien fora te aspeto!
Adeso non posso finisso u sorbetto
Vien fora, te aspeto coa spada e coa lanza
Adeso non posso che g’ho el mal de panza!
Nemico.. nemico? Non facciamo scherzi.. Nemico?
Come occupato? Chiama ancora.. nemico!
Usa il telefono speciale
Sono io, sono il presidente, sono il ministro della guerra, sono l’onnipotente!
Yo soy el caudillo, Yo soy el leader maximo, je suis le president, e I’m the governator, the terminator!
nemico.. bu!
nemico…un grand’uomo senza nemici è un uomo gran solo!
nemico..
pronto? nemico?
dai, non facciamo scherzi.. nemico, se ci sei spara un colpo!
dopo non imboscarti… odio, odio gli imboscati! Arrenditi dopo!
Impossibile… son qua, col mio cane e il cane del presidente..
Un grand’uomo senza nemici è un uomo gran solo.. vero Bobi?
Nemico? Vado a portar fuori il cane, quando torno voglio che tu sia qui..
Ti prego.. mia moglie si incazza!
Nemico.. soy el Re Federico!
sono tuo amico.. ma tu mi sei nemico!
nemico, per piacere.. un grand’uomo senza nemici è un uomo gran solo!
nemico?
…ti faccio vincere…
Nulla è più sacro della Pace
Il mio nome è Pace
Il mio nome è Pace
abito nel vento quello che ribalta il cielo
Sono angelo dagli occhi combattenti
che non può vincere solo
Sono il viaggio che non è finito sai,
su a nordest o giù in Oriente
Sono quello che non ha paura mai
di fissare gli occhi della gente
Io sono l’uomo il pazzo il Cristo cercami se vuoi
Sono il sogno che non muore mai
Io sono il canto libero salvami se puoi
Sono il sogno che non muore mai
Il mio nome è pace
sono la tua luce che risplende nella sera
Sono terra, acqua e sole sono inverno e primavera
Sono pane sono pura verità che sorride in faccia al male
Sono il viso di tua madre sono io le sue parole
Io sono l’uomo il pazzo il Cristo cercami se vuoi
Sono il sogno che non muore mai
Io sono il canto libero salvami se puoi
Sono il sogno che non muore mai
Sono lungo la tua strada, sono forza sono amore
chissà se mi puoi sentire, chissà se mi sai vedere
Chissà se mi puoi trovare
Il mio nome è pace sono un viaggiatore e sarà giusto partire
Sono in piedi a una stazione ma il mio viaggio non può mai finire
Sono l’alba giusta e chiara che si leva sulla via
Sono l’ostinato bene e ora cerco casa tua
Io sono l’uomo il pazzo il Cristo cercami se vuoi
Sono il sogno che non muore mai
Io sono canto libero salvami se puoi
Sono il sogno che non muore mai
Io sono il canto libero salvami se puoi
Sono il sogno che non muore mai
Io sono il canto libero salvami se puoi
Sono il sogno che non muore mai.