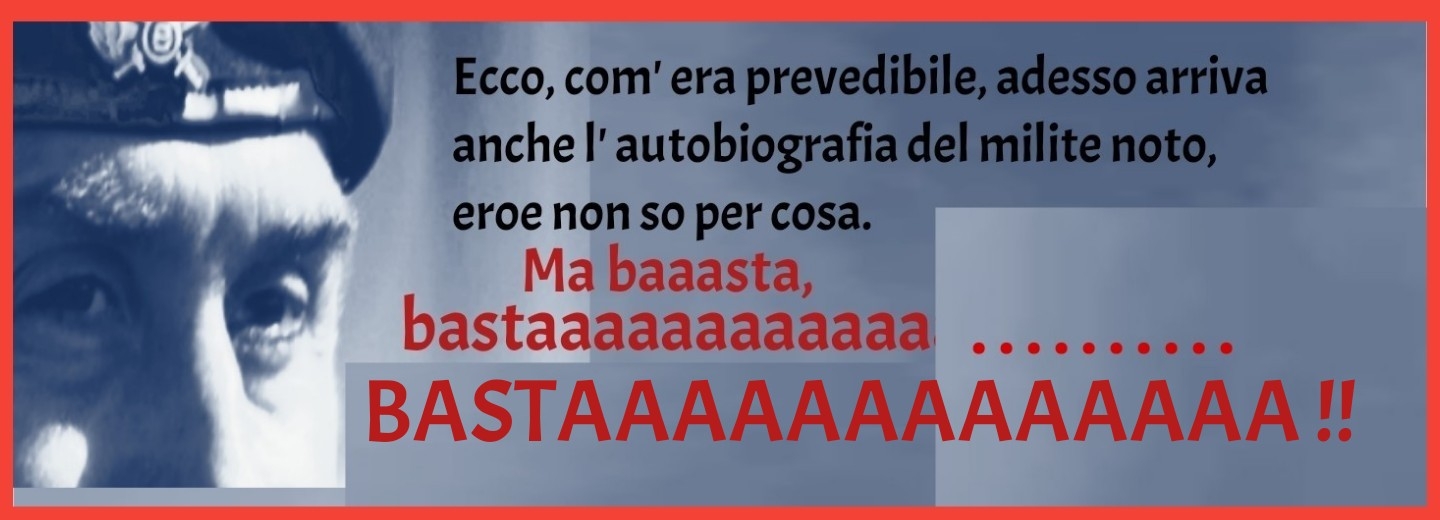I “MAI PIÙ” SEMPRE PIÙ RELATIVI
Di Pier Giorgio Ardeni
In altre occasioni, per altre devastanti guerre, intellettuali, giornalisti e politici si erano mobilitati, denunciando il diritto dei popoli a esistere e rifiutando sempre l’idea che un conflitto possa risolversi con l’eliminazione fisica, lo sradicamento, l’allontanamento. In questo caso, invece, mentre ci sono state manifestazioni di piazza, il mondo della cultura e della politica è rimasto silente.
Il nuovo anno è arrivato e il mondo procede lungo i binari già presi. Sono binari morti, per lo più, vicoli ciechi dai quali non c’è uscita, se non tornando indietro. A provare a guardarlo con distacco, se mai si possa, si prova incredulità se non disdegno. Certo, come sempre c’è una superficie al di sotto della quale, si pensa, c’è il ribollìo delle passioni, delle lotte, l’eterna rabbia dei maltrattati contro gli aguzzini, degli sfruttati contro gli sfruttatori, degli infelici molti contro i felici pochi. Ma la profondità, come dice il poeta, va cercata in superficie. E noi vediamo un mondo di conflitti, di morte, di predominio, dove la violenza si accompagna all’assuefazione, una violenza che ci pare ogni volta più brutale.
Come diceva un altro poeta «la storia insegna che dalla storia non si impara nulla». Già, non abbiamo imparato nulla. Ma ciò che è più grave è che la nostra cultura non ha imparato nulla e mai come in questo tempo sta mostrando quanto sia regredita.
In queste settimane – grazie anche all’iniziativa del governo sudafricano che ha portato Israele davanti alla corte di giustizia dell’Aia – si è tornato a parlare di “genocidio”, un termine macabro che indica l’eliminazione sistematica di una popolazione. Un termine moderno che è stato usato per indicare ciò che fu fatto ai nativi americani, agli aborigeni australiani, ai “bushmen” della Namibia, agli armeni, agli ebrei in Europa (in passato, per quanto meno evoluti fossimo, non eravamo mai stati capaci di questo).
Certo, è anche questione di “modalità”: l’eliminazione di centinaia di migliaia di persone, come accadde sulle trincee europee durante la Prima guerra mondiale, a Dresda, a Hiroshima e Nagasaki, non riceve lo stesso appellativo solo perché fu più circoscritta, ma non meno brutale.
Tutti casi che trovarono “giustificazione”, al tempo. Ma oggi, in reazione ad un attacco terroristico di ampia portata – mai attacco palestinese aveva causato tante vittime – la reazione del governo di Israele è stata di quelle commisurabili a ciò che fu fatto a Dresda o a Hiroshima.
Oggi come allora, la domanda è la stessa: era davvero necessario?
Quale logica militare e quindi politica può giustificare la distruzione e la morte di decine di migliaia di civili indifesi?
Quasi più che la stessa questione – se sia o meno “genocidio” – ciò che appare agghiacciante è l’evidente tentativo di sradicare la popolazione di Gaza dal suo insediamento, eliminandola. L’aggravante, tra l’altro, è che quella popolazione, nella Striscia – «un campo di concentramento a cielo aperto» era stato chiamato prima dell’invasione israeliana – vive in condizioni relegate di oppressione da decenni.
Più di cento giorni sono trascorsi da quell’attacco di Hamas e da quando Israele ha iniziato a radere al suolo le città della Striscia. I media e il mondo dell’informazione dominante ne hanno parlato, certo, raccontando la guerra dalla parte degli assalitori, che cercavano la giusta vendetta. Non l’hanno fatto «dalla parte delle vittime», in fondo complici per aver covato l’odio e albergato gli assassini terroristi.
Partiti, governi e organizzazioni sovranazionali hanno reagito giustificando l’operato di Israele perché «attaccare Israele è antisemitismo», quindi la sua reazione è sempre legittima, quale che sia. Mai come in questa occasione Israele è stato fatto oggetto di simpatia in nome delle comuni radici, della comune «civiltà occidentale».
Una civiltà che, invece, è stata spazzata via. Silenti, se non compiacenti, sono stati gli intellettuali e il mondo della cultura, nella sua grande maggioranza. Il conformismo ha prevalso sull’onestà intellettuale, la cecità sulla verità. Nessun coraggio, nessuna indipendenza: la soluzione genocidaria è stata accettata in nome di più supremi valori. Nessuno si è premurato di spiegare perché a Israele sia concesso di incarcerare migliaia di persone, invadere e distruggere migliaia di abitazioni, costringere alla fuga milioni di palestinesi. E tutti hanno affermato che non si tratta di genocidio e, quindi, che tutto quanto sta accadendo rientra nel novero di ciò che è accettabile (come Dresda, come Hiroshima).
Dopo l’ultimo grande genocidio, quello ebreo compiuto in Europa dai nazisti non solo tedeschi, si era detto «mai più». Ma, ora è chiaro, era un «mai più» relativo. Ci sono e ci saranno sempre degli “altri” ai quali non si applica.
Il silenzio dei media e della stampa, degli intellettuali e del mondo della cultura su quanto accade a Gaza sull’estensione e l’efferatezza del massacro di civili mostrano quanto la nostra “civiltà” sia arrivata al capolinea.
Il conformismo, generato dal sonno della ragione, e l’assenza di indignazione sono il segno di quella fine. Un tempo, si diceva, i diritti dell’uomo, dell’umanità, sono valori universali. In nome della ragione – non siamo più “barbari”, siamo “civilizzati” – non saranno più accettati lo sterminio di massa e l’eliminazione fisica di persone e popoli. Ma era anche questa un’idea “universale” relativa, evidentemente, che riguardava una parte del mondo e una concezione del mondo, la nostra.
In altre occasioni, per altre devastanti guerre, intellettuali, giornalisti e politici si erano mobilitati, denunciando il diritto dei popoli a esistere e rifiutando sempre l’idea che un conflitto possa risolversi con l’eliminazione fisica, lo sradicamento, l’allontanamento.
In questo caso, invece, se forte è stata la mobilitazione di migliaia di persone che sono scese in strada per manifestare, più silente è stata la reazione del mondo della cultura e della politica. Complice, forse, quel senso di impotenza che nasce dal fatto che le parole, oggi, finiscono facilmente nel tritacarne dei media, amplificato dai “social”, che omogenizza pensieri e opinioni nella maionese che regolarmente “impazzisce”, contrapponendo drammaticamente chi è “pro” da chi è “contro”. Rendendoci sempre più incapaci di distinguere e prendere parte con coscienza. Ma anche questo, a pensarci, è un frutto del «capitalismo della conoscenza» che, così facendo, è in grado di manipolare le coscienze delle masse, svuotandole della loro carica critica.
Perché, vien da chiedersi, non vi è stata a sinistra – in Italia, in Europa – una reazione forte contro l’evidente operazione di annichilimento di una popolazione oggi in atto a Gaza?
Il filo-semitismo tedesco, proporzionale solo alla colpa accumulata per un antisemitismo atavico, obnubila la Germania. L’Europa, dall’Atlantico agli Urali, ne è succube, nel coacervo irrisolto delle sue radici cristiane. Ma le sinistre, dopo due secoli, dovevano avere assimilato il principio che non c’è emancipazione senza coesistenza di popoli e culture. La reazione della cultura e della politica dei Paesi occidentali, invece, segnano il fallimento della nostra civiltà, che non ha mai dismesso il principio della forza – che ha segnato il colonialismo, l’imperialismo – per far valere il diritto alla propria esistenza, che si afferma solo negando l’altro.
Un fallimento culturale con il quale dobbiamo fare i conti. Abiurando, rifiutando, distaccandoci. La ragione illuminista – che avevamo coltivato con senso di superiorità – ha generato il mostro della sua negazione, in una regressione senza apparente fine.
Così, nel vuoto, brancoliamo abbracciando le centinaia di migliaia di giovani delle comunità ebraiche e musulmane, dei giovani “cittadini del mondo” che di quella cultura si sono nutriti e che guardano avanti. Non lasciamoci ammorbare, reagiamo come i tanti di noi, ancora allerta, ci chiedono. Siamo ancora in grado di discernere. Oltre l’impotenza, possiamo essere in grado di alzare la voce e far sentire parole di verità.