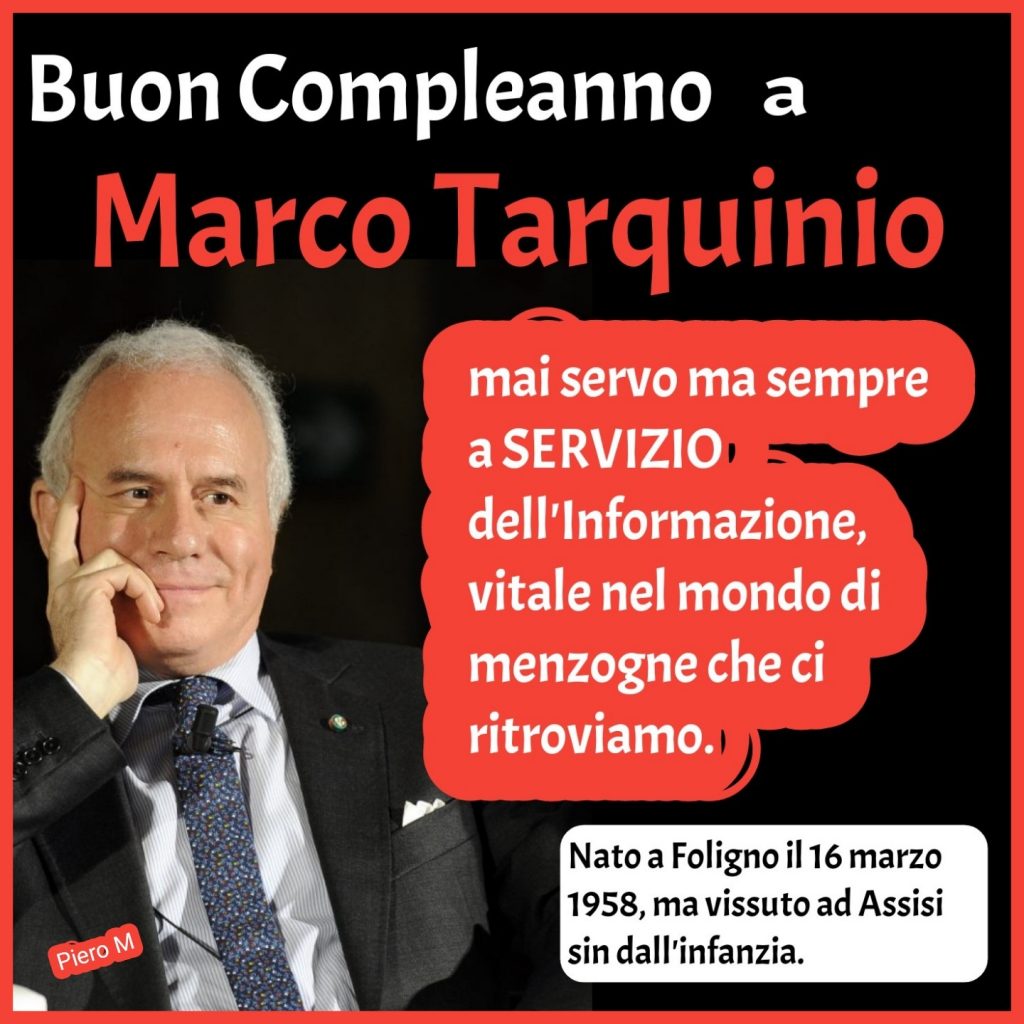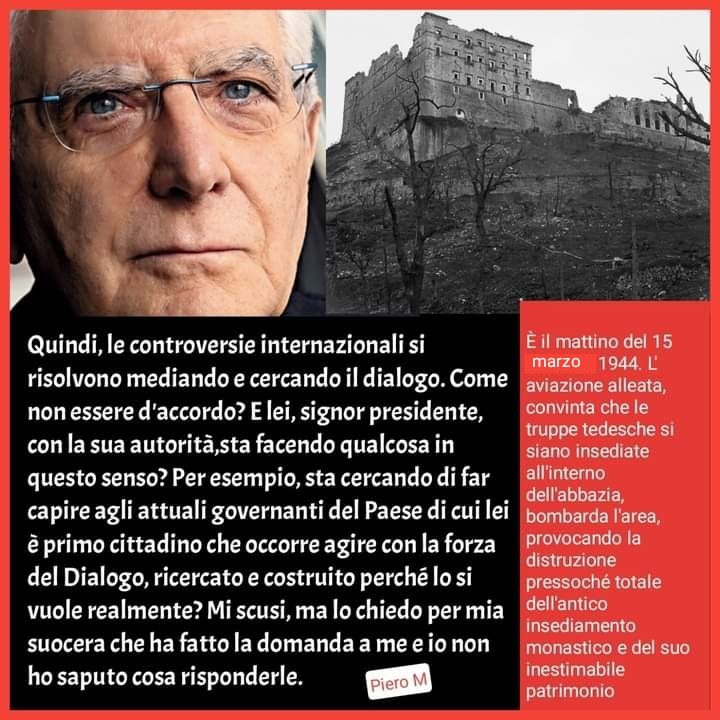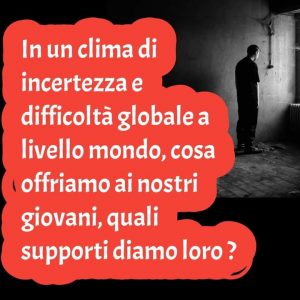Aggiornamento sugli sbarchi dei migranti
di Annalisa Camilli (Internazionale)
Dal 14 al 16 marzo sono ripresi sbarchi di numerose persone a Lampedusa, la piccola isola del Mediterraneo più vicina all’Africa che alla Sicilia. In tre giorni sono arrivate circa 1.500 migranti, poi il 17 marzo il tempo è peggiorato e gli arrivi si sono fermati. Il 16 marzo la guardia costiera ha soccorso dodici imbarcazioni, mentre un’altra è arrivata in maniera autonoma fino alla spiaggia. Una barca con circa duecento persone è arrivata a Pantelleria.
Le imbarcazioni arrivate a Lampedusa – che sono soprattutto di legno – sono partite dalla Libia e dalla Tunisia: da Zuara e in misura minore da Sabratha (in Libia), e da Sfax e Kerkenna (in Tunisia). Dal 1 gennaio al 15 marzo 2024, secondo i dati diffusi dal ministero dell’interno, sarebbero arrivati in Italia in maniera irregolare 6.560 persone, meno della metà di quelle arrivate nello stesso periodo dell’anno scorso. Il governo sostiene che questo sia il risultato degli accordi stipulati con la Tunisia per fermare le partenze, ma è ancora troppo presto per dire se quest’ipotesi sia fondata o se si tratti semplicemente di una conseguenza delle condizioni del meteo e del mare, peggiori rispetto allo stesso periodo del 2023.
“Ci sono stati molti giorni di maltempo e appena la situazione è tornata calma, numerose imbarcazioni sono partite sia dalla Libia sia dalla Tunisia”, conferma Francesca Saccomandi, operatrice di Mediterranean Hope e il Forum Lampedusa Solidale, attiva nell’accoglienza dei profughi allo sbarco al Molo Favarolo di Lampedusa. “Non vediamo più barche di ferro, l’anno scorso molto usate dai migranti che arrivavano dalla Tunisia. Sappiamo che le autorità tunisine ne hanno ostacolato la costruzione e che hanno fatto delle deportazioni sistematiche da Sfax al deserto per ridurre il numero di partenze e venire incontro alle richieste dei paesi europei”, racconta Saccomandi. L’operatrice sostiene che tra i migranti ci siano molti subsahariani, anche tra quelli partiti dalla Tunisia, e che tra loro ci siano molte donne e molti bambini o minori non accompagnati.
“Le procedure allo sbarco si sono velocizzate, rispetto a qualche mese fa. Ma le condizioni di accoglienza sono ancora pessime”, spiega. “Ci siamo solo noi e qualche volta i volontari della Croce rossa a distribuire acqua e snack, i servizi igienici al molo sono fatiscenti e manca un servizio per dare notizie alle famiglie che sono rimaste a casa. Inoltre, i problemi al centro di prima accoglienza (hotspot) sono sempre gli stessi da anni. Ci sono pochi posti e basta che gli arrivi aumentino perché la situazione vada fuori controllo. Inoltre le persone sono trattenute e private della libertà personale per un periodo più lungo di quello che sarebbe consentito dalla legge, le persone sono rinchiuse nell’hotspot anche oltre il tempo necessario all’identificazione”, spiega Saccomandi.
Intanto al centro di prima accoglienza (hotspot) di Lampedusa con gli ultimi arrivi si è raggiunta subita la massima capienza. Il 17 marzo duecento migranti sono stati trasferiti con un traghetto a Porto Empedocle e nel centro di accoglienza di Contrada Imbriacola sono rimaste 439 persone. Altri due migranti hanno lasciato l’isola con l’elicottero per ragioni sanitarie e sono stati trasferiti all’ospedale di Palermo. Uno è stato spostato per crisi epilettiche, mentre l’altro per una malattia neurodegenerativa.
Lungo la rotta del Mediterraneo centrale sono attive intanto tre navi umanitarie: la Geo Barents di Medici senza frontiere, la Life Support di Emergency e la Ocean Viking di Sos Méditerranée. Altre tre sono state sottoposte a fermo amministrativo la scorsa settimana. La Geo Barents ha soccorso un totale di 249 persone in tre diverse operazioni e ora è diretta verso Marina di Carrara dove arriverà il 20 marzo. In un primo soccorso sono state salvate 28 persone a bordo di un’imbarcazione di vetroresina, nel secondo 146 persone che viaggiavano su una barca di legno, mentre nel terzo, avvenuto di notte, sono state messe in salvo 75 persone.
Nel secondo episodio l’imbarcazione umanitaria è stata attaccata dalla cosiddetta guardia costiera libica, come era già avvenuto la settimana scorsa alla nave Humanity 1. Fulvia Conte, responsabile di Medici senza frontiere a bordo della nave, ha commentato: “Le operazioni di questi giorni sono state particolarmente difficili, abbiamo provato a soccorrere un barchino con più di cento persone a 40 miglia a sud di Lampedusa. Ma abbiamo assistito a un’intercettazione da parte della guardia costiera libica in acque internazionali”. In seguito in un altro salvataggio la nave di Msf è stata minacciata e attaccata dai libici. “La Geo Barents era in comunicazione continua con tutte le autorità competenti”, spiega Conte. Anche nel terzo soccorso ci sono stati momenti drammatici: “Il barchino si è ribaltato e circa quaranta persone sono finite in mare, ma per fortuna sono state soccorse”.
Il 16 marzo la Life Support di Emergency ha aiutato un’imbarcazione in difficoltà nella zona Sar maltese con a bordo 71 persone. “A causa del buio abbiamo impiegato circa tre ore per individuarla e a raggiungerla”, ha raccontato Domenico Pugliese, comandante della nave. I naufraghi erano partiti dalla città libica di Tajura, a una dozzina di chilometri da Tripoli, alle 22 del 15 marzo. L’imbarcazione di legno su cui viaggiavano aveva il motore guasto ed era inclinata da un lato. I naufraghi sono originari del Bangladesh, dell’Egitto e dell’Eritrea e tra loro ci sono una donna e tre minori, di cui due non accompagnati, ha dichiarato l’organizzazione.
Il soccorso più drammatico degli ultimi giorni ha riguardato la Ocean Vicking dell’ong Sos Méditerranée il 13 marzo in aiuto di un’imbarcazione in difficoltà, che era in mare da più di una settimana. “I sopravvissuti hanno riferito che almeno sessanta persone sono morte durante la traversata, tra cui alcune donne e almeno un bambino”, ha affermato il 14 marzo l’ong, che ha soccorso 224 persone in tre diverse operazioni.L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) aveva reagito esprimendo forte preoccupazione. Secondo Sos Méditerranée, l’imbarcazione è partita l’8 marzo da Zawiya. Tre giorni dopo si è rotto il motore, lasciando i migranti alla deriva, senza cibo né acqua.
Dopo un primo salvataggio di 25 persone, tra il 13 e il 14 marzo la Ocean Viking ha salvato prima 113 e poi 88 migranti in altre due operazioni di soccorso.
Le autorità italiane le hanno assegnato alla nave il porto di sbarco di Ancona. Dato che la città “dista 1.450 chilometri dalla posizione attuale della Ocean Viking, abbiamo chiesto alle autorità marittime italiane di concedere un porto sicuro più vicino”, ha scritto l’ong in un comunicato. Ma le autorità hanno concesso all’organizzazione di attraccare a Catania solo per fare scendere i casi più gravi, 23 persone bisognose di assistenza medica, e poi hanno imposto all’organizzazione di riprendere la navigazione verso Ancona, sulla costa adriatica.
Il ministro dell’interno italiano Matteo Piantedosi, parlando della situazione nel Mediterraneo, ha ribadito che questi episodi sarebbero la prova che “l’immigrazione irregolare va fermata alla partenza”. Il ministro ha comunque rivendicato una contrazione negli arrivi per il sesto mese consecutivo: “Segno che qualcosa sta funzionando”. Il 17 marzo la presidente del consiglio italiana Giorgia Meloni, insieme con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, è andata in Egitto per siglare diversi accordi bilaterali e sostenere un accordo da 7,4 miliardi di euro da parte dell’Unione europea con l’Egitto per la cooperazione economica e in materia migratoria.
Ma per i critici del governo Meloni e le organizzazioni che si occupano dei diritti umani gli arrivi di questi giorni e il caos nei soccorsi nel Mediterraneo mostrano che i numerosi accordi che il governo ha fatto con governi instabili o autoritari come quello con la Libia e la Tunisia nel 2023 hanno effetti limitati sul numero degli arrivi, ma hanno un costo enorme in termini di violazioni dei diritti umani nei paesi di transito e lungo le rotte.