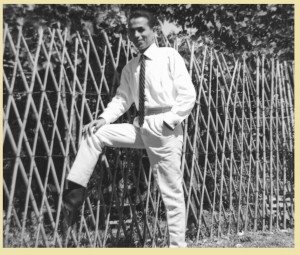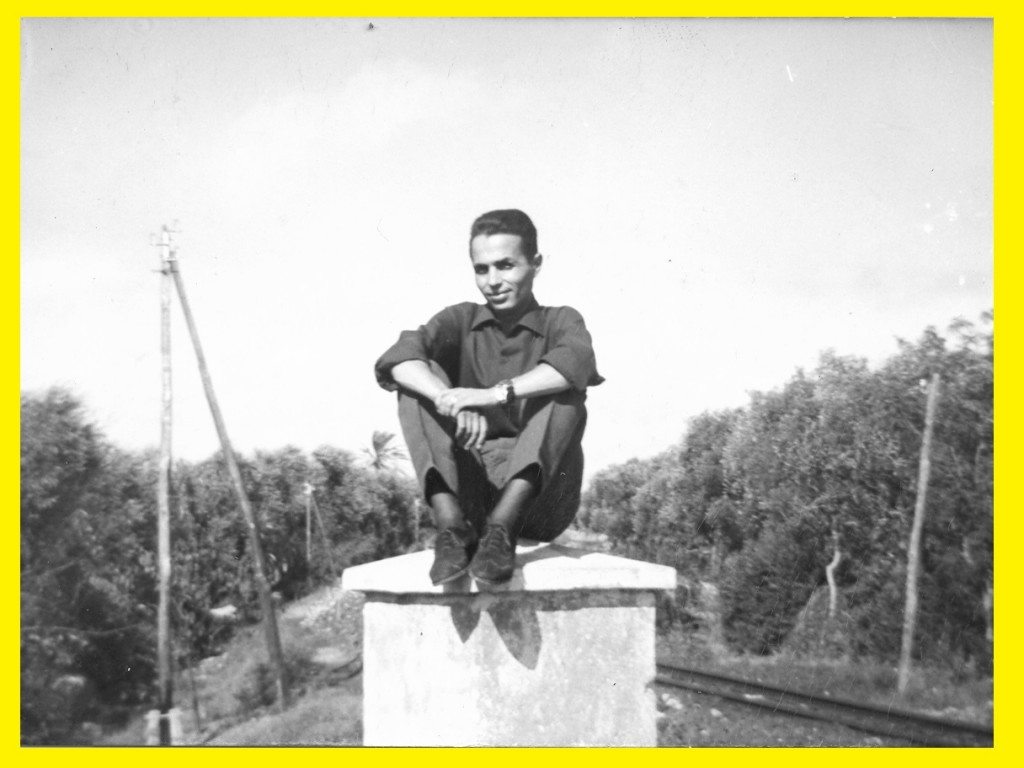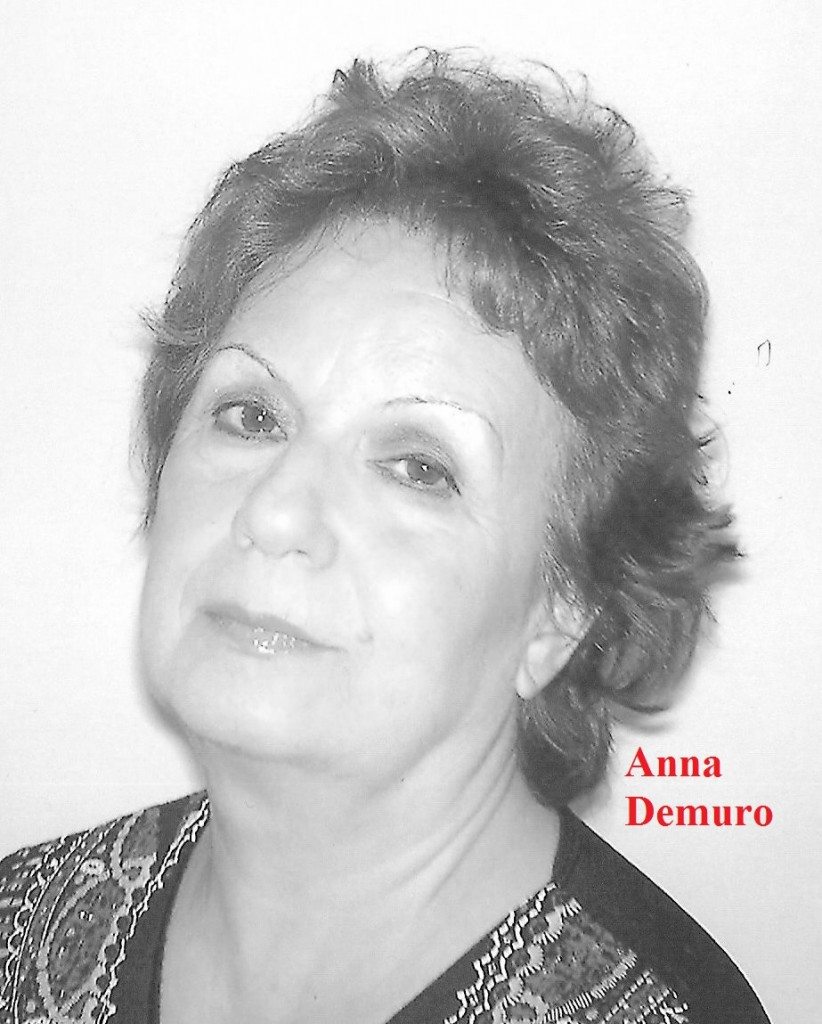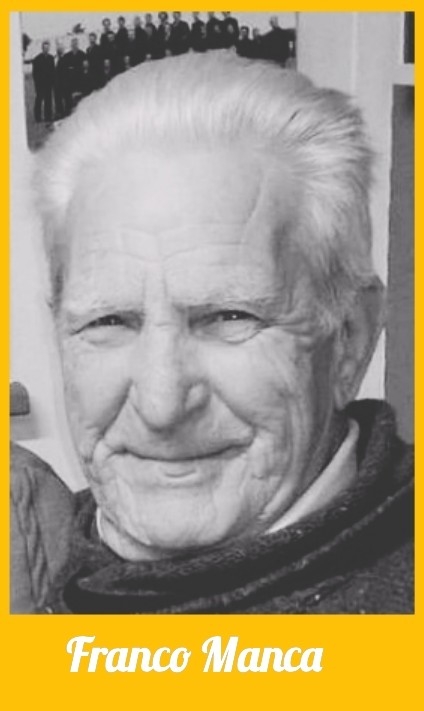Premessa
di Piero Murineddu
È da qualche tempo che Anna Demuro (*) voleva pubblicare il suo libro “Un Quadrato di Sole” e assolutamente, a presentare il suo lavoro doveva essere Enrico Porqueddu, giornalista che per trent’anni ha diretto il quindicinale “Il Sassarese“, dove Anna stessa teneva una rubrica di critica artistica e letteraria. Purtroppo gli eventi della vita sfuggono spesso alla volontà umana e ad un certo punto una malattia costringe l’acuto giornalista a porre fine alla sua attività, portata avanti anche con un’emittente locale. Nell’ agosto del 2019, a 81 anni, Porqueddu verrà poi a mancare. L’inaspettato male dell’amico, blocca Anna nell’intenzione di pubblicare il suo lavoro. Ho avuto il privilegio di leggerne le sofferte pagine, una sorta di diario quotidiano che descrive le giornate impegnate da Anna ad accudire il coniuge, il geometra Nino Canu. L’autrice Immagina un colloquio a due che nella realtà purtroppo non può esserci, dal momento che una malattia irreversibile ha costretto Nino a letto, chiudendolo in un mondo tutto suo.
Ringrazio Anna per avermi autorizzato a pubblicare in questo blog il suo volume.
(*) Anna Demuro è nata a Calangianus il 26 settembre del 1939 ma da sempre vive e opera a Sorso, sua città di adozione. Insegnante e pittrice. Dal 1975 al 2010 ha scritto oltre venti saggi, tra cui “Il terrorismo negli anni ‘80”, “Il bambino nel mondo”, “Droga, ultimo passaporto”, “Sardegna come”. “La fatica di crescere”, fi nito di scrivere nel 1997, è uno spaccato di quella scuola creativa a lei tanto cara, dove ogni bambino deve sentirsi protagonista. Del 1998 è “Dal silenzio” (autobiografico); del 2001 “Oltre l’inferno” (poema in tredici canti); del 2003 “Quore di cane” (racconto). “Alle radici della vita. Catalina di Limbara”, romanzo pubblicato nel 2009, celebra il riscatto socio-culturale della protagonista e denuncia il fallimento della società che cancella il diritto all’istruzione. La produzione dell’autrice comprende “Stracci” (raccolta di versi), “Pensieri e parole” (raccolta di massime), qualche novella, bozzetti e rifl essioni. Anna Demuro ha collaborato per lungo tempo col periodico “Il Sassarese”, con contributi di tipo culturale e artistico fra cui: “Quell’arte, l’altra”, “La risposta dell’Arte” e “Suprematismo”. Sullo stesso periodico ha curato la rubrica “Se di poesia”.

Il Desiderio che il viaggio continui
di Gavino Puggioni
Scorrendo le pagine di questo libro, con le date che ne segnano la vita, mi è parso subito un diario, anche se scritto a bordo di un’anima incorniciata d’amore.
Leggendo, però, ho fatto “quadrato” su ciascuna quasi-lettera, continuo colloquio di un cuore di donna che vuole far sentire i propri battiti a quello del suo amato marito, che è, ma non è.
È lì, a casa, in ogni suo angolo, in ogni finestra, che la guarda; gli occhi, le labbra, le mani che parlano, in un silenzio rumoroso dove la vita si fa trascinare in miriadi di stelle luminose, di ricordi, di momenti felici, di albe e di tramonti, vissuti e disegnati nella mente, di stelle nebulose dalle cui braccia, piano piano, si sono allungati quei fili del destino che li ha ammucchiati malamente, nel greto di una vita che voleva ancora essere vissuta.
Scrive, Anna, srotolando pensieri di bambina e di adolescente, vuole che Nino la ascolti, che ne senta l’essenza, perché lei desidera che quel viaggio possa continuare.
Ogni parola, intimamente sofferta, di queste lettere, trasuda sofferenza, trasuda sacrificio di un amore che va oltre l’infinito, Leopardi permettendo.Non cerca aiuti altri, questa donna, ma chiede a sè stessa, tutti i giorni, di essere presente, come sempre è stata, col cuore, con gli sguardi, con le mani che possano accarezzare quel volto amato, per trasmettere a lui segni di vita, di coraggio, di affetto, in un tutt’uno di sorrisi, di lacrime che andranno ad esaurirsi, alla fine, nel sonno di un corpo che vibra per conto proprio.
Non si può giudicare l’amore che esiste fra una donna e un uomo, ma Anna, al contrario, sembra che ci inviti a farlo, quasi ci incita a frugare in mezzo a tutte quelle sue frasi-domande, per le quali, lei, non ha avuto alcuna risposta, mentre la Vita scivolava lentamente verso quell’ Abisso, fatto di scale solo a scendere.
Il dolore, a lungo sopportato, non ha voluto regalarle alcunchè di leggero; solo buio, e in questo, Anna, ha saputo e voluto dedicare a sè e a chi la legge, la luce di queste sue emozioni vissute accanto a chi l’ha amata, senza SE e senza MA.
Cito questa frase che mi è rimasta impressa, di loro due, dopo aver assistito ad un concerto.
” Il miracolo del suono nasce sulla carta per sciogliere il mistero in vibrazione e canto”
Grazie Anna

Quel gioco delle parti
di Enrico Porqueddu
Un soliloquio lungo, sofferto a volte beffardo, un parlarsi con estrema chiarezza tentando di esorcizzare la drammaticità dei giorni, delle notti nel tentativo di “provocare” una qualche reazione da parte di lui, quel marito infermo e sofferente da anni, adagiato su un letto ch’è diventato il suo “covo” di inconsapevolezza. Con quegli occhi che non sanno dove guardare, nemmeno sul proprio stato perché, si presume, non ha più alcun riferimento con la realtà. Anna Demuro ha rinchiuso me in un ammirevole ma allo stesso tempo doloroso cammino di ostacoli che non sono riuscito a superare per la forte emozione nel leggere “Un quadrato di sole” che disegna quell’uomo ma, soprattutto, lei, quella donna ricca di sensibilità e di reale ma non nascosta tremenda visione di impotenza. Lei scrive, parla convinta che Nino possa darle una risposta ai mille interrogativi che pone, si pone, gli pone. Ma lui è lì, ora con gli occhi socchiusi ora con gli occhi aperti e qualche accenno ad un sorrisetto che solo per qualche attimo gli illumina il volto. Quando andando avanti nella lettura mi domandavo dove Anna volesse portare il suo soliloquio e chi leggeva quelle parole mi sono reso conto che si trattava di una intimistica indagine personale per mettere a prova la sua resistenza di donna, sposa e madre. Tre entità che ne conformano la personalità, la cultura, l’umanità di un essere all’apparenza fragile ma di certo più forte di quanto le avversità delle vita e la immobile presenza di Nino ne circoscrivono il carattere. Fra i due chi è il protagonista del dramma? Può essere Anna visto che è lei l’artefice di simili pensieri, riflessioni, appunti e provocazioni in un tremendo copione che riga dopo riga attrae il lettore. O è Nino, il protagonista? Nel gioco delle parti si accavallano immagini ora sbiadite, ora messe a fuoco solo dai turbamenti che scuotono chi continua nella lettura. Come preso da un inatteso groppo alla gola metto da parte il racconto e mi sistemo sul terrazzino e allora vedo, fra alberi secolari di un giardino piccoli quadratini di sole, scintille che colpiscono gli occhi e scendono nel cuore fino a risalire verso gli occhi. Spunta qualche lacrima, il cuore si stringe e tento di contenere la commozione. Perché, mi domando, proprio a me? Potevo leggere qualche pagina e poi gettarmi in qualche altra lettura È stata Anna a mettermi il guinzaglio e portarmi fino all’ultima parola scritta. Che fare? Resto in silenzio e parlo a me stesso indirizzando pensieri ad Anna e al suo Nino. Ma perché esiste l’amicizia, l’affetto, il rispetto fra gli esseri viventi? La risposta me l’ha fornita la stessa Anna, vera testimone di una realtà che colpisce anche quando tenti di scansarla. Mentre tutto questo invade la mia mente vedo Nino in quel giorno d’aprile quando, accostandomi al suo letto di dolore inconsapevole alla domanda di Anna, chi è quest’uomo lui rispose pronunciando il mio nome. Allora Nino c’è, è con noi? Anna già sapeva la risposta. Nino è in quel “Quadrato di sole” e ci illumina tutti.
28 maggio 2012
Il particolarissimo” Quadrato di sole” di Anna
di Piero Murineddu
“Un Quadrato di Sole” è il titolo del libro che Anna Demuro ha scritto nel periodo marzo – agosto 2010, e coloro che si avventureranno nella sua lettura, non tarderanno a capirne il motivo. Alla grafica ha partecipato la figlia dell’artista, Silvia Canu. L’ottima prefazione di Enrico Porqueddu credo ci abbia introdotto bene all’atmosfera che pervade il volume ancora inedito di questa ottima artista a trecentosessanta gradi, originaria di Calanganus e arrivata da giovane al seguito del padre che lavorava presso la stanzioncina ferroviaria di “Predda Niedda“. E’ proprio durante i viaggi in treno verso la vicina città che nasce l’amore tra Anna e Nino Canu, l’una studentessa delle Magistrali, l’altro all’Istituto dei Geometri. A differenza di questi nostri tempi “magri” e bui, allora non era difficile lo sbocco lavorativo per chi raggiungeva il Diploma di Maturità, per cui, stabilitisi a Sorso dopo undici anni di fidanzamento e una volta sposati, Anna insegna negli stazzi e nei paesini di La Tozza,Concatile, Bulzi, Martis, Perfugas, Badesi e infine a Sorso.
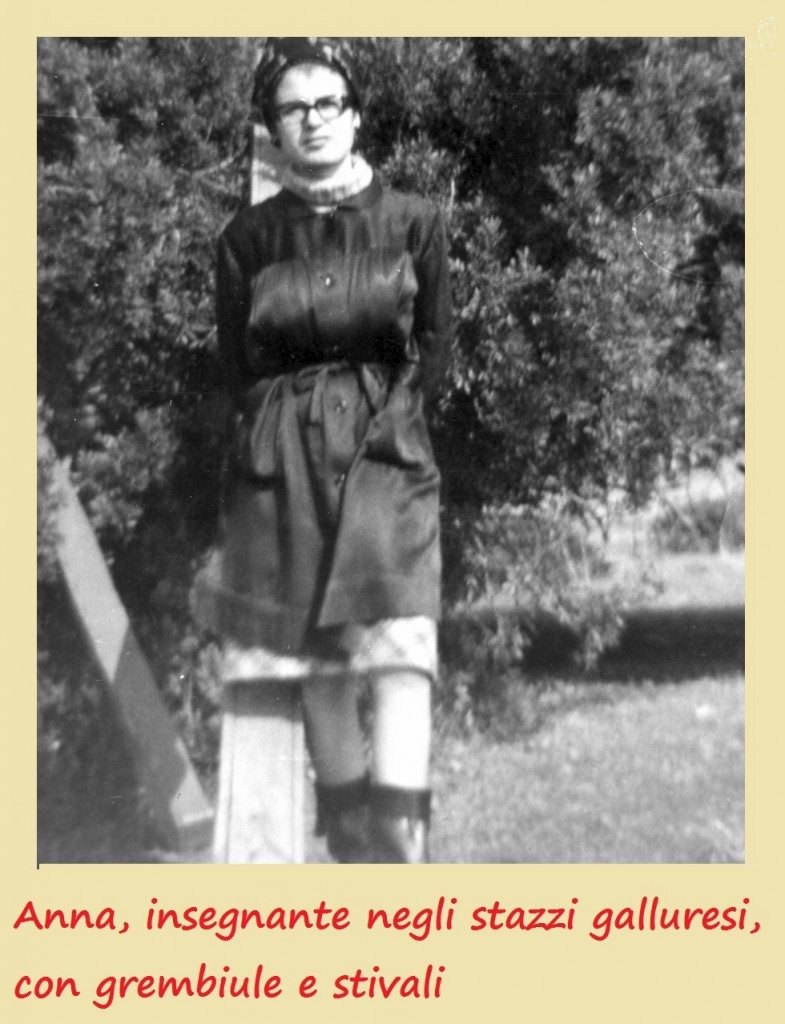
Nino non ha difficoltà ad avviare l’attività di geometra. Personalmente ho un vago ricordo di quando, avendo dovuto interrompere gli studi per forza maggiore, partecipavo ad un cantiere-scuola comunale, ed era proprio lui che ci seguiva e ci dava le indicazioni. Come capita a molti, tutto bene per lui, fin quando non arriva la malattia che, progressivamente e inesorabilmente, lo inchioda a letto, e la moglie viene assorbita completamente ad occuparsi di lui, impedendole concretamente di svolgere una vita normale e di portare avanti la pittura e la realizzazione d’installazioni artistiche.
Nel dicembre del 2016, ottantenne, la morte libera Nino dai sofferti limiti che da troppo tempo gli impedivano di manifestare appieno la sua dignità di persona.
Da allora, sembrerebbe che in Anna, oltre che l’amore della sua vita, sia venuta a mancare anche la vena creativa. In uno degli ultimi incontri mi diceva che saltuariamente riesce a scrivere i suoi pensieri con la penna, facendone scaturire un’ottima scrittura, come andrete da qui in avanti a leggere.

Un Quadrato di Sole
di Anna Demuro
A Nino
PARTE PRIMA
8 marzo 2010 – Gli ulivi che custodivano la nostra intimità
Gli ulivi che custodivano la nostra intimità ci sono ancora là, sulla collina, col maestoso ponte dalle superbe arcate, che domina la valle di profumi e case delle fate. Nulla è cambiato se non il bianco sporco della cantoniera e il recinto in canne dell’orto dietro casa, che non esiste più. La cisterna sotto il fi co è come allora, ma non ci sono i fi ori di una volta né siepi a guardia dei sussurri e delle confidenze che nascevano insieme con l’amore. Dal treno in corsa vedo il viottolo gibboso, la bordura polverosa dei rovi e delle more e l’ombroso viale che porta ancora alla chiesetta antica. E vedo i nostri sogni, le pagine ancora da studiare: filosofia, chimica e storia d’altri tempi e i tuoi occhi buoni che si perdevano nei miei, la voglia pazza di trattenere il tempo e poi il commiato. Il cielo si dilata fi no a cancellare ogni apparente linea di confine; il sole, l’erba, l’albero e i suoi rami tessono un arazzo di luci e di colori che coi profumi si uniscono in tripudio insieme a noi.
Il mondo guardato con gli occhi dell’amore è più dell’Eden, e nel nostro già si pregusta l’infinito. Ma come posso condividere con te, oggi, il ricordo di quei giorni? Lo sguardo tuo di allora non lo ritrovo più. Si è fermato 12 oltre i limiti reali, in un luogo senza nome e sconosciuto, dove vorrei entrare ma vedo che si ritrae da me e si allontana. Non so quanto potrei e come riportarti quelle sensazioni e condurti per prati erbosi e luoghi d’ombra a parlare, come allora, solo di noi. In questo tempo di attesa il silenzio è diventato il tuo rifugio; le parole ti pesano quanto i passi incerti e lo sguardo, perduto, approda qua e là debole e stanco. Mi chiedo se può bastarti il mio esserti a fi anco anche senza parlare; poi mi consola il credere che ogni creatura umana, col perdere forza e vigore, possa acquistare in giusta proporzione capacità che noi non conosciamo e perciò sfuggono alla nostra percezione sensoriale. Allora dico che nulla forse è perduto di quel che siamo, anche quando l’altro ci sembra completamente assente.

10 marzo – Troppo diversa questa sera da quelle di una volta
Troppo diversa questa sera da quelle di una volta quando, al rientro dal lavoro, mi raccontavi delle cose andate male o di piacevoli sorprese. Lo facevi con dovizia di particolari, quasi a compiacerti del tuo raccontare ben nutrito, immancabilmente aggiuntivo di nuove fioriture. Allora non eri certo parco di parole e non serviva la mia delicatezza a farti capire che lo spazio doveva essere anche mio; così accadeva di frequente che tu rispondevi per me, battendomi nel tempo, quando ci si tratteneva con gli amici e qualche volta, con mio grande disappunto, sforavi con qualche parolona fuori luogo. Eri forte e la tua presenza mi dava sicurezza; premuroso e attento in ogni circostanza e bravo a sollevarmi da carichi eccessivi. Ho imparato a fare tutte quelle cose cui solo tu sapevi provvedere. Devo dire però, che ho pagato a caro prezzo tutto il tempo che mi hai lasciato in libertà. Ora mi addolora il silenzio che mi esclude dal tuo mondo. Ti guardo. Mi guardi. Alle mie sollecitazioni non rispondi. Non riesci a trovare le parole: sono fuggite come l’acqua dileguava in mille cerchi quando, sulla battigia, ti divertivi a giocare a rimpiattino. Ti disorienta non ricordare il nome delle cose: è come avessi perduto i riferimenti del reale, ed io mi sento annichilita dalla mia impotenza. Ti vedo tanto fragile e indifeso e se da un lato vorrei che fossi più combattivo, dall’altro colgo il profondo disagio che è in te e mi fa male. Ora che non ho più nulla da rimproverarti capisco il valore anche dei contrasti e mi sento perdente, non potendo competere con te. Non mi cerchi. È come se non avessi bisogno più di me, come volessi solo riposare, e tante volte, per paura di violare il tuo strano stato di apparente oblio, sempre più sola mi allontano. Ti seguo con lo sguardo. Il passo incerto mi fa trasalire e le cadute mi danno la misura della precarietà della tua vita. Le prime volte che ti succedeva, con la tua collaborazione ti rimettevo in piedi; ora non è più così. Non avendo il mio sforzo il tuo supporto, resti a terra, e ti va bene se lo è per poco. Può accadere infatti, che i soccorsi tardino a venire e allora dovrai accontentarti di restare al tappeto un po’ più a lungo; ti ho promesso però che, in tal caso, ti faciliterò l’attesa facendoti poggiare la testa sopra un cuscino. Così non sarà poi tanto male.

PARTE SECONDA
11 marzo – La giornata fredda e senza sole accresce forse in te il senso di abbandono
La giornata fredda e senza sole accresce forse in te il senso di abbandono ma sai, sono le ultime botte di un inverno che ci ha massacrato di pioggia, vento, fulmini e saette. Alle porte c’è ormai la primavera e insieme potremo godere tanto sole negli angoli a te più cari della nostra casa. Rivedremo il mare con gli occhi della mente e sarà come fossimo distesi sulla sabbia. Sei sempre tu a piazzare l’ombrellone; ti vedo inginocchiato a scavare la sabbia con le mani e sdraiarti accanto a me, e poi correre divertito con le bimbe lungo la battigia e irrorarvi la pelle con gli spruzzi. Sei stato padre e maestro di rare qualità e posso dire che ti ritorna tutto con buona provvigione. Sei stato anche un bravo combattente nelle battaglie della vita, e ce ne sono state di tremende che hanno messo a dura prova il nostro amore. Mi sono vista più volte come un giunco in balia di un tornado; credevo proprio di spezzarmi, ma con te a fi anco ce l’ho fatta. Come ti sia sentito tu non me l’hai mai detto e ora è troppo tardi perché possa farlo, però mi senti e questo può bastarmi.È una mia teoria che ciascuno di noi sia una scheggia d’infinito caduta sulla terra; lei ci tira a sé con la forza di una calamita e le sensazioni sono legate al mondo del reale. Come tutte le schegge però, ci accendiamo d’improvvisi bagliori che ci legano ad una dimensione superiore e, in virtù di questo, possiamo godere di percezioni interiori straordinarie. La forza della terra ci consente di conoscere tutto quanto appartiene al mondo del sensibile, così come noi riusciamo a percepirlo col contributo delle nostre debolezze e vediamo allora il volto delle cose belle, come l’amore e tutte le sue derivazioni; ma anche i loro opposti. “Quei bagliori”, a loro volta, tirano verso l’alto i loro fi li d’oro e, se lo vogliamo, ci fanno godere di beni superiori che danno le risposte che cerchiamo e una pace che neanche chi la prova sa spiegare. Dicevo poco prima che le nostre battaglie sono state tante: parecchie vinte, qualcuna persa per scarsa incisività della nostra difesa personale, e una dura ancora da trent’anni. Più che di una battaglia direi si tratti di una guerra, con qualche tregua, si capisce. È sorda, intestina, di quelle che vanno a botte come i terremoti e quando speri sia fi nito tutto, arrivano altre scosse. Ora mi manca il tuo sostegno e questo mi fa sentire più scoperta, e se aggiungo che come te non ho mai avuto adeguate armi di difesa, devo ammettere che la cosa per me è fonte di paura.
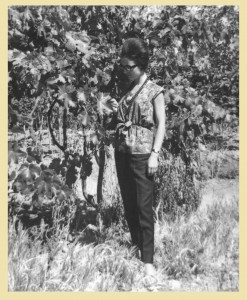
13 marzo – Ricordi quando mi venivi a prendere in quello stazzo dell’Anglona
Ricordi quando mi venivi a prendere in quello stazzo dell’Anglona, dove insegnavo in una pluriclasse? Dopo giorni di abbondanti piogge accadde che l’auto s’impantanò in un mare di argilla rugginosa. Ti vedo scendere e affondare la gamba fino alla caviglia, nel tentativo di collocare qualche sasso sotto le ruote posteriori: dobbiamo superare il guado a tutti i costi. Al volante stai seduto tu. Acceleri. Io, con tutte le mie forze, cerco di spingere, a terra, posizionata dietro una ruota posteriore. Questa agisce con l’effetto di una fionda: ingloba un sasso nel turbine di fango che deriva dal suo girare vorticoso e lo catapulta contro il mio ginocchio con la forza di un proiettile. Tutto questo avviene mentre l’impasto mi cambia i connotati, intonacandomi il volto, la giacca e i pantaloni. Le gambe restano prigioniere di quella mota oscura, e io cerco di liberarmi almeno un occhio per vedere che fi ne hai fatto tu. A stento cerco di recuperare un po’ di forze e gli stivali annegati nel pantano.
Il dolore, fortissimo, mi ha tolto anche la parola. Ti saluto solo con la mano e come un cane ferito che cammina su tre zampe, riesco a raggiungere lo stazzo. Cerco di ripulirmi come posso e mi trascino verso gli scolari, in attesa sullo spiazzo della scuola.
Tu rientri in sede per venirmi a prendere a fi ne settimana. Nel frattempo il ginocchio si è gonfiato e non si distingue dal resto della gamba, diventata grossa quasi come due. Devi portarmi in braccio fi no all’auto che, per prudenza, hai lasciato a valle onde evitare altri contrattempi, essendo il terreno ancora intriso della pioggia di una settimana. La permanenza in casa si dilata: devo stare a riposo assoluto per un mese onde evitare complicazioni gravi alla rotula evidentemente compromessa. C’è dell’altro. Forse non ti ho mai detto del guaio che mi procurò, una mattina, lo yogurt della signora che mi offriva la pensione. L’attività didattica è appena cominciata e io sento impellente il bisogno di assentarmi per un improvviso meteorismo intestinale. Non so che fare. Non c’è tempo. Nomino all’istante un capoclasse e corro verso un cespuglio di lentischio. Sotto quella capanna che madre natura mi offre per pietà, trovo i primi istanti di sollievo ma devo prendere atto, all’improvviso, che tre galline mi girano intorno interessate. Provo imbarazzo nel sentirmi osservata da quegli animali che hanno l’occhio aperto a tutto tondo. Devo tenerle a bada con gesti delle braccia, ma indietreggiano di un passo e avanzano di due anche quando cerco di difendere le mie intimità lanciando qualche sassolino che, nonostante la posizione poco comoda, provo a raccattare intorno a me. La mia testa gira a ventarola per tenerle a bada. Ma non è mai tanto male il prima, quando quel che viene dopo è molto peggio. Un gallo spavaldo che sbuca alle mie spalle è deciso e malintenzionato. Avanza a passo svelto. Non so che altro fare. Umiliata e carica di sdegno afferro un ceppo che la fortuna mi offre un po’ più in là e glielo scaglio contro con tutta la forza che ho in corpo, ma non lo centro. Lui, agile com’è, lo schiva con un salto nel comune starnazzare delle galline spaventate. nello scompiglio generale realizzo che devo lasciare il cespuglio prima che qualcuno voglia verificare l’accaduto. Mi ricompongo e a passo svelto attraverso la tanca che mi separa dalla scuola, recuperando il sentiero che si apre in mezzo all’erba alta almeno mezzo metro e intrisa ancora della brina della notte.
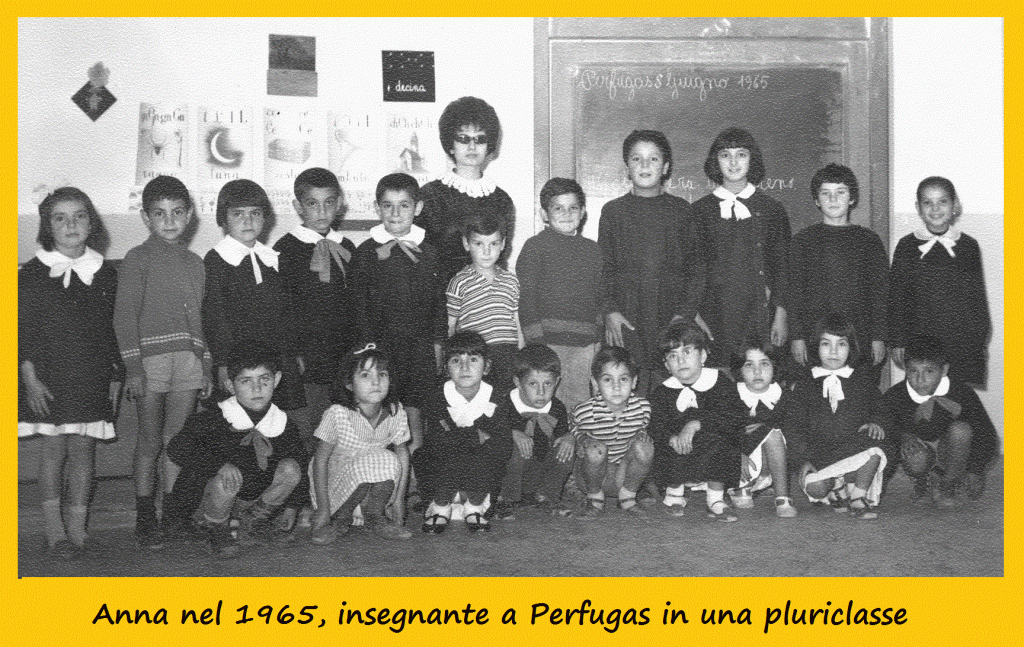
PARTE TERZA
15 marzo – Oggi voglio raccontarti di altri fatti
Oggi voglio raccontarti di altri fatti, collegati sempre all’insegnamento fuori sede. Non so se ricordi ancora che avevo acquistato la mia prima utilitaria giusto per raggiungere la scuola e fare su e giù la pendolare. La sede era lontana e la strada, alquanto dissestata, non consentiva che una velocità di percorrenza molto limitata. La mattutina levataccia e la partenza erano materia assicurata per una tragicommedia quotidiana. Ogni mattina la sveglia suonava puntualmente ma io, che di sonno non riuscivo mai a saziarmi, ovviamente non davo segni di risposta e tu, instancabile, mi sollecitavi con le toccatine delicate prima e poi con la voce a volume naturale. I primi tempi, con l’entusiasmo che accompagna ogni novità, riuscivo a superare il gelo del fatidico momento. Una mattina però, le sollecitazioni di cui sopra non riescono a sortire alcun effetto e tu, avvantaggiato dalla mia posizione e non sapendo più come intervenire, mi punti un piede sulle chiappe e molto lentamente ma deciso spingi, spingi e spingi. Comincio a prendere coscienza. Sento il bordo del letto inevitabilmente sempre più vicino. Il piede spinge ancora come un congegno di puntamento di grande precisione e con mio grande disappunto arrivo al pavimento. La prendo come una mancanza di rispetto e durante il viaggio medito vendetta. Non dura il mio risentimento perché sai capire il disagio e la stanchezza che ogni giorno porto a casa e perdonare il nervosismo e le sfuriate che tante volte non ti ho risparmiato. Devo dire però che anche tu, nonostante la bontà che ti distingue, più d’una volta mi hai lasciato sconcertata, mostrandomi di te quel che meno mi piaceva. Ora che hai messo i remi in barca posso guardarti solo con tanta tenerezza e carezzare il tempo che ci ha visti insieme. È dolce e di conforto poter vivere a lungo perché ci si scopre a misurare con un altro metro le nostre debolezze e quando torniamo indietro coi ricordi, questi scolorano nella nebbia del passato, quasi a mostrarci attraverso un velo di sottile trasparenza i contorni essenziali di un tracciato disegnato dalle vite.
I volti diventano rugosi ma l’animo si accende di una luce che non sa più di provvisorio. È come se ci si fermasse ad osservare il mondo che abbiamo vissuto in frenetiche sequenze, negandoci quella magica visione che sa esaltarci proprio a questa età.

17 marzo -Perché mi guardi?
Perché mi guardi? Lo fai per distrazione o sei ancora interessato? Mi piacerebbe sentire come vedi la mia cera e come imposteresti una tua conversazione sulla bellezza che sfiorisce e la zavorra che rimane. Di solito gli uomini, che poco amano guardare nel di dentro e molto dal di fuori, vedono le donne che non sono più fanciulle come delle barche sgangherate ed è per questo che cercano scialuppe sempre nuove. Se tu sai osservare un bambino attentamente, ti accorgi che resta affascinato da ogni novità e vuole possederla a tutti i costi. Ogni gioco nuovo lo fa suo, lo smonta, vuole vedere come è fatto, lo rimonta, quando lo fa, e poi lo abbandona. Capisci il parallelo? Non dico che si tratti del tuo caso. Almeno questo è quanto mi risulta, ma non posso fare a meno di certe riflessioni. Vuoi che ti dica quel che penso in merito alla moda di rifarsi? Non condivido l’idea di chi vuole omologarsi, che sia uomo o donna non importa; amo leggere su un volto amato o conosciuto i segni che lascia lo scorrere del tempo. Vado contro corrente rispetto a chi il tempo vuole fermarlo; prendo quel che mi dà, mi unisco alla sua danza nel vortice dei giorni, tante volte lo sfi do e altre lo bacchetto, non lo tradisco mai. Gli chiedo, se può, di non togliermi la grinta, di portare oltre il mare la mia voce, di custodire del mondo tutte le cose buone e cancellare il male. Corro con lui anche quando sono trattenuta, gioco d’anticipo per non farmi cogliere in castagna e gli confido i miei segreti per non perderci di vista. Amo raccontargli favole come faccio coi bambini, inventare storie per tenergli compagnia, ricordargli la mia giovinezza e la voglia che mi resta d’inventarmi un’altra vita. Non voglio cancellare la scrittura che ha impresso sul mio volto: lì ci sono i preziosi ricordi dell’infanzia, i sogni della giovinezza, le attese dell’età matura e la consapevolezza degli anni che vivo e che verranno. C’è tutto il sole, la pioggia che tante volte mi ha colto di sorpresa, le lotte col vento di maestrale e il freddo gelido di tanti inverni in modeste pensioni di campagna come in solitudini di città completamente spente. E c’è anche la scrittura impressa da avventure straordinarie, da carovane in cerca di sollazzi, da notti di luna tra vecchi montanari e suoni di launeddas, dall’eccitante gioco di danze improvvisate, aspettando che si facesse l’alba sulle balere della giovinezza. Ci sono le pene dell’amore così dolci ma tante volte anche tormentate e quei drammatici vissuti che ti cambiano la vita e scavano abissi che solo l’anima conosce ma rimanda al volto le profonde tracce.
Sarebbe un tradimento se volessi cancellare i segni della vita, un po’ come colmare i solchi di un campo appena arato; e che senso avrebbe? Che senso ha la fatica se prepari la terra e ti fermi prima della semina? Immagina poi se si fosse tutti nel pieno della giovinezza! Indubbiamente sarebbe uno spettacolo d’indescrivibile bellezza e forse anche un mondo di follia pura. Ma allora, come si farebbe a conoscere questo grande amico che lenisce ogni dolore e chiude le ferite? Tu mi diresti che ne apre delle nuove. È vero, però così non ci si annoia mai. Dimmi tu, come si farebbe a riconoscerlo se non ci fossero le età dell’uomo che così bene lo caratterizzano? Il mondo sarebbe un giardino immenso, stupendo sì, ma fatto solo di una specie floreale.
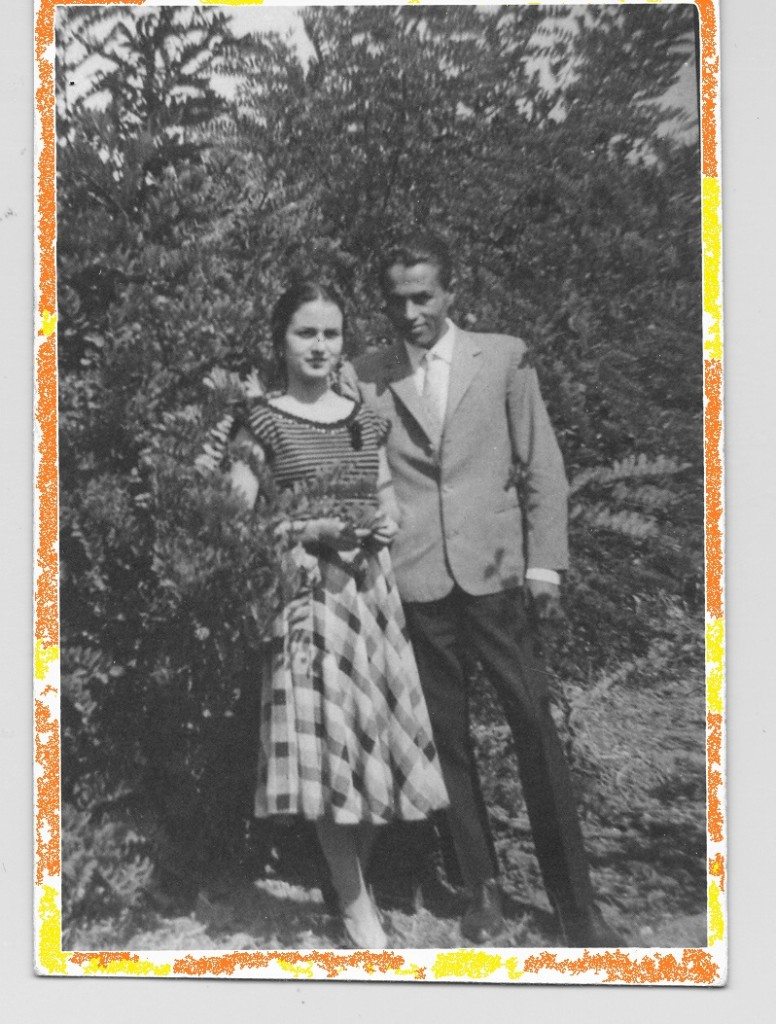
20 marzo – Oggi voglio parlarti di “Sicolina”, la mia prima utilitaria
Oggi voglio parlarti della mia prima utilitaria. L’avevo acquistata in occasione del passaggio in ruolo, ricordi? Così cominciava la mia vita di insegnante pendolare, dopo anni di pensione negli stazzi della Gallura e dell’Anglona. La chiamavo “sicolina” e sembrava tagliata proprio addosso a me, tanto che la sentivo come il vestito della festa. Mi pavoneggiavo,anticipando alla grande il femminismo; di questo però parleremo un’altra volta. Torniamo a lei. La ritenevo il mio salotto quotidiano, la fuoriserie, il camper giramondo, la limousine che potevo sfoggiare come bandiera della mia emancipazione galoppante. Tra noi c’è stata una perfetta intesa. Ha imparato a conoscere i miei limiti ed io la sua potenza e la risposta; per questo ha saputo perdonarmi l’incapacità definitiva a fare la doppia debraiata e il parcheggio in retromarcia. Sapeva tutto di me; conosceva umori e nervosismi e soprattutto vegliava sulla mia stanchezza e la micidiale sonnolenza che s’impadroniva di me durante il viaggio. La usavo anche come arma di difesa quando, dopo qualche nostra litigata, fuggivo con lei sbattendoti la porta. Rammenti la volta che mi lasciò a piedi per vendicarsi della mia intemperanza? Furente la lasciai sul bordo della strada e più tardi fosti tu a recuperarla. Siamo invecchiate insieme, perché il nostro è stato un grande amore, ma dopo trent’anni lei ha cominciato a perdere i suoi pezzi. Per pudore non ti ho mai detto quanto mi è costato il suo distacco. È vero che la sapevo in buone mani: un amatore, infatti, l’ha introdotta nel fantastico mondo delle antichità, ma ti assicuro che è stata bestiale la mia sofferenza. Mi domando se a lei sono mancata e quanto. Anche le cose pare abbiano un particolare modo di sentire, visto che sanno alimentare in noi i più svariati sentimenti. Come si spiegherebbe una perfetta intesa? Il rimpianto? La nostalgia che ti assale e il nitido ricordo che ti resta? Qualche giorno prima che ne facessi la consegna, rimasi un po’ con lei, i finestrini chiusi, quasi a voler nascondere a chicchessia l’ultima carezza. M’invase un’esplosione di sentimenti contrastanti, quelli che derivano da un inevitabile abbandono e la necessità impellente di voltare pagina. Le dissi che anch’io, come lei, non avevo più lo smalto d’una volta né potevo sperare in una pietosa giovinezza di ritorno che mi avrebbe permesso di affrontare con disinvoltura qualunque situazione di emergenza. Le confessai col nodo in gola che la separazione sarebbe stata molto dolorosa e che più volte ho accarezzato il sogno di tenerla con me, offrendola all’arte sotto nuove forme; ma il tempo ha deciso per me in altro modo. La nostra è stata una storia di straordinaria fedeltà, di quelle che ti legano per sempre e gli anni non ne cancellano il ricordo. Il pensiero corre a lei, non riesce a immaginarla in altre mani e la nostalgia ritorna puntuale. Tu hai cambiato tante auto con facilità. Lei è stata l’unica per me, e quando mi accade di vedere una cinquecento vecchio tipo color sabbia, provo inevitabilmente un tuffo al cuore; proprio come quando vedi da lontano un vecchio grande amore: ti fermi un istante e con lo sguardo l’accarezzi ancora, sperando che nessuno possa cogliere questo momento che vuole restare solo tuo. Poi abbassi gli occhi e te ne vai nella grigia nebbia di una malinconia senza volto.

PARTE QUARTA
22 marzo – Sono stanca,non ho voglia di mettermi ai fornelli
Sono stanca; non ho voglia di mettermi ai fornelli, preferirei stare seduta accanto a te e trovarmi nel piatto, come per magia, i manicaretti che sapevi fare tu. Ricordi la tua passione per l’arte culinaria? Far la spesa era per te come per una donna andare per vetrine. Ci prendevi tutte per la gola con i piatti d’eccellenza e intascavi complimenti a destra e a manca. Ma, dimmi la verità, perché con gli anni hai voluto cambiare abitudini e menu lasciando che facessi tutto io? Ora la tua goduria è diventata la poltrona e non ti schiodi più. Sarà forse perché ti piace essere servito e riverito? Non mi aspettavo che mi avresti riservato la sorpresa di cotanto carico, proprio ora che facevo un pensierino su noi due. Immaginavo di poter volare con te sul deltaplano, per dominare da una certa altezza i luoghi vissuti un tempo dai banditi e quelli sconsacrati dalle mafie, i paradisi dai quali siamo esclusi e le tanche assolate dove possono vagare solo ombre. Vorrei vederla tutta, questa Sardegna, con un solo abbraccio dello sguardo e distinguere insieme anse, rade, fondali e faraglioni, precipizi, vette superbe, nuraghi e torri aragonesi diventate l’ultimo baluardo dei nuovi sardi dalla notte di Buggerru. Vorrei vedere in una volta i suoi contrasti: il Supramonte e la vita che è nel mare, la ricchezza sfacciata della Costa e l’estrema povertà delle pinnette, lo sfavillio di architetture da nababbi e lo squallore dei rifugi di fortuna. Volevo fare un ripasso con te delle lezioni della vita, per non dimenticare ingiustizie e differenze, diritti negati e schiavitù e sfidare lo sguardo di corrotti e corruttori. Volevo poi planare per spazzare le tavolate dei baroni che parlano di affari, dollari e donnette, mostrando le nudità come trofei. Volevo entrare nelle celle all’Asinara, dove si consuma l’ultimo atto di una tragedia che dura dal tempo dei nuraghi, e dividere l’attesa di uomini soli che chiedono lavoro per non diventare criminali. L’operaio non ama il facile guadagno ma la sana fatica del lavoro onesto; è il solo che sa soltanto chiedere anche a costo della vita, e lotta per il pane quotidiano senza armi di difesa. I potenti non potrebbero mai vincere il suo sguardo. Penso proprio che il deltaplano non potrà mai imbracarci, viste le tue condizioni di salute ma non rattristarti, direi che comunque il ripasso è stato fatto. A cosa possa servire non lo so, se non ci viene dato modo di far sentire la nostra esposizione; ma torniamo ai tuoi piatti succulenti che non ci sono più. Devo dire però che sei molto comprensivo con la mia cucina; lo deduco dai voti che mi dai. Ma dim mi, la tua è una magnanimità nata insieme a te o una forma pietosa di bontà che nasce all’occorrenza? Ho capito; vado a preparare.

23 marzo – La nostra è l’età in cui con serenità ci si racconta
La nostra è l’età in cui con serenità ci si racconta; peccato che, tante volte, non lo si possa fare senza qualche inevitabile rimpianto. Volevo chiederti se ti è mai capitato di ritrovarti a fare un bilancio della nostra vita e se questo è accaduto, se è stato in perdita per te. Già immagino quali possano essere i miei punti di svantaggio, conoscendo quelli forti che possiedi tu. Temo non abbia apprezzato a sufficienza la mia natura taciturna e solitaria che mi ha portato spesso in una dimensione, dove giustamente faticavi a entrare perché sei concreto. Devo dire che sei stato buono e rispettoso, studiando forse di evitare approcci fuori luogo e questo, se da un lato mi dà la misura del tuo affetto e della delicata tua prudenza, dall’altro, devo confessarti, mi lascia un certo amaro retrogusto. Entrambi siamo stati però pezzi essenziali del medesimo congegno: le ruote del calesse che si abbracciano al telaio e percorrono la strada della vita attutendone a vicenda gli scossoni. Abbiamo superato fossi e sfi orato precipizi, guadato fiumi ed evitato frane che ostruivano il percorso, ci siamo arenati nel pantano di luoghi sconosciuti e inf ne ritrovati accanto a una panchina che ci offriva un po’ di sicurezza. Dalla nostra postazione abbiamo fatto tirassegno senza mai stancarci, mirando l’obiettivo anche quando diluviava, coi fucili puntati come due soldati che hanno perduto la divisa. Gli obiettivi falliti sono stati tanti ma ne abbiamo anche centrato; tra i primi ci sono quelli mancati a causa di terzi e altri perché forse non abbiamo saputo misurare i nostri sforzi. Il povero calesse ha macinato tanti sassi da ritrovarsi con le ruote consumate; il mantice non l’ha mai posseduto perché appannaggio della “nobiltà”: il nostro doveva essere un viaggio sotto il solleone che avvizzisce in anticipo la pelle, togliendole lo smalto della giovinezza. Sai, vedo la vita come una strada sterrata molto accidentata, con ciottoli e buche a volontà che non ti permettono mai di rilassarti e col tempo, la vettura di cui sopra, finisce per ridurti a un cumulo di ossa dolenti e deformate. E tutto va bene finché ti restano le ruote. Pensa tu, che straordinaria la vita! Secondo me l’assapori solo viaggiando con mezzi primitivi, i soli che sanno tenerti desto per il loro particolare modo di condurti. Del resto a che servirebbe stare sdraiati sul sedile posteriore di una macchina che sfreccia in autostrada e ti concilia il sonno? La vita è tutta fuori. Il nostro calesse ora s’è fermato. Una delle ruote ancora gira, ma l’altra ha dichiarato la sua resa e passa i giorni adagiata su un cuscino, quasi a rifarsi degli agi non goduti. Ha perduto la grinta battagliera; i raggi lenti mostrano un cedimento della presa e il legno, che il tempo ha impallidito, mi rimanda il triste racconto della linfa ormai perduta. La guardo con rassegnata nostalgia e ancora sento forte l’abbraccio del telaio che, seppure unito solo a me, ama tenerle compagnia senza perderla di vista e accenderle il ricordo di un tempo che scolora.
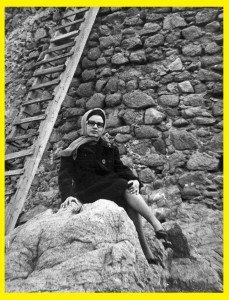
25 marzo – La giornata odierna passerà alla Storia come la “pacifica rivoluzione” contro l’abuso di potere
La giornata odierna, sai, è eccezionale; passerà alla Storia come la “pacifica rivoluzione” contro l’abuso di potere che vuole cancellare dal pubblico servizio i programmi dell’informazione e del dissenso. I fatti di guerra che raccontano i libri della scuola, ricordi? Sembrano tanto lontani dal nostro quotidiano, e invece no. La prevaricazione, l’insulto e il vilipendio alimentano lo scontro sempre in atto, che si combatte sui media ormai da troppo tempo, impregnando di veleno la vita democratica. C’è ancora chi non ha imparato nulla da secoli di storia e sotto l’abito borghese cela stivali e pantaloni grigio-verde come i vecchi boia d’altri tempi. Cambia la divisa, l’uomo no. Il despota di turno ama far mostra di sé e frena il tempo per ripescare gli anni già vissuti e sempre in forma offrirsi alla platea. Il nuovo imbonitore degli schermi, vendendo sproloqui a tutto campo, incanta le masse popolari e impingua il proprio ventre togliendo il pane a chi lotta per averlo. Incoraggia l’ottimismo sfoggiando sorrisi a trentasei, e quelli che sperano di diventare come lui, si prodigano senza pudore in stomachevoli applausi a scena aperta. Con sfacciata tracotanza e l’indice puntato, il moderno dittatore in doppio petto fomenta l’odio e incita allo scontro, confonde le menti con i suoi proclami e fa il tiro al bersaglio con i dissidenti. Nei lussuosi palazzi del potere ama sfoggiare la sua “virilità” insieme alle bandane, gonfiando le fi la del “partito dell’amore”. Intanto l’Italia diventa l’ultimo cantiere dove gli operai depongono gli attrezzi; nei cortei sfilano i giovani defraudati del futuro e i tetti delle fabbriche in disuso raccontano di presenze disperate. Sbandierano striscioni i nuovi licenziati e gridano aiuto le famiglie senza tetto, franano i costoni mai messi in sicurezza ed esondano i fi umi senza più canali. Le incompiute che durano trent’anni si aggiungono alle nuove che già perdono i pezzi. Le sole cose che funzionano sono tangenti e regalie di qualsiasi “colore”, che non conoscono crisi di mercato. L’etica è un concetto d’altri tempi che fa sorridere le “cricche”, sempre in attesa di alluvioni, terremoti e grandi eventi. Ma cosa dico! Sono tutte calunnie, complotti e castelli di carta costruiti solo per invidia. Come si può pensare che uomini di tale levatura…? E tu come la pensi? Tranquillo, conosco la risposta. Il nuovo paladino della libertà è talmente generoso che ha voluto allargare lo “scudo” anche ai suoi ministri e fare il ponte sullo Stretto per accorciare le distanze… Ma la cosa più straordinaria, che non ha confronti, è la solenne promessa di debellare il cancro entro tre anni, senza bisogno di fondi alla ricerca. Che vogliamo di più? Penso che tu daresti man forte alla mi a rabbia, se potessi farlo; mi servirebbe, credimi, mi servirebbe tanto, così invocherei l’ira dei giusti insieme a te.
 l
l
PARTE QUINTA
27 marzo – Volevo farti una carezza con la mano nera di fuliggine mentre ti passavo accanto
Ciao. Volevo farti una carezza con la mano nera di fuliggine mentre ti passavo accanto, ma il tuo passo traballante mi ha fatto desistere perché nel tentativo di evitarla avresti perso l’equilibrio. Ti prometto però che al momento giusto ci riproverò, perciò ti consiglio di tenermi d’occhio, soprattutto quando mi vedi impegnata in quel particolare lavoro che tu sai. Visto che non hai esaudito il mio antico desiderio di vederti con barbetta incolta, baffi e capelli lunghi al punto giusto, voglio provare ora a cambiarti a modo mio, togliendomi uno sfizio che dura da trent’anni.
Ricordo di aver notato l’eleganza di una giacca avana e i pantaloni grigio-fumo quando avevo diciott’anni e m’innamorai di quel ragazzo bruno con gli occhi da cerbiatto. L’amore di quegli anni poteva durare tutta la vita; forse si respirava ancora una cert’aria di romanticismo, seppure ormai crepuscolare, e i sentimenti sapevano resistere a tutte le tempeste. Il pudore regolava, la durata dell’ “attesa” e il rispetto aiutava a vincere tante debolezze; poi c’erano la dedizione e il sacrificio, e l’educazione di modi e portamenti dava la misura della completezza e della personalità. Il senso di responsabilità e del dovere era talmente forte da saper filtrare ansie e desideri, e il profondo sentimento religioso illuminava progetti e aspettative. Altri tempi! La decadenza della civiltà dell’operare onesto e laborioso alimenta il disimpegno e il culto dell’effimero, dell’apparenza e non della sostanza. Ogni cosa si riduce a mero prodotto di consumo; si corre alla conquista di emozioni sempre nuove che portano inevitabilmente a una caduta in verticale del valore delle stesse; il risultato è un nichilismo strisciante spaventoso.Ho nostalgia, sai, del nostro tempo. Rispetto ad oggi non avevamo niente in senso materiale, ma eravamo molto più sereni; le piccole cose erano conquiste che ci rendevano felici, e soprattutto sapevamo amare. La sofferenza dell’altro diventava nostra, la solidarietà non era propaganda e la dignità era il distintivo dei più forti. Insomma, come accade spesso, l’equilibrio lo si scarta perché scomodo, se non cosa superata, perciò, in caduta libera, ci si schianta sul materialismo. Ci sarà sempre chi ha troppo poco e chi invece troppo ma a sostegno dei deboli c’era la costante dei valori. Siamo tutti colpevoli di aver corso la china senza curarci di azionare di tanto in tanto anche il freno a mano, concedendoci qualche salutare riflessione. Sai, tante volte corro col pensiero a certe antichissime tribù che isdegnano il progresso; evidentemente non c’invidiano il prezzo che paghiamo. Non manca tuttavia chi comincia a fare qualche pensierino su come tornare alla natura e liberarsi di tutto ciò che non risponde all’essenzialità. C’è una donna sarda che, nella terra chiamata ormai dei centenari,unica al mondo, ha organizzato la sua vita in un monolocale di forma circolare: la pinnetta, da lei stessa costruita con materiale di risulta. C’è di più: a differenza di coloro che vivono in tribù, lei ha collocato l’uomo tra le cose che non giudica essenziali. Ciao caro, ti lascio riposare.
1 aprile – Oggi è primo aprile. Ti ricorda qualcosa?
Oggi è primo aprile. Ti ricorda qualcosa? Ai nostri tempi si ritagliavano i pesci in pannolenci,si coprivano di polvere di gesso, si praticava un foro nella coda e lì si annodava lo spago della lunghezza che si desiderava e poi si lanciavano ai passanti. Ricordi ora il divertimento dissennato?
Di solito si prendevano di mira le donne di una certa età perché quel marchio bianco spiccava a meraviglia sui cappotti neri. Ai nostri coetanei invece si facevano scherzetti che andavano dalle stringhe slacciate delle scarpe, al bavero scomposto; dalla calza di nylon smagliata all’orlo scucito di gonne e di pastrani. Si aspettava dietro i portoni e lungo i muri delle case il passaggio dei predestinati e appena voltavano le spalle la patacca bianca era assicurata. A volte accadeva che qualche vittima intravvedesse il balenio dello spago in fuga di ritorno e si voltasse minacciosa sentendosi beffata. Ci si fingeva estranei, tutti non colpevoli, attori sulla strada che diventava il nostro palcoscenico, dove ci si sentiva gabbati e gabbatori. Per i bambini l’attesa di quel giorno era già festa; si recuperavano vecchie lingue di stoffa dai cassetti della mamma e si sottraevano alla scuola i gessetti bianchi di risulta; lo spago si poteva ricavare annodando tra loro i pezzetti che il babbo scartava quando legava le canne del traliccio. Non occorreva chissà quale materiale per realizzare i nostri giochi, né ci si annoiava col poco che si aveva. Si sapevano inventare le cose più fantastiche: i fusti piatti delle piante grasse diventavano carretti, con le canne si facevano trombette, il vecchio manico dismesso diventava un destriero che nitriva al vento e il cerchio spinto a mano faceva il giramondo. Si faceva il gioco della palla a muro o quello delle belle statuine che sembravano sculture, si trasferiva il “prigioniero” sul seggiolino a quattro mani e su una tavoletta a due rotelle si sfrecciava sull’asfalto. E poi c’era la passione per il gioco dei “ballocci”. Ricordi? Voi maschietti passavate ore, seduti a terra, a puntare e prendere la mira sulle “cristalline”, prima che scattasse il tic del pollice e dell’indice che diventavano una formidabile molla circolare. Erano stupende palline di cristallo colorato nei modi più svariati e i bravi giocatori ne possedevano a cascate. Io, sui muretti a secco e le treccine al vento, superavo valli e dirupi per volare insieme ai condor. Mi affascinavano nelle giornate ventose, le case che si spostavano invece delle nuvole; nelle notti stellate l’inutile conta dei punti luminosi e nei tramonti di fuoco il sole che lentamente si tuffava in mare. Le cime degli alberi diventavano trampolini per le fate e il gorgoglio dei ruscelli un festoso raduno di libellule. Oggi, troppi bambini non sanno più sognare. La fantasia l’hanno perduta tra gli ingranaggi di moderni meccanismi e vivono gli incubi di una vita convulsa che genera violenza. I bimbi creativi e sognatori erano quelli che a diciott’anni facevano le serenate alle fanciulle sotto i balconi, ai raggi della luna, accompagnando il canto al suono dello strumento allora in voga: il mandolino. Le ragazze, destate all’improvviso dal bel canto, nel silenzio della stanza buia, sbirciavano dietro le tendine nell’attesa, ciascuna, che il più bello ne pronunciasse il nome. Che notti! Non erano da sballo.
3 aprile – Questa notte le tue interminabili apnee mi hanno tenuta desta troppo a lungo
Questa notte le tue interminabili apnee mi hanno tenuta desta troppo a lungo, per cui ho avuto modo di pensare al tempo in cui è cominciato il tuo declino. Ero serena e tanti erano i progetti. Non mi sfiorava neppure con la leggerezza di una piuma il pensiero che la nostra vita potesse subire una virata tale da togliermi anche l’ultima speranza.Era la giovinezza del cuore e della mente che mi dava la vitalità che possedevo; funzionava come una potente catapulta. Capisco che è opera del tempo. Non è tuttavia solo mascalzone ma anche un grande amico e il toccasana che ha dato il via all’ultima catarsi. Ora conto i secondi: non sento il tuo respiro. Conto, conto, ma tu non dai segno di ripresa. Scatta il panico. Ti sveglio. Dopo un po’ tutto ricomincia come prima. Provo a modificare la posizione del guanciale. Non cambia nulla. La cannula e l’ossigeno non bastano a darmi la serenità che mi consentirebbe un poco di riposo. E penso, penso agli anni vissuti nell’angoscia, ai momenti di sconforto e di terrore che mi vedevano correre al telefono per invocare un mezzo di soccorso. Rivivo le volte che hai perduto conoscenza, le crisi comiziali, il pallore e l’abbandono. Conosco il volto scuro e l’abbraccio gelido di una solitudine che si manifesta tale solo in quei momenti.Un’ansia angosciosa mi accompagna lungo il vialetto che conduce allo studio sempre chiuso. Entro. Annaspo nel buio e nell’odore acre della muffa cercando un po’ di luce. Le sensazioni, tante, sono quelle che si provano quando lo sguardo scivola smarrito, dalla scrivania vuota con le carte ancora lì, all’armadio semiaperto per un fermo provvisorio, ai pennini e alla china e al progetto realizzato solo per metà. La tristezza e la polvere hanno steso un velo sopra ogni cosa. Io sono lì, ancorata a un presente sfilacciato, con la dolorosa certezza che nulla potrà tornare come prima, e nella mente vedo passare gli anni futuri come spettri neri che camminano in fila. Rileggo l’ultima tua relazione e vedo, con sgomento, la portata del danno causato da quella ischemia. Ti vedo in un letto d’ospedale; lo sguardo confuso si allontana dal mio. Il gorgoglio dell’ossigeno mi riporta al presente e il respiro, tornato normale, mi consente finalmente un po’ di riposo. Mi sento trascinata in un vortice di zolfo da odiosi fantasmi e mi ritrovo nel mezzo di un tornado con le braccia tese per fermarne la violenza. Il vento ulula, mi investe con tremende scudisciate in pieno volto e mentre corro nel tentativo di mettermi al riparo, un’ombra tetra simile a un gigante, con il volto celato contro il petto, immobile, ostenta la sua mole e mostra di volermi sfi dare con la brutale volontà di non schiodarsi. Mi sveglia un freddo gelido che accresce l’orrenda paura di quel mostro.
5 aprile -Oggi ci godiamo la Pasquetta impacchettati nei plaid
Brutta giornata, vero? Vento, nuvole e freddo. Oggi ci godiamo la Pasquetta impacchettati nei plaid, sotto la finestra a quattro ante che di tanto in tanto, dai vetri, ci offre un po’ di sole quando si decide a fare capolino. Possiamo parlare però, di quelle godute in passato quando,
qualche mese prima del suo arrivo, si sceglieva l’itinerario più gradito e si trascorreva fuori tutto il giorno. Ricordi che goduria? Particolarmente nostalgico è per me il ricordo della Pasquetta all’Argentiera; è legato al riflesso d’argento delle sue scogliere, alla battigia che luccica e imbrunisce sotto le carezze dell’acqua che recupera e perde, al vecchio borgo minerario che si stringe alla roccia in un connubio perfetto e ai legni, diventati puntelli del tempo che ha rubato gli antichi colori. Forse si nascondono lì fate e folletti per preparare sorprese ai bambini e invitarli a giocare con loro nelle notti di luna, quando i suoi raggi disegnano bianchi arabeschi. Forse vi si radunano coloro che ci hanno lasciato, per ritrovare la pace di una notte terrena su luoghi familiari che conoscono la voce del mare, o forse quelle casette di legno sono venute giù dalla luna portando con sé la luce riflessa sull’acqua e l’argento diventato di roccia. E la Pasquetta a Nettuno? Hai memoria? Nei fondali blu le sirene si tuffano per la pesca dei sogni e sulle rocce spruzzate dai colori dell’iride si adagiano nell’attesa di “prede”. Quelle grotte sprigionano una fatale magia; chi le visita ne resta stregato. Vedi, la memoria è un mezzo speciale; non ha ruote né ali; non ti chiede denaro per farti viaggiare e ti lascia comodamente seduto senza farti stancare. Così piazza San Marco ci vede turisti incantati delle sue meraviglie e il Ponte di Rialto, naviganti innamorati delle bellezze del mondo; Firenze, visitatori ammirati della superba città degli artisti e Taormina ci vede passare lontano perché siamo soltanto due poveri cristi. La giornata è quasi finita e la Pasquetta conclusa; siamo stati insieme, seduti vicini, per tutto il tempo del viaggio e abbiamo goduto, al riparo, di qualche furtivo raggio di sole. Tu per tutto il tempo sei rimasto in silenzio, quasi sempre ti ho visto guardare il cielo oltre i vetri, come se avessi voluto continuare a viaggiare magari in groppa alle nuvole, portando con te il profumo e i colori dei luoghi già visti. Credi sia riuscita a procurarti almeno un po’ di sollievo? Con la testa mi fai cenno di sì. Sono felice ma solo a metà.

PARTE SESTA
7 aprila – Non per volerti offendere ma mi ricordi un bruco, infagottato così fino al naso
Non per volerti offendere ma mi ricordi un bruco, infagottato così fino al naso, in questo plaid verde a rosoni puntinati. Un bruco speciale con occhiali e cappellino visierato che, non potendo combattere la calura estiva in riva al mare, si consola in questo modo, “riparandosi” dall’ombra di una stanza. Mi consola che siano i colpi di coda di un inverno freddo, umido e piovoso che si appresta a cedere il passo alle giornate soleggiate, così potrai affacciarti alle finestre tutte le volte che vorrai. Già nelle ore calde al punto giusto ami sederti sul balcone, un po’ per consegnarti al sole, un po’ per restituire agli occhi increduli una visione che da tempo ti mancava. Incuriosito ti fermi con lo sguardo sugli alberi che cominciano a mostrare foglie nuove e sui fi ori accanto a te, nei vasi in terracotta. Come un bambino ti mostri interessato alle formiche che in fi la indiana procedono lungo il paramano e alla cavalletta gigante che guarda immobile dal ramo dell’arancio, mentre terrorizzata, mi allontano in cerca di un manico di scopa che mi consenta, a debita distanza, di interrompere quel suo strano stato di ipnosi e di cacciarla via. Con lo sguardo segui gatti sconosciuti che passeggiano sul muro del giardino o a terra, quando si aggirano sornioni tra le aiuole e si acciambellano come fossero in salotto. Vai col volo dei gabbiani che annunciano la pioggia o col piombo delle nuvole che portano tempesta e con l’ululo del vento che forse, venendo d’oltre mare, ti riporta alla mente qualche viaggio fatto in gioventù. Pretendi di sederti su uno spicchio di gradino, non riuscendo a valutare l’ingombro dei presidi sanitari che ti porti dietro; se provi a camminare dimentichi che il piede deve prima fare l’alzata e se già ti trovi in movimento pretendi di arrivare all’obiettivo col busto prima che coi piedi, allungando le braccia per toccarlo rischiando di schiantarti. Vorrei entrare nel tuo mondo sconosciuto dove hai trovato approdo, leggere i misteri che racchiude e quello di te che a loro ti accomuna. Forse tu ora senti maggiore appartenenza a un mondo diverso dal reale, nel quale ti abbandoni perché lì trovi la tua giusta dimensione, o forse sei arrivato in quella zona d’ombra che ti lascia in preda allo sgomento. Non so come spiegare i tuoi silenzi e lo sguardo perduto chissà dove tutte le volte che non riesce a fissare un obiettivo. Vorrei entrare dalla porta che tu lasci chiusa e visitare i meandri di quel luogo per scoprire la percezione che di me ti resta ancora. Mi turba il pensiero che possa aver perduto tante cose e mi addolora la negazione della speranza nella possibilità di una ripresa che mi consolerebbe, almeno in parte, di quel che ora non ho più di te.

9 aprile – Non vorrei che tu pensassi ora a qualche mia improvvisa sviolinata
Non vorrei che tu pensassi ora a qualche mia improvvisa sviolinata o al panegirico del santo, ma mi corre l’obbligo, oltre che il piacere, di dichiararti la mia riconoscenza per la dedizione, il rispetto e la pazienza che hai saputo sempre dimostrarmi, non disgiunti per la verità da qualche facile contrasto che molto si addice alla mia natura un po’ sanguigna. Posso dire di averti visto in collera con me una sola volta nella vita quando, proprio nel momento in cui avevi bisogno del mio aiuto nel reggere quel famoso specchio in pesantissimo cristallo, con le mie osservazioni fuori luogo ti costringevo a spendere le forze per rispondere alle mie cavolate del momento. Realizzai in quell’istante la portata della mia disgustosa petulanza e bastò quella presa di coscienza per frenare qualsiasi impulso similare. Il ricordo che mi resta mi fa sentire ancora come un verme. Dovrei battermi il petto per tutte le volte che ho perso il controllo solo per inezie e ti assicuro che mi sento umiliata dalla mia tracotanza se faccio il confronto con la tua straordinaria pacatezza. Riconosco che delle tue virtù faccio difetto ma devi ammettere che il mio intuito te lo sogneresti; ma lasciamo stare e torniamo a te. Se i signori della guerra ti somigliassero un pochino non farebbero baratto della vita altrui con vodka e tressette; ma il Potere è una forza che sa di demoniaco e chi lo possiede si diverte nella stanza dei “bottoni” come i giocatori d’azzardo alla roulette. Ci sono guerre che infliggono condanne a fi ne pena mai e interi popoli senza tribunali si consegnano alla morte o tentano la fuga per trovarla altrove. Il Potere poi, non cammina mai da solo; di solito si accompagna col Denaro, e questo connubio diventa polveriera che quando scoppia, com’è già accaduto, riduce a brandelli la nostra economia. L’alta finanza gongola, si sa, comunque vada, ma i poveri cristi, non avendo più di che sfamarsi, per salvare la propria dignità si buttano dai ponti o s’impiccano alle grate. Questo mondo lo sento troppo stretto; è una cloaca immensa a cielo aperto che appesta l’aria e chi è senza colpa è condannato a doverla respirare. Ma tu credi davvero che ci potrà essere una inversione di tendenza? Fino a qualche tempo fa io lo speravo ma ora sento che il mio ottimismo comincia a vacillare. Non ti nascondo che s’insinua in me il dubbio che gli artefici di questo abominevole disegno possano prevedere alcun ravvedimento in un futuro prossimo o remoto. Non vorrei che il Padreterno intervenisse prima a modo suo; in tal caso per colpa dei corrotti nella fossa ci andrebbero anche i giusti, e allora quelli si befferebbero di questi un’altra volta. Ho paura però che la conta dell’Altissimo abbia preso già l’avvio, e lo deduco dal cataclisma economico-politico senza precedenti, dalla dilagante corruzione dei costumi, da terremoti, esondazioni e smottamenti che colpiscono la terra come la ola dei tifosi negli stadi. È chiaro che l’uomo è il solo arbitro di sé e quando sbaglia le sue scelte paga di persona. Forse è giunto per tutti, senza escludere nessuno, il momento di concederci qualche riflessione in questo vortice di melma che ci divorerà come un dragone. Dal canto mio voglio sperare che Colui che tutto vede ci conceda per pietà il tempo che ci serve per fare ammenda delle nostre colpe.

12 aprile – Oggi non posso esserti di grande aiuto perché non sono dell’umore giusto
Oggi non posso esserti di grande aiuto perché non sono dell’umore giusto. Scusami. Sento un vuoto profondo di cui mi è sconosciuta la natura. Stai tranquillo però, non lascerò che mi prenda lo sconforto. Anzi, sai che faccio? Metto vicino a te le gabbie dei criceti. Guarda, in questa c’è Jangh e in quest’altra Fiulingh. Tu potrai introdurre la mano attraverso le finestrelle che ti mostrerò e carezzarli con delicatezza.
Jangh è una pallottolina bianca con due occhietti neri all’orientale, per via della goduria sonnolenta che glieli socchiude quando lo tieni nel cavo della mano. Se ci fai caso, tutte le volte che lo prendi, in qualunque modo tu lo posizioni, lui si blocca in attesa di carezze e quando ti va bene ti fa “plin” per l’emozione. Mi fa tanta tenerezza quando sotto i miei baci si appiattisce come uno zerbino. Dubito della sua felicità intesa in senso generale, perché ha avuto la sfortuna di finire in gabbia insieme a Fiulingh che tutti credevano l’altra sua metà, e invece no. Mi viene da pensare che quando si sente baciato e accarezzato s’illuda che tutto possa venire dall’amata. Ho sempre pensato che dei due fosse il più tondetto perché dorme tutto il giorno, ma non sapevo che gira tutta la notte nella ruota. Nelle ore notturne, del resto come Fiulingh, è molto attivo: trasferisce il nido dal piano terra a quello superiore, lo rinnova nella capacità e nella forma; ne modifica anche la struttura col materiale che ricava dal cartoncino di cui ogni tanto può disporre. È straordinario il lavoro che fa di sfogliatura, che gli consente di ridurre tutto in veli. Quando il nido è pronto, ci si mette dentro e con un’abilità che lascia sbigottiti, si copre fi no a sparire nella maniera più totale. Così dorme tutto il giorno. Credendo di fare ad entrambi cosa gradita abbiamo garantito a ciascuno la sua gabbia, con arredi e spazi nuovi da gestire in modo del tutto “personale”. Ora vivono in piena autonomia che, unita all’agiatezza, se da un lato migliora la qualità della vita, come tra gli umani, dall’altro forse li intristisce la solitudine che sempre ne deriva. Ma si sa, le comodità producono dei costi. Fiulingh è un batufolino grigio-fumo che ama le carezze a domicilio, proprio come un bambino che preferisce stare in culla. Se tu introduci con delicatezza la mano nel suo nido e provi a massaggiarlo dolcemente, si struscia contro le tue dita e ti fa sentire il brivido che prova. È di salute cagionevole e soffre di una forma di rinite che lo fa starnutire molto di frequente. È stato anche sfortunato perché lo shampoo gli ha causato un’allergia che lo ha costretto a una serie di punture. La sua affettività non si mette in discussione come le sue idee e quando ti fa capire che le carezze possono bastare, devi rispettare la sua volontà. Come noi hanno bisogno di tante tenerezze e ci annusano la mano per farcelo capire.
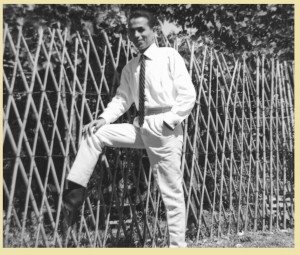
13 aprile – Non so se tu abbia memoria delle stravaganze che caratterizzavano il mio modo di vestire
Non so se tu abbia memoria delle stravaganze che caratterizzavano il mio modo di vestire, perché di quelle che attengono alla sfera del di dentro te ne parlerò un’altra volta. Ricordi le mie pazze idee sui cappellini? Erano di moda ai tempi della scuola e io, che di cucito e creatività me ne intendevo, ne avevo realizzato alcuni che calzavo con orgoglio ai matrimoni, abbinandoli ora al vestito a sbuffo col pannello laterale, ora a quello con gli spacchi tutt’intorno che, se c’era un po’ di vento, svolazzavano come ali di farfalle. Mi è particolarmente caro il ricordo di quel cappellino di velluto nero con una grande rosa laterale uguale nella stoffa e nella tinta, che calzai con i guanti in rete anch’essi neri (mi mancava solo la veletta agli anni trenta) allo sposalizio del tuo migliore amico. La volta fu un trionfo! Non parliamo delle rose che, se non comparivano sul cappellino del momento, fiorivano sul petto o in vita alla cintura; ne avevo di diverse tinte, aperte, in boccio e solo in gemma. E i guantini li ricordi? Ne avevo bianchi e neri in pizzo che sembrava filigrana, e guai a mancarmi nelle grandi cerimonie, come il fazzoletto da naso ricamato a mano che doveva far mostra di sé all’occorrenza. Oggi, come poche cose al mondo, tutti i nasi hanno uguale trattamento: finiscono in un bianco lenzuolino che ha la morbidezza della carta a veli.Il modo di vestire e gli accessori richiamavano la leggiadria di un romanticismo che ormai annunciava il suo declino e le nuove proposte della moda suggerivano invece la praticità. Che tempi! Tutto era all’insegna del saper fare con molta discrezione, senza troppa civetteria o cattivo gusto. Poi è arrivato il tempo dei tacchi a spillo e delle zeppe che mi hanno visto svettare con aria trionfante “quasi” alla pari delle spilungone, regalandomi una sorta di rivincita che la moda mi aveva negato fi no a quel momento.Si cominciava a mostrare anche un pezzo della coscia, cosa che all’epoca faceva voltare i giovanotti, rischiando il linciaggio morale di una società ancora lontana dal “minimalismo”. È stata poi la volta degli abiti fi no alla caviglia, in crespo fantasia, tinta unita, svasati, a tubo o scampanati e degli scialli, enormi, di cui facevo collezione. Ti mancava di reggermi lo strascico tutte le volte che si usciva insieme! Riconosco, in fatto di moda, la mia sregolatezza e oggi l’apertura tua di allora mi sorprende e mi commuove l’assenso senza condizioni. Ricordi i miei variopinti caffettani di foggia musulmana che mi vedevano in spiaggia come turista di passaggio? E le catene, catenine, rosari e cerchi vari che portavo al collo nel tempo che celebrava i metallari? Devo darti atto del buon fiuto: hai subodorato che limitare la mia libertà sarebbe stata impresa dura e con eleganza hai guardato alla modernità sposando il femminismo, forse più per paura di esserne travolto in malo modo che per vera convinzione personale. Nonostante mi rimanga questo dubbio, devo dire molto onestamente che la tua complicità era scudo per la mia innata timidezza e l’ammirazione un tuo segreto che tale non restava più quando parlavi di me in mia assenza.

PARTE SETTIMA
16 aprile – Un quadrato di sole ci accomuna in questo pomeriggio sonnolento
Un quadrato di sole ci accomuna in questo pomeriggio sonnolento.Tu ti lasci vincere dal sonno e io traccio con la biro mille ghirigori sull’agenda, mentre il pensiero corre alle assolate spiagge d’altri tempi. Voglio farlo da sola questo viaggio, piano, per non farti male. Mi vengono incontro le prime rose cardinali che occhieggiano dalla turgida rete, adagiata sul lino della sabbia. I grappoli s’abbracciano alla dune tra sentieri di neve, tracciati dagli amanti del mare in cerca di emozioni e fanno da cornice ad anse e rade di cristallo. La distesa cerulea m’invia, leggera, la sua brezza carica di sogni, confusa col cobalto del cielo più profondo e lo smeraldo che nasce dai fondali. Ed io respiro la vita, la bellezza e l’aria dell’estate che carezza lieve la mia pelle, lasciandovi il profumo umido del sale. Sulla battigia l’acqua trasparente mi ruba la sabbia, con dolcezza, sotto i piedi nudi e m’invita a raccogliere ciottoli e conchiglie che lo sciacquio accende di colori. Mi sento primadonna che si concede alle lusinghe di lamelle che increspano le acque come fossero drappeggi e s’inebria ai profumi dei pini e della macchia. Sono la sirena che scruta le luci degli abissi, ne cattura la voce e strega i naviganti. Sono io, che della bellezza celebro l’incanto e indago la segreta vita di sepolte stive, per dissetarmi a misteri sconosciuti. Gli occhi chiusi, distesa sulla sabbia, torno al Maschio Angioino e al Beato Angelico di Roma, alla Galerie Chardou, a Londra, Philadelphia e Granada, che hanno conosciuto di me la tavolozza; il vermiglio e l’amaranto riaccendono d’un colpo la passione del pennello, col cobalto e l’oltremare faccio un tuffo nell’immenso e ai colori del sole mi abbandono, dimenticando di essere chiusa un una stanza. Le sensazioni tornano vive come nate nel momento e un vortice d’incosciente percezione del reale, di fervore e giovinezza, di anelito supremo della perfezione mi avvita a sé e mi trascina. La forza dei ricordi è una potenza che sa rivoltare al pari d’un calzino e per me diventa sinfonia quando di mezzo ci si mette il sole. Continua sereno il tuo riposo; non voglio disturbarlo. Il viaggio si conclude lasciandomi dentro tanta nostalgia che vela quei ricordi come la nebbia sfuma i contorni delle cose. Torno alla vita reale non senza una punta di amarezza e riprendo il cammino interrotto insieme a te che, se mi ha tolto i colori del pennello, mi mette tra le dita la matita a raccontare di te in bianco e nero. E ti riprende col capo reclinato quando ti abbandoni completamente al sonno, assorto in chissà quali pensieri o gli occhi che guardano oltre i vetri, inseguendo i fantasmi che le nuvole disegnano. Il bianco e nero ha tutto il sapore del mistero; ti affascina e stuzzica, ti frena e ti appassiona, proprio come in questa fortunata contingenza che mi spinge a fissare sulla carta questo scorcio di vita di noi due.
19 aprile – Oggi c’è una novità piuttosto sconcertante. Hai voglia di sentirla?
Oggi c’è una novità piuttosto sconcertante. Hai voglia di sentirla? Qualcuno ti porta i baci di Celeste che dice essere legata a te dai tempi della giovinezza. Si tratta di un tuo tradimento sotterraneo o di un ritorno di fiamma dichiarato così, pubblicamente, per accrescere l’effetto esplosivo della bomba? Conosco questa donna. Ti ha forse incantato il decolté piuttosto generoso? O forse ti ha sedotto la sua intraprendenza o la voglia matta di mostrare le sue grazie senza inibizioni? Sicuramente c’è scappato più d’un timbro! Non si spiegherebbe la passione di ritorno. Come mai mi hai nascosto questa Celestina? E come pensi ora di rimediare a questo affronto? Non mi dirai che intendi ricambiare il messaggio galeotto? Sono furente e, ti avverto, non intendo restare alla finestra. Se non ci sarà una tua inversione di condotta, ti lascerò morire togliendoti l’ossigeno, la cannula e quant’altro. Quel sorriso gabbatore non mi piace proprio e ti consiglio di prendermi sul serio. Non basta il corteggiamento sfacciato di Doriana che sta disgustando gli anni della mia vecchiaia? Tu mi dirai che a questa età la pace dei sensi ci conforta. Non proprio! La proprietà privata resta tale. Ma torniamo a quest’ultima donnetta. Vorrei sapere perché ti lasci baciare sempre tre volte. Forse non hai perso il sapore della “russa” di tanto tempo fa o è la stessa che si ripropone come a tanti stalloni del libero mercato? E poi, la cosa sconvolgente è che ti bacia col risucchio. Tu mi dici che ti dà fastidio ma è una tesi che non avvaloro perché non fai nulla per farglielo capire. E se un giorno decidesse di baciarti anche sulle labbra? Non vorrei vederla con la bocca sulla tua; ti fagociterebbe nel cavo orale con l’avidità di una gallina che becca grano a volontà. Non sai poi quale nausea riesca a procurarmi l’odioso starti sempre addosso con quei seni rubati alle bambole rifatte. Ti rendi veramente conto della mostruosità? Dovresti provare a invertire i ruoli. Se fosse un uomo a fare a me le stesse cose in tua presenza, mi diresti che tanto c’è la pace dei sensi a confortarci? Forse, come minimo, lo accuseresti di pascolo abusivo e non oso pensare le cose che diresti a me, geloso come sei. Ma di questo tuo vizietto parleremo più avanti con dovizia di particolari. Torniamo a lei, piuttosto, che puzza di vino e fumo e viene a trovarti nelle ore più impensate da chissà quale alcova turritana.Vorrei sapere come fai a sopportare tanto degrado senza muovere un dito per allontanarla. Capisco che sei un gentiluomo ma la dignità, dimmi, a chi la lasci? Mi fa imbestialire questa spudorata che ti si attacca come una ventosa; si tratta di mancanza di rispetto sia nei tuoi confronti che nei miei. Vorrei allontanarla in malo modo, visto che non capisce i nostri modi signorili di volerla evitare a tutti i costi, ma probabilmente avrei la peggio, perché ritengo imprevedibili le sue probabili reazioni. Devi darti una mossa per uscirne con orgoglio e dignità e rendermi giustizia.Come possono simili donnette offendere in me cultura e intelligenza?
21 aprile – Nel ’99 cominciavo a lavorare a un’installazione che all’epoca contava venti croci e sei rosari
Sai, mi sembra di essere caduta dentro un pozzo da quando non ho potuto più visitare le mie croci. Le ricordi? La tua perplessità non mi sorprende. Ascolta bene. Nel ’99 cominciavo a lavorare a un’installazione che all’epoca contava venti croci e sei rosari. Utilizzai un arnese in ferro che si articolava in tre pannelli, uniti tra loro da piccole cerniere, diversi per forma e dimensione e tali da consentire qualsiasi ancoraggio per via di una sorta di rete a larghe maglie che ne univa le strutture periferiche. Mi consentiva di applicarvi le croci che realizzavo con materiale da riciclo: vecchie cornici larghe, strette, grezze e lavorate, coprifili antidiluviani, bacchette varie di provenienza sconosciuta, tubi e tubini in ottone e alluminio reperiti in depositi in disuso. Non fissavo i bracci in legno con martello e chiodi, bensì con sottile fil di ferro che avvolgevo più volte al punto preciso in cui gli stessi sono sovrapposti. Ancoravo le croci alla struttura e per meglio fissarle tenevo stretto il fil di ferro con le pinze in una mano, e con le tenaglie nell’altra lo tendevo con tutte le mie forze. “Kosovo Nuova Aschwitz”, questo è il nome dell’installazione, la realizzavo in memoria dei caduti civili e militari della guerra dei Balcani. Ma tante altre guerre vennero dopo e massacri in ogni angolo del mondo, così nuove croci si aggiungevano alle prime e le mie mani diventavano ganasce che senza posa bloccavano e stringevano legno e metallo, riducendoli a quell’unico simbolo di passione e morte che ormai mi ossessionava. Per oltre un lustro ho camminato con i morti, costruendo croci di tutte le misure per i caduti della Palestina e di Manhattan, dell’Iraq, della Cecenia e di tutte le guerre senza nome che non interessano a nessuno. Ho realizzato così la mia “Collina delle croci”; aggrappate a quel supporto nero, come anime abbracciate alla salvezza, se ne contano duecento e settanta sono i rosari dei vivi e dei defunti. Non è solo la moltiplicazione del dolore che abbraccia l’intera umanità. Anche tu mi hai seguito in questo viaggio, e tutte le volte che per noi si è spento il sole, hai segato legni, legato bracci e dipinto di nero il cammino della sofferenza. Forse, inconsciamente, abbiamo anticipato questo nostro presente di disagio grave e di sconforto che ci vede reclusi, legati a una vita di inerzia comandata che scolora tutto intorno a noi, rendendoci straniere le persone conosciute. Forse è stato anticipato il mondo attuale, difficile, confuso, pieno di angosce e di paure che popolano la nostra vita di mostri e di fantasmi. Un mondo di perfetti alieni che quando si toccano accendono scintille, come fa sull’incudine il ferro battuto con il fuoco. I miei passi sono fermi là, ai piedi della mia “Collina” e il mistero della teca rende più forte il suo richiamo. Mi giunge il rumore del silenzio, il senso profondo di un rispetto religioso misto al ricordo dolente di chi non c’è più. Mi manca la mistica visione del devoto connubio di croci e di rosari. A consolarmi resta il flusso arcano che mi lega a questi simboli d’antica devozione.

22 aprile – Nella tua poltrona mi sembri un gran signore
Nella tua poltrona, con la rasatura fresca di giornata e l’ordine perfetto dei capelli, negli abiti composto e profumato, mi sembri un gran signore, di quelli che sanno esserlo anche da seduti, perché la signorilità è un bene di così grande pregio e così raro che chi lo possiede è in grado di mostrarlo in ogni circostanza, lasciando nell’incredulità chiunque abbia la fortuna della vista e dell’udito. Non accade infatti di frequente di imbattersi in persone di provata gentilezza nel relazionarsi, di modi e gesti di squisita educazione; direi che si respira, invece, un’assuefazione generale al turpiloquio, una certa indifferenza verso gesti volgari di ogni tipo e tanta, tanta mancanza di rispetto verso l’altro.
Tornavo dalla scuola a bordo della mia utilitaria, in un caldo pomeriggio di settembre. Dal retrovisore vedo una grossa cilindrata in fase di sorpasso; non rallento perché non ne vedo la necessità, vista la potenza di chi vuole superarmi. Mi sibila a fi anco come il vento e nonostante la velocità, faccio in tempo a distinguere, bene inquadrate dal lunotto, due chiappe bianche e una faccia scalmanata che dal fi nestrino laterale destro esibisce al mio indirizzo un riso beffardo a trentasei. Sento quel gesto come un vile insulto e per tutto il viaggio macino rabbia a denti stretti, immaginando di fare il tiro al bersaglio su quell’obiettivo. Tralasciando certi atti che andrebbero comunque sanzionati, non si può ignorare il mutamento subito dal linguaggio e il frasario in uso, diventato contagioso, che ormai risparmia veramente pochi. Si è perso il gusto della correttezza e della raffi nata eleganza di modi e portamenti che, se anche ci fosse chi ancora li possiede, probabilmente verrebbe giudicato dai più un sopravvissuto e si sentirebbe imbranato a farne uso. Succede per esempio che entrando in ambulatorio o in farmacia in treno o sull’autobus, tutti luoghi dove si prevede che per un certo tempo si debba stare insieme, non ci sia chi risponde al tuo saluto e allora tu che, come ci sei rimasto persona educata non può dirlo, la volta successiva ti guardi bene dal riproporre a chi la disconosce, la tua educazione. Tu mi dirai che il giudizio negativo colpisce chi si rende responsabile di condotte riprovevoli; sarà così, ma come spieghi il disagio che si prova a essere civili? Anche quando minimizzi, a denti stretti sbotti «ho salutato e nessuno mi ha detto manco crepa». Non c’è tuttavia da stupirsi più di tanto; questo è frutto di quanto abbiamo seminato. Viviamo in una società cosmopolita ma, come la gramigna, l’individualismo ne ha contaminato le radici. «Esisto solo io. Tutto mi è dovuto e nulla devo» è lo slogan dell’ultimo millennio. Io paragonerei l’attuale società a un campo compromesso dall’amianto, perché non posso disconoscere il degrado e la pericolosità della deriva. Occorre un risanamento capillare ma temo che questo, se ci fosse, richiederebbe tempi molto lunghi, per cui noi due non avremo la fortuna di goderne.
23 aprile – Stamane ho visto Paul
Stamane ho visto Paul, sai, è ritornato. Ti avevo detto che mancava da gennaio, lo ricordi? Con un largo sorriso mi è venuto incontro; è un vero amico. Gli ho chiesto il perché della sua lunga assenza e, commosso, mi ha risposto di essere andato al suo Paese e la sua donna lo ha stretto a sé, chiedendogli di restare ancora un po’. Paul ama la Sardegna che lo accoglie con benevolenza; lavora qui e si trova molto bene. Non credo sia stato facile però lasciare il Senegal per fissare la dimora, seppure provvisoria, in mezzo a noi; gliel’ho letto negli occhi quando, dopo avergli lasciato l’euro del carrello della spesa che spontaneamente riportava nel deposito, mi ha detto: «Tu sei brava, Anna». Paul espone la sua mercanzia davanti ai grandi magazzini collabora allo scarico merci in cambio dello spazio che gli serve. È discreto. Non invita a comprare la merce. Ti guarda come chi sa di non essere a casa e la propone restando in silenzio. I suoi occhi grandi, neri come la pelle, t’interrogano senza parole e non riesci a passare facendo fi nta di niente. Quando lo vedo seduto accanto al suo metro quadrato di merce, col capo chino a guardarsi le mani, indovino i pensieri di chi è figlio dell’Africa e vive lontano. La nostra tacita intesa prevede che sia lui a segnalarmi il parcheggio, a spostarmi la macchina se è necessario e caricarmi la spesa. Per le feste voglio essere generosa con lui e il biglietto che gli offro lo prende senza esitare, lo porta alle labbra e guarda lontano. La nostra amicizia è nata quando ha saputo che tu non potevi più venire con me e si è sentito in dovere di darmi una mano senza chiedere niente. Nel lungo periodo della sua permanenza in famiglia, quell’angolo vuoto mi appariva triste e banale e temevo che la sua partenza non prevedesse ritorno, immaginando che la crisi colpisse prima chi è considerato straniero. Ricordo di averti manifestato questa mia paura quando mi hai chiesto di comprare da lui un berretto che ti avrebbe consentito l’esposizione al sole con la testa protetta. Paul è alto oltre un metro e novanta. Il tragitto che ci separa dall’auto in parcheggio, a volte anche oltre la strada, la sua falcata lo ingoia in pochi secondi; voltandosi, risponde con una sonora risata al mio tentativo goffo di ridurre il vantaggio: La sua essenzialità non esclude la mia seppure diversa, né la mia libertà è meno precaria. L’amicizia di Paul è per me il vento dell’Africa, il deserto e le dune, le tempeste di sabbia e la terra del sole; è l’infinito che mi affascina e avvolge.

PARTE OTTAVA
29 aprile – Antichi ricordi di stazzi dell’alta e bassa Gallura, dove amavo fare scuola all’aperto
Questa stupenda giornata di sole, il verde intenso e il soave profumo di zagare risvegliano in me antichi ricordi di stazzi dell’alta e bassa Gallura, dove amavo fare scuola all’aperto. Ti ho raccontato altre volte che l’aula era piccola e buia, col pavimento in grigio cemento, un’antica finestrella a due vetri, e le pareti, che conoscevano solo l’approssimazione dell’occhio e non il rigore del piombo, erano piuttosto ondulate. Rimediavo a tanto grigiore tappezzando i muri con i coloratissimi disegni dei bimbi e le loro semplici didascalie. Davanti alla porta qualche vaso fi orito abbelliva l’ingresso: erano i nostri gerani, cui gli scolari non mancavano di dare acqua e concime nella giusta misura e al giusto momento. Insegnavo a far le talee, reinvasare, cimare quando occorreva ed esporre le piantine alla luce del sole perché non “filassero”. Sapevano che soprattutto i gerani hanno bisogno di sole. Si scavavano aiuole i cui confi ni venivano segnati da pietre di piccola pezza che loro stessi reperivano nel tragitto che li portava alla scuola. Non mancavano mai i mazzi di rose o anche semplici fiori di campo da mettere in vaso sulla cattedra annerita dal tempo. L’interno veniva arricchito di qualche vaso fiorito collocato qua e là; il tutto rendeva anche le lunghe e grigie mattine d’inverno serene e gioiose. La nostra era una didattica viva che amava leggere quel libro straordinario che è la natura.Con l’acqua del vicino ruscello i padri abbeveravano i loro animali e dissetavano gli orti; era vita non solo per gli uomini. L’ovile era il ricovero delle pecore durante la notte, dove l’alba attendeva il pastore per la mungitura di rito. Ogni bimbo conosceva la stalla e il perché della raccolta del fieno. Aveva visto come nasce un agnello e sapeva proteggere le pecore gravide; parlava di animali figliati, di paure e contagi, di semine e pascoli. Poteva contare i petali di un fi ore senza andare troppo lontano, conoscere odori e profumi e osservare la perfezione anche del più piccolo insetto. Non distruggeva il nido agli uccelli, né chiudeva le tane degli animali selvatici e sapeva rispettare la fatica delle mille formiche che, come lui, tracciavano sulla terra percorsi che le portavano a casa. La vita a pensione mi consentiva di partecipare anche alle feste campestri e alle serate da ballo tante volte organizzate per me. Si stava dunque insieme anche nelle ore di svago e il canto a chitarra e il ballo di coppia diventavano veri momenti di vita comune. Nonostante conoscessi tante abitudini della gente locale, devo dire che altre non mi erano note e una volta ebbi tanta paura.
Durante la notte, nella stanza dove vivo a pensione, mi sveglia uno strano rumore; a fatica accendo il lume a candela. Sento ancora, sotto la fi finestra, quel botto secco contro la terra battuta. Resto immobile. Volgo intorno lo sguardo sgomento. Le ombre dei mobili che a dismisura si allungano sulle pareti d’improvviso diventano mostri. Il botto ha cadenza quasi regolare. Sudo freddo. Cresce l’angoscia. È il rumore sordo di un palo in caduta pesante. Gli occhi della notte possono vedere solo orribili fantasmi e io li immagino in agguato sotto la finestra. L’idea mi paralizza. Sono un gomitolo di ghiaccio che scruta attraverso una fessura delle coltri quelle ombre spaventose che la fiamma trasforma in orrende creature senza volto, per raggelarmi il sangue e togliermi il respiro. Sulle pareti si muovono ora carponi, come animali avviluppati in orridi lenzuoli, ora eretti, come giganti minacciosi, agitando tuniche e mantelli in preda all’ira. Continua, terribile, il botto cadenzato. Maledico in un tremito d’orrore scuola, pensione e vita pendolare, e rannicchiata sotto le coperte che mi hanno ingoiata come il fumo dalla cappa, aspetto il peggio. Conto le ore di terrore che mi dividono dal giorno. La fiamma, spinta da uno spiffero, consuma la candela tutta da una parte, lasciando nudo lo stoppino e un lungo solco che sembra una ferita, mentre la cera liquida scivola copiosa sul piano del vecchio comodino e si espande fi no a formare un bianca copertura, che, esaurendo la superficie orizzontale, finisce in tante stalattiti tutt’intorno. Le prime luci dell’alba che filtrano attraverso il telaio e la finestra, cominciano a placare la mia angoscia. Quel pauroso rumore non lo sento più. Prima di raggiungere la scuola, ancora confusa mi fermo un attimo sotto la finestra. Vedo che sporge qualcosa dall’intonaco: è un anello di ferro grosso un dito. Alla mia domanda sul perché, il padrone di casa risponde che lì, la notte, legano l’asino e durante il riposo batte il tempo a suono di zoccolo.

1 maggio – È tutto pronto all’Asinara per celebrare il lavoro che non c’è
È tutto pronto all’Asinara per celebrare il lavoro che non c’è. Voglio essere solidale con gli operai di stanza nelle celle. Ci vado e tu vieni con me. Le acque del Golfo sono piatte. Le cale, strette tra le rocce brune, mostrano i colori e la trasparenza del mare di Sardegna. La macchia cela i segreti di una terra che odora di selvatico e d’antico e gli asinelli, padroni incontrastati, ne rivelano le origini che si perdono nel tempo. Asinara. Terra di contrasti e di silenzi, di pena e di riscatto, palcoscenico moderno dei dimenticati che chiedono lavoro. Da oltre sessanta giorni gli operai gridano il disagio diventato ormai disperazione, aggrappati al coraggio come i molluschi s’attaccano agli scogli. Nelle celle carcerarie, assurte a simbolo di chi è prigioniero di schiavismo e sfruttamento e dell’inerzia di troppi governanti incapaci di difendere il diritto, un drappello di uomini grida la sua rabbia contro tutti coloro che vivono di dignità rubata e annegano nel lusso più sfrenato il ricordo sbiadito di impiccati e suicidi che pagano per loro.Per secoli spogliati anche della terra che ci ha partorito, ora prendiamo l’urlo più che la parola per vuotare il sacco delle false promesse, degli inganni perpetrati a nostro danno, dei 70 patti traditi e disattesi, degli sproloqui e delle litanie, tutte armi usate per ferirci, umiliarci e ridurci all’obbedienza da uomini violenti, ingiusti e dissacratori indegni di una società civile. Metteremo radici su questa terra d’Asinara se non ci verranno date le risposte che attendiamo. Le nostre donne e i figli ci saranno di sostegno e divideremo insieme questi spazi angusti che ancora odorano di Mafia. Noi siamo i veri condannati! Siamo in tanti in attesa del concerto, un po’ per smorzare la rabbia che stringe le ganasce, un po’ per dare corpo alla protesta. Sul palco si avvicendano gli artisti, nell’intento di strappare un sorriso ai tanti giovani spogliati del futuro e ai genitori che diventano canuti aspettando un lavoro che non ci sarà. S’intrecciano le voci di chi inneggia a una giustizia che non riesce a mostrare la sua faccia, a chi continua a dire che va tutto bene e alle maschere mostruose di tanti “benpensanti”. Ma la festa del lavoro che non c’è è sotto tono. Già si pensa a quando la ribalta avrà spento le sue luci, al silenzio che calerà sui reclusi senza colpe, al mare che perderà i colori della luce per vestire quel profondo nero che sa gelare il cuore. E intanto i personaggi della “casta” continueranno a far politica nei Palazzi del Potere come al Sud i raccoglitori fanno la battaglia delle arance per la festa del Patrono. Dai, torniamo a casa. Noi due continueremo a guardare a quell’esilio volontario e da questa sponda, come fossimo su una torre di controllo, guarderemo all’altra, con la trepidazione e l’ansia di chi combatte con loro con la forza del pensiero e con la penna.

4 maggio – Non vorrei dirtelo ma ci sono momenti il cui peso vorrei poterlo dividere con te
Oggi è uno di quei giorni che vorrei fosse passato perché l’angoscia mi rende i passi pesanti e affannoso il respiro. Non vorrei dirtelo ma ci sono momenti il cui peso vorrei poterlo dividere con te. Per tenerti impegnato ti porgo riviste e giornali e antichi album di foto ma non posso trattenermi con te a parlare dei nostri ricordi. Oggi no. Con lo sguardo seguo ogni tuo movimento ma sento inibito il desiderio che sempre mi spinge a recuperare anche l’attimo per starti vicino e non perdere più nulla di te. Non posso mostrarmi serena quando mi sanguina il cuore. Tu sapevi arginare le mie inquietudini col tuo sano ottimismo, sapevi trovare la soluzione ad ogni problema e non c’era ostacolo che minasse il tuo naturale entusiasmo. Tutto questo mi manca. Mi guardo attorno e vedo grigia ogni cosa. Non mi sfugge, però, che riesce a farti sorridere la botta in testa presa per una mia distrazione, né il tuo divertito seguire con gli occhi la mia lotta con le formiche che entrano in casa dal balcone fiorito; basta questo per farmi riflettere. Realizzo che valgono molto meno le mie paure e la tristezza che tante volte s’impadronisce di me. Ci sei, e anche dal tuo silenzio sai infondermi coraggio e destarmi da questo oscuro torpore. Ti prendo per mano e ti guido lontano dagli angoli bui, dove tante volte mi fermo immaginandomi sola. Ti mostro la lingua di mare dalla nostra terrazza, i tetti rossi che diradano a valle e le case accese di luci la notte a disegnare un presepe. Incuriosito segui con gli occhi le teleguidate da corsa che sfrecciano sotto casa come le rosse Ferrari. Seduto sotto la tenda ti lasci vincere dalla stanchezza e dal sonno ed io, che a fatica mi trascino oltre il presente, torno nel mio angolo buio a indagare le ombre che si addensano sulla mia vita futura. M’immagino sola a cercare di te tra le cose di casa, chiamarti senza più le parole, a indovinare la tua nuova dimora e la vita che fai. M’immagino stretta nella morsa di antichi ricordi, di vecchie care abitudini, di momenti di vita, delle grandi e piccole cose che costruiscono un mondo. Mi spaventa il pensiero della casa vuota di te, la definitiva assenza di vita che potrei respirare aprendo il tuo armadio o guardando il letto ormai spoglio anche del tuo corpo malato. Forse, la notte, mi sembrerà di sentire ancora il gorgoglio dell’ossigeno e mi sveglierà la paura di saperti vinto da una lunga apnea. L’incubo sarà il mio compagno di letto e l’alba sarà sempre troppo lontana. Il mio cuore stanco e ferito ti cercherà tra le ombre delle stanze deserte e ti chiederà un po’ di calore per l’ultima ruota del vecchio calesse definitivamente schiodata.

6 maggio – La giornata grigia non invita a sedere nel solito angolino
La giornata grigia non invita a sedere nel solito angolino dove ami crogiolarti al sole, perciò possiamo dedicare un po’ di tempo in più agli esercizi di recupero. Capisco quanto per te sia faticoso e comprendo anche il peso delle membra sfinite dai mali che t’inchiodano, ma devi sapere che ogni movimento, per quanto precario e doloroso, aiuta a darti un minimo di autonomia. Non dimenticare che ti aspetta uno straordinario appuntamento: la rassegna sul teatro. In altri tempi la tua collaborazione era un sistema. Eri il mio braccio destro; colui che cuciva ogni tela al suo telaio, spostava e riponeva cornici vecchie e nuove, selezionava materiali e mi forniva vernici e diluenti. Eri il mio corriere e l’assistente, il fotografo, l’esperto e il consigliere e il primo fruitore cui mi rivolgevo per un giudizio sull’opera finita. Per essere sinceri, in principio mi sfuggivi perché dicevi di non sentirti preparato, e ce l’ho messa tutta per farti capire che di fronte a un quadro, chiunque può provare emozioni e sentimenti che non sono meno validi di altri. L’arte non si fa solo per gli esperti. Considerarla un bene per privilegiati è un grosso errore. È pronta già da un pezzo la rassegna, lo sai vero? Attendo solo che l’intelligenza e la sensibilità di qualche rappresentante delle nostre istituzioni vincano la non cultura dell’ostruzionismo e dell’indifferenza che, al contrario, io ho sempre combattuto molto civilmente senza voler togliere nulla a nessuno né cercare vili compromessi. Mostro di me quella che sono: cittadina del mondo ed eremita, schiva e partecipe del vivere comune, pacifi ca e furente a seconda del bisogno. Contradditoria nella mia coerenza, sono clemente e giudice spietata, non perdo di vista la costanza e mi rifugio nel minimo riserbo. La prudenza mi gioca ancora qualche brutto tiro perché, non essendo più di moda, viene immancabilmente scambiata per qualche non virtù. La diplomazia poi mi fa difetto e se provo a forzare appena la mia naturale inclinazione, mi sento un’imbranata. C’è qualcosa che mi guardo bene dal mostrare: il disprezzo per tutti coloro che sanno provocare in me questo sentimento. Non posso farlo. Ne andrebbe della mia incolumità. Non nascondo che mi sento comunque disarmata di fronte a tante insidie e questo mi rende vulnerabile, facendo scattare in me quella diffidenza che nasce proprio dalla consapevolezza di non possedere adeguate armi di difesa. In molte donne ho dovuto combattere l’ipocrisia che aborro per la mia schiettezza; negli uomini, oltre l’odioso maschilismo che ne fa degli essere minori, quella folle spinta che fa correre più d’uno dietro le sottane. Ricordi quella sera al vernissage, quando fui messa sotto chiave in una stanza per sfuggire alle deliranti avance di quel tale? In preda a una profonda alterazione picchiava i pugni sulla porta gridandomi di uscire, e solo dopo alcune ore accettò di lasciare quella Galleria perché qualcuno lo convinse che avevo guadagnato l’uscita secondaria. Devo dire che nel corso della vita ho avuto anche la fortuna di conoscere persone straordinarie. Uomini e donne che della disponibilità hanno fatto una virtù e delle mie debolezze una generosa coltre a mia difesa e altri che, pur procurandomi dolore,hanno voluto incidere la scorza per fare del legno nudo l’arca della mia stessa vita. Vorrei aver dato tanto quanto ho ricevuto e poter riscrivere quest’avventura straordinaria che, se non mi riproponesse i piatti amari che mi ha già servito, le chiederei di offrirmi almeno un’altra chance. Che pensi? Direi che forse è meglio per te evitare le insidie di questo labirinto.
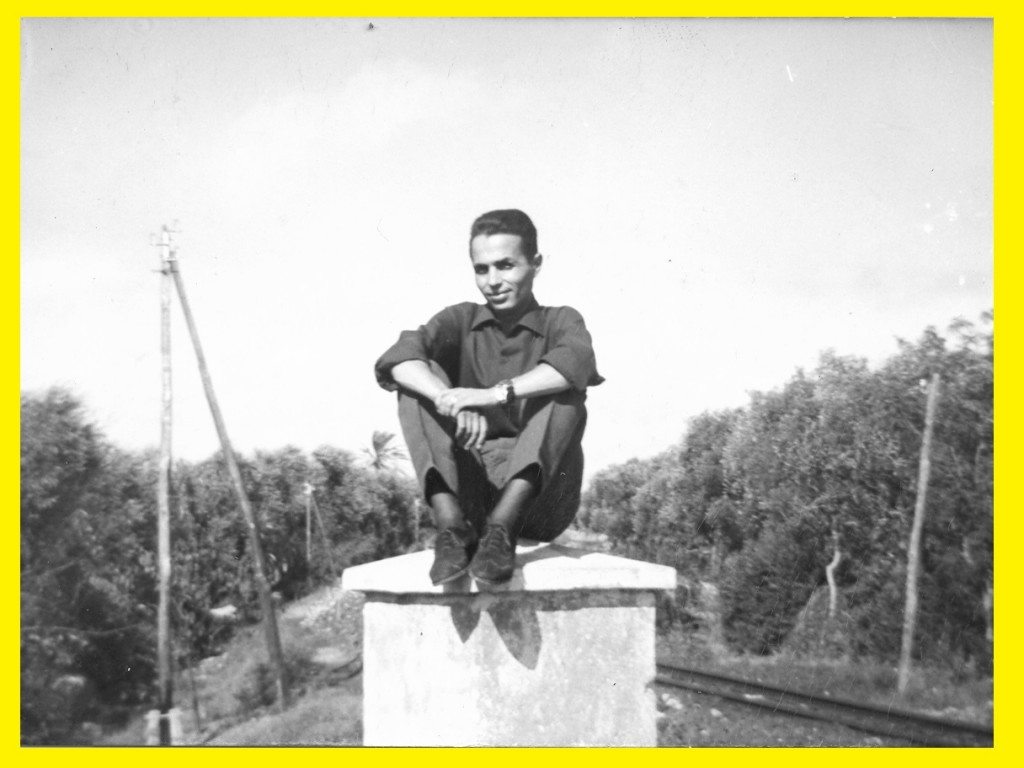
PARTE NONA
7 maggio – Questo maggio piovoso concilia i ricordi
Questo maggio piovoso concilia i ricordi ed io proprio in questi voglio tuffarmi. Ammetto di essere stata troppo ingenua lasciando che il tempo mi cogliesse di sorpresa quando invece avrei potuto batterlo, per risparmiarmi la beffa del rimpianto. Ma, sai come accade. Gli anni della giovinezza per “vincere” il mondo mettono le ali e non conoscono le sottili riflessioni; la maturità è come la marea che ti sospinge a riva e ti riprende, ti culla, di esalta, ma ti stravolge anche di paura, ti aggredisce coi flutti e sugli scogli, ferita, ti abbandona. La mente studia sempre nuovi sistemi di difesa e il corpo lotta contro la furia degli eventi e non pensi mai a quello che sarà fra quarant’anni. Lui, il tempo, ha voluto negarmi le risposte che si attendono dall’ultimo bilancio ed io ora posso fare solo congetture inutili e tardive. Avrei voluto chiederti come hai fatto a dividermi con la passione per l’arte e quella per la penna, perché di tempo ne ho voluto tanto. A volte ho pensato che il tuo atteggiamento di distacco altro non fosse che un consenso elargitomi senza condizioni per evitarti spiacevoli sorprese, considerata la mia natura volitiva; altre, che la tua mitezza e la bontà fossero con la profonda dedizione quell’elisir di lunga vita che, nella chimica alchimistica, diventa il rimedio a tanti mali; altre ancora che la tua fosse un’attesa lunga e paziente come si addice a chi possiede qualità umane più che rare.
Ho anche pensato si trattasse di rassegnazione. Lo penso ancora a dire il vero e la cosa mi procura sofferenza. Ma che vuoi fare, sono così. Credo però di essere in debito con te ma, devi credermi, non saprei proprio cosa fare per ripagarti di tanta generosa umanità. Mi tornano in mente i lunghi pomeriggi passati a spatolare colori, e ti vedo, con passo felpato, che mi vieni a trovare; ti fermi in silenzio davanti alle tele e in silenzio poi te ne vai. Ricordo le tante volte che sei andato a dormire, solo, con la delicatezza di chi non vuole interrompere una stupenda magia, e il tempo che avremmo potuto passare a raccontarci la vita. Ma sono certa che tu, ormai diventato un esperto, la leggevi attraverso le tele; respiravi l’aria gioiosa e serena della natura che volevo inoffesa, la sofferenza nei volti di emarginati ed esclusi e le tante tragedie del mondo. Questo devi averlo di sicuro capito: l’arte per me è stata la passione che mi ha dato le ali. Mentre scrivo, come allora mi guardi senza parlare ma ti leggo negli occhi tante mute domande. Ti chiederai se ricomincio da capo per ripetere cose già dette, e se davvero ti poni questa domanda, ti rispondo di sì. Se col pennello sono stata poco incisiva, bene, ora mi affido alla penna. Ma sai, a volte mi sento la pala di un vecchio mulino che, avvitandosi all’aria, s’illude di produrre qualche beneficio improbabile.
Magari pensi che mai finirò di usare penna e pennello, nemmeno quando lascerò questo mondo. A questo non avevo pensato. Che farò nella nuova dimora? Forse potrò dipingere l’aria con piume d’uccelli, catturando la trasparenza e il profondo blu dello spazio; userò i colori del sole affidandoli al vento per disperderli come polvere d’oro in siderali distanze. Sulle tele, alla terra lascerò il ricordo della natura brutalmente violata, di tanti volti ti uomini e donne che gridano rabbia e dolore e di milioni di bimbi diventati resti di guerra. Su gabbie di ferro lascerò impresso il nichilismo del mondo. Dipingerò sinfonie celestiali rubando la luce alle stelle e della loro armonia vestirò l’universo. Con lo stelo di un fiore che la brezza leggera porterà fino a me scriverò cascate di versi in canti di giubilo. Ma chissà tu dove andrai. Ed io dove sarò.
10 maggio – Stamane imploravo la tua collaborazione
Stamane imploravo la tua collaborazione mentre con le ultime forze strattonavo le calze perché superassero il tallone. Ho l’impressione che tu possa adagiarti sulla convinzione che il tempo abbia stretto un patto diabolico con me, assicurandomi eterna giovinezza in cambio di che cosa non saprei. Questo me lo fa pensare, in varie circostanze, qualche dettaglio che francamente non mi sfugge, e la dice lunga il sorriso che mi accenni quando evidentemente centro l’obiettivo. Quella di fermarsi almeno per trent’anni è una richiesta che gli feci quando ne avevo venti in meno; poteva andarmi bene, visto che per tutti ne dimostravo meno dieci, e avrei firmato l’accordo a occhi chiusi perché mi sentivo ancora addosso l’agilità di una gazzella. Mi chiese in cambio di rendergli tutte le cose belle che mi aveva dato fino a quel momento e di sottoscrivere un’ipoteca sul futuro che rispettasse la lunghezza d’onda. Insomma, voleva spogliarmi dell’identità e oscurare gli anni che ancora mi restavano. E che senso avrebbe avuto la mia vita senza più passato? La stessa domanda me la posi per gli anni che avrei vissuto da “novizia”.
La proposta non mi piacque e l’accordo non ci fu. Lui mi avrebbe lasciato la bellezza che sfioriva, che avrei potuto mostrare come bandiera a chi invece gli anni li contava senza sconti. In quella proposta non riconobbi più il vecchio amico, il complice e il compagno, il saggio consigliere che tante volte mi aveva evitato di commettere errori grossolani, ma un’entità che non mi apparteneva. Gli dissi no e mi ripresi gli anni.
La nostra amicizia non è messa in discussione ma deve sapere che non mi spaventano le rughe né la paura della sua rivalsa. Mi ha privato della libertà, è vero, ma con la forza del pensiero so combattere anche chiusa in una stanza. Non saremo mai nemici; se sono viva è perché ha voluto risparmiarmi e devo dire che gli sono grata per avermi insegnato che ogni sosta della vita è un sicuro investimento per la salute dello spirito.
Ma, torniamo a te. Come stamane, altre volte mi hai guardato quasi con sorpresa e negli occhi lucidi ho visto balenare una luce antica. Era come se mi avessi scoperta in quel momento. Non posso pensare che la tua mente abbia cancellato il ricordo dell’età intermedia, sovrapponendo a quella attuale l’immagine del volto mio di allora. Voglio credere che il tempo per te abbia fatto un’eccezione. Forse ha voluto compensare il torto che ti fa a tenerti prigioniero, facendoti dono di qualche visione straordinaria delle mie sembianze d’una volta. Magari accade che un’improvvisa luce cancelli le mie rughe e inturgidisca labbra e gote facendomi apparire ancora giovinetta. Non sarà così, però il modo di guardarmi che tu hai, anche a questa età mi fa un certo effetto e mi lusinga. Non escludo dunque che il mio nuovo aspetto, per quanto virtuale, possa procurarmi ancora qualche ammiratore d’eccezione. Oh, scusami, dimenticavo che un tempo eri geloso! Mi facevi il terzo grado se ti capitava di vedermi da lontano in compagnia di un collega o se un amico si tratteneva a parlare con me in occasione di un incontro di cultura. Non lo dico per volerti offendere e poi, il “terzo grado” è solo una battuta. La tua gelosia mi faceva un po’ sorridere perché, non volendola mostrare, giravi con eleganza intorno all’obiettivo, convinto che anche le domande non dirette potessero sortire l’effetto da te desiderato, senza mettere a nudo l’amor proprio. Ed io, con la vaghezza delle mie risposte, stavo al gioco, per il piacere sottile e malizioso di saperti tormentato. Forse è questo ricordo che accende il tuo sguardo di quella stessa luce.

14 maggio – Un collega mi disse che noi donne siamo superiori
Tanti anni fa un collega, forse perché “interessato”, mi disse che noi donne siamo superiori. Tu che ne pensi? Conoscendoti, credo proprio che non sia d’accordo. Eviterei di porre l’argomento in questi termini, semmai comincerei col dire che non siamo uguali. Vi riconosco la concretezza e la praticità ma noi sappiamo vedere molto più lontano ed è per questo che le nostre previsioni sono quasi sempre veritiere. Ti faccio qualche esempio. Se provi a nascondere una certa verità accade sempre che ti sfugga qualche traccia, sulla quale poi io cammino fi no a raggiungere il traguardo. Non so se ti sia mai accorto, ma un uomo con me è sempre sotto osservazione. Non mi sfugge il senso di una sua domanda, di un mancato appuntamento o di un impegno disatteso. L’incertezza e il nervosismo hanno sempre una lettura, come pure l’eccessiva gentilezza inaspettata o fuori luogo. Amo la chiarezza e la pretendo anche se qualche volta potrebbe farmi male e non tollero che venga tradita la fiducia che invece concedo a piene mani. E nessuno provi a deludere le mie aspettative! L’uomo, diciamoci la verità, non va per il sottile, di conseguenza gli sfuggono i segnali che dovrebbero tener desta l’attenzione. Di solito cerca di correre ai ripari quando i buoi sono usciti dalla tanca. Non parliamo dell’inutile chimera che rincorre a tener dietro alla donna che ha deciso di lasciarlo. Di sicuro è per sempre quando è lei che se ne va; se è l’uomo a farlo, di solito ritorna. Lei mostra maggior fermezza nelle decisioni e forse questo può farla apparire più sicura. Lui non accetta il vantaggio e la combatte. È una guerra aperta che da tempo ha cominciato a far paura, e se sul fronte del lavoro e della parità, lei è perdente, nel rapporto di coppia si impone anche a costo della vita. Sono del parere che la morale non debba essere di genere e lo stato di diritto solo di una parte. L’omologazione non è nelle mie corde, semmai mi piacerebbe che ci fosse in tutti una buona dose di equilibrio. Inoltre, la “diversità” dovrebbe essere un valore aggiunto. Ma, torniamo a noi. Il modo che hai di affrontare la realtà non sempre concorda con il mio. Ricordi la qualità del tuo intervento nel tentativo di sfrattare un pipistrello che si era introdotto nella nostra camera da letto? Ti vedo sorpreso. Ti racconto. Si era d’estate e il caldo eccessivo imponeva di dormire con la finestra spalancata. Io riposavo già. Mi svegliano d’un tratto le sventagliate tue col battipanni, nell’intento di cacciare il volatile che penzola, come una bolla di muffa, dalla volta. Il mio urlo di terrore non serve a fermare il gioco alla racchetta. Mi seppellisco sotto le lenzuola. Sono di marmo. Ti urlo di fermarti; di darmi il tempo di uscire dalla stanza, ma tu imperterrito continui a sventagliare saltando come un canguro dietro a lui. La luce accesa complica le cose e il pipistrello, che non trova la fi nestra, salta da una parete all’altra facendomi vento con le ali. Nei suoi voli incrociati sfi ora le lenzuola quando perde quota. Mi paralizza il sibilo proprio su di me. L’ultimo urlo, diventato roco come quello di una donna in pieno parto, annuncia la cattura e la morte del povero animale. Col battipanni l’hai incollato alla parete. Credo non occorrano commenti.
16 maggio – La vicenda della giovane infermiera che si lascia morire
La vicenda della giovane infermiera che si lascia morire per rivendicare il salario è una delle tante riportate dalla stampa e dai tg nazionali.
Non fa più notizia lo sciopero della fame e la donna si fa prelevare ogni giorno quel sangue che i suoi aguzzini le rubano, togliendolo ai figli. È l’orrore in diretta che dura il tempo di un pasto. Poi tutto torna normale. Una normalità diventata sistema. Anche a me, sai, capita, di perdere la voglia di parlare e il tempo non ci aiuta col cielo grigio che stende un velo bruno sulle cose, quasi a voler esprimere condanna. Vorrei pescare tra i ricordi quelli gioiosi che potrebbero almeno per un giorno aiutarci ad essere sereni, ma si fa più fatica quando non c’è sole perché, mancando la sua luce, non si accendono i colori e più forte diventa la tristezza che ti prende pensando agli orrori della vita quotidiana. Forse il tempo usa questo sistema per invitare ogni tanto a fare qualche riflessione e invece ci si affanna a cercare alternative alla fatica di pensare. Una giornata soleggiata, inviterebbe a correre incontro alla gioia di un’uscita fuori porta, o ad una passeggiata tra le dune vestite a festa dai colori della primavera. Il calore e la luce di una stella non può che invitarci all’abbandono. Se provo a fare una veloce analisi degli avvenimenti, mi pare di cogliere la volontà di proiettarsi verso tutto ciò che può allontanare la mente da fatti contingenti che rendono complicata e tante volte assurda questa nostra vita. Di qui la voglia dello sballo di giovani e adulti. Ci si orienta verso situazioni estreme in cerca di una felicità che non esiste o, se vogliamo dirla in altro modo, di quella serenità che ci deriva dall’essere in pace con noi stessi. Chi fa questo tipo di esperienze sa di non trovare quel che cerca, pur tuttavia, non riuscendo o forse non volendo indagare il proprio Io, persiste in una scelta che certamente non gli giova perché, premendo il “pedale”, necessariamente deve inserire la marcia superiore. Sono convinta che ciascuno di noi sia un universo e, come nell’universo che tutti conosciamo, ci siano tante cose da scoprire quante quello stellato ne contiene. Non ci basta la vita per conoscerne i segreti e noi perdiamo tempo dietro le chimere. Sappiamo che la ricchezza fuori misura non può dare la felicità, semmai procura sofferenza e morte a quanti sono stati defraudati dalla nostra avidità, e questa grave colpa poi si paga. Così come sappiamo che lo sballo non risparmia ai giovani delusioni e sofferenze ma gliene procura di peggiori. Se invece provassimo a visitare questo nostro Io, tanto unico quando misterioso, scopriremmo un labirinto di spazi e vuoti pieni, di angoli bui investiti dalla luce, di archi e ponti che incoronano distanze e di fi umi che traghettano il dolore verso nuove sponde. Conosceremmo di noi un’altra identità, quella segreta che sa nutrirsi di ideali per quella straordinaria aspirazione nata insieme a noi, che ci rende creature superiori. Non si sentirebbe la voglia spasmodica della trasgressione e di stare sempre in vetrina a tutti i costi, né ci si lascerebbe prendere la mano dalla cieca cupidigia di gloria e di denaro. Forse non ci tormenterebbe l’angoscia che deriva dal disprezzo della vita fi no a volerla sopprimere con una leggerezza che sconvolge. Volevo pescare tra i ricordi quelli gioiosi per allontanare la tristezza e invece sono caduta dalla padella nella brace trascinandoti con me. Sarà perché siamo arrivati allo sciopero del sangue e non si può restare indifferenti. Forse siamo diversi da coloro che sono capaci di cotanto orrore e non sappiamo darci pace sentendoci impotenti. Si dice che la parola ferisca più della spada e, stando ai fatti, che siano dette o scritte non fa differenza. Ma allora, perché i fi umi non riescono a sortire alcun effetto? Se puoi, dammi una risposta. Ti concedo tutto il tempo che ti serve. Ho voglia di sentire un tuo giudizio; non mi consola essere sempre il solo interlocutore di me stessa.
30 maggio – Pronto per la colazione?
Pronto per la colazione? Col nuovo grembiule parigino mi sembri un distinto sommelier. Devo dire che il salto di qualità è stato eccezionale: sei passato dal grembiule veneziano, vezzosamente allacciato sui due fi anchi, a quello della famosa attrice nei panni della cara Natalina e infine all’esclusivo Caudalie. Immagino l’importanza che ti dai. Inutile dire che la cosa diventa contagiosa perché un conto è prestare tutte le attenzioni ad un comune assistito di provincia, altro è farlo con chi sale alla ribalta in modo così inaspettato e clamoroso. In principio mostravi una certa ritrosia a indossare questo tipo di indumento, ritenendolo troppo femminile; ora è diventato più che un accessorio di cui mostri tutta la fierezza. Sarà perché i tempi sono cambiati e sono mutati i ruoli o forse l’antica passione per l’arte culinaria te l’ha fatto amare tanto da desiderarlo nei modelli più esclusivi, secondo la moda del momento. Se il Caudalie venuto da Parigi ti dona la dignità del sommelier, il berretto di Paul con visierina, del pescatore ti dà tutta la fierezza, specialmente quando i polpacci sono nudi per via del pediluvio giornaliero che devo farti nella salamoia. Coi piedi a bagno e i pantaloni che si fermano al ginocchio, mi pare di vederti sugli scogli, pronto a lanciare esca e amo con la canna che non c’è. Il grembiule quadrettato, alla gaia Natalina, con i volant cuciti alle spalline, il tascone addominale con la mela rossa in bella mostra e l’allacciatura con fiocchetto posteriore, è quello che mi fa sorridere di più perché mi sembra di vederti da bambino. Il Caudalie nero lungo al ginocchio, con l’uva amaranto nel quadro pettorale, ti dà l’austerità del francese mescitore di vini e di champagne, ed io mi vedo al tavolino di un rinomato ristorante parigino, dove mi versi lo spumante nel calice di finissimo cristallo che la rosa rossa appena sfi ora, sulla candida tovaglia di preziose finiture. Il pescatore senza canna mi è più familiare; lo vedo vicino al mio naturale modo di sentire. In punta di piedi entro nel suo mondo, ne accarezzo i pensieri semplici e sinceri che mi riportano alla schiettezza di una volta e alla fatica di inutili remate, quando era il mare in tempesta a dettare le sue leggi, costringendolo all’ormeggio con la chiglia ancora vuota. Lo vedo chino sotto il solleone a ricucire sullo scafo stinto le ferite aperte dagli scogli e dei remi le pale spaccate dalla furia delle onde. E rivedo tra i fl utti minacciosi le mie mani che cercano le sue, nell’estremo sforzo di raggiungere la riva. La vita ci viene risparmiata ma negli occhi è impressa l’orrida visione degli abissi neri. Quell’ansa pietosa accoglie ancora i nostri scafi speronati dai marosi, che mostrano al cielo i visceri sconvolti. E siamo qui, su questa sponda, a misurare distanze che gli anni non hanno consumato e a raccontare vite parallele che giocano l’ultima partita sul fi lo dei ricordi. Di quell’ansa solitaria, rammento la purezza dell’acqua che lambiva la battigia come la pennellata sbava sulla tela, le rocce rosse e la sabbia bianca come lana di bucato stesa al sole. Ancora respiro i profumi intensi di erbe antiche sempre familiari in quell’estremo lembo di levante che ci vide approdare e conobbe di noi gli anni della giovinezza. Ascolto di quel mare sinfonie che arrivano da mondi sconosciuti, dove le note scritte sulle onde le pizzica il vento col fruscio delle ali. Il distinto sommelier, ancora fasciato dal suo elegante Caudalie, si lascia vincere dal sonno, sognando di servire vino e champagne a dame e cavalieri dei rinomati ristoranti parigini.
PARTE DECIMA
5 giugno – Vedo che il “Gran Concerto” riesce a farti saltare la consueta pennichella
Vedo che il “Gran Concerto” riesce a farti saltare la consueta pennichella. Sai, piace anche a me e non solo per i brani musicali accuratamente scelti per soddisfare i gusti dei bambini e magistralmente eseguiti dall’orchestra, ma anche per i personaggi, interpreti straordinari che fanno sognare i piccolini. Se poi fai caso al conduttore del programma capisci che davvero è incomiabile il coinvolgimento che fa della platea. Segui bene. La scena musicale ora appartiene alle “Valchirie” nella famosa “Cavalcata” che Wagner ha composto per esaltare la bellezza e la maestosità delle mitologiche fanciulle che, nella religione dei Germani, accompagnavano gli eroi morti in battaglia nel Walhalla, oltretomba dei privilegiati. I cavalli alati, che sembrano uscire dal mondo delle fiabe, sono evanescenti quasi come l’aria e la leggiadria delle Valchirie sospese sulla sella, ne esalta tutta la bellezza. Procedono maestosi tra i guerrieri armati fi no ai denti che si affrontano nella mischia a sciabolate. Il ritmo impresso dallo scontro delle armi, si perde nell’aldilà delle anime elette, dove non la morte in guerra conta, bensì le qualità naturali dell’eroe, che di sé nel mondo dei vivi diffondono l’essenza. Questa, ben nota alle Valchirie, ne cattura il cuore e nel giardino della somma felicità colloca il caduto. Il nuovo eroe volerà in sella ai cavalli e si unirà alle danze sinuose delle mitiche fanciulle. Ora il conduttore propone un nuovo brano musicale. Vedi, l’ippopotamo e lo struzzo ora interpretano la “polka in volo” dell’altro grande musiista che è Strauss. Prova a immaginare, tenendo gli occhi chiusi, di metterti a ballare mentre voli. La tua sarebbe una polka senza fine come senza fi ne sono le vie dell’aria, e come lei sarebbe leggera e trasparente, tanto da renderti quasi invisibile alla gente. La musica ha il potere unico e incredibile di sollevarti dal mondo del reale e farti muovere su un piano superiore, dove non arrivano a toccarti le miserie della vita. È per eccellenza il linguaggio universale che unisce Popoli e Paesi; il percosso, il soffiato o il pizzicato può passare a porte chiuse e raggiungerti anche dove tu non sei. Può raccontare storie mai scritte e vite mai vissute, degli amori rinnovare le puntate e costruire cattedrali di cristallo in deserti di sabbia o negli abissi; può farti superare in volo le montagne e rubarti il pianto per stendere oceani di speranza, strappare il velo grigio della scena quotidiana per tessere arazzi alle pareti e sciogliere i colori per farne corde di violino. Ora l’ippopotamo e lo struzzo abbandonano la scena e la “polka in volo” si dilegua tra stelle e palloncini colorati che racchiudono i sogni dei bambini come lo spartito le note di una musica. Il miracolo del suono nasce sulla carta per sciogliere il mistero in vibrazione e canto. Ci pensi mai? Una scrittura che non è scrittura, che si articola in segni di misura e di valore, capace di offrire inni al Creato e interpretare ogni supremo anelito di noi.
12 giugno – Oggi è in lutto la carta stampata
Oggi è in lutto la carta stampata. Vedi? Osserva la fascia nera accanto al titolo di prima “Legge bavaglio, torna la censura”, e poi in seconda “I giornalisti si ribellano”, e in terza “Per l’informazione cala il sipario”. C’è tanto da leggere. Non ti annoierai. È un momento buio questo per l’Italia, in cui trionfano oscure manovre in Parlamento. La legge bavaglio arriva nel momento in cui è meglio si lasci cadere un menhir a chiusura di una cloaca di proporzioni tali che la Maxima dei tempi romani, al confronto, sarebbe cosa da poco. I nuovi, come i vecchi corrotti, sembrano personaggi usciti da un girone dantesco, dove il Caronte di turno li traghetta dalla propria poltrona al sofà del complice amico. Mi torna in mente la fascia nera di mussoliniana memoria che gli uomini portavano al braccio in segno di lutto, quando veniva a mancare qualcuno della famiglia. Era segno di morte. E oggi sono in tanti a provare quel cupo sentimento che accompagna un valore perduto. La libertà di stampa è stata mutilata, il diritto all’informazione messo dietro le sbarre e la giustizia costretta in una camicia di forza in nome del privato di ogni cittadino che non ha mai interessato nessuno. Tutto questo per far passare sotto silenzio le malefatte di tanti “criccari”, dei beneficiati da “pietosi samaritani” più o meno conosciuti, dei lobbisti che manovrano tanti fantocci seduti sugli scranni. Ci si serve sempre dell’esatto contrario per avvalorare tesi false e bugiarde, sostenute da coloro che sono preposti alla ricerca del bene comune e invece perseguono vigliaccamente solo i propri interessi. Al potere non occorre l’uomo informato né il giovane istruito o l’onesto cittadino. Le masse popolari devono possedere muscoli forti e scarso cervello perché il loro ruolo è del subalterno assimilabile allo schiavo. Dovremmo accendere i lumini dei defunti all’interno delle scuole, dove muoiono i diritti dei bambini e dei giovani senza più speranze; tra le rotative dove s’impone il massacro dell’etica e della professione; nei tribunali dove si umilia la giustizia e nelle nostre case dissacrate dalla negazione.Ma dove sono gli Italiani? E le coscienze? Che risposte danno le coscienze dei giusti allo scempio che si fa del diritto, all’impunità assicurata ai criminali e all’iniquità di leggi e manovre che rubano lavoro e futuro? Il mio tormentato monologo, sai, resta un inutile sfogo se tu non partecipi. Forse, se anche tu dicessi la tua, si placherebbe un po’ la mia indignazione, almeno per quel senso di condivisione che può nascere da una conversazione comune. Tra i corrotti della Prima Repubblica c’era chi si vergognava davanti agli onesti, abbassava lo sguardo e si sparava alla tempia e chi, per la stessa ragione, lasciava l’Italia; oggi non esiste più la vergogna, quella urlata in faccia ai tanti ladri delle miriadi di “cricche” da chi non sa più come vivere. Nella Seconda Repubblica, che doveva essere quella trasparente e pulita, nata per cancellare gli indegni, chi si toglie la vita non è colui che si è arricchito sulla pelle degli altri, ma il disoccupato senza futuro, il padre di famiglia che il lavoro l’ha perso e il giovane che soccombe al male di vivere che nasce dall’orrenda visione di tante brutture e dall’indifferenza di chi è responsabile. Chi puzza di vite rubate è meglio leghi al collo un macigno e si lasci affondare dove sono più profonde le acque del mare. Qualcuno dirà che forse è opportuno si pensi alla Terza Repubblica che spazzi via il lordume che ha insozzato il volto e l’anima di uomini senza morale; è vero, si pensi al cambio. Già scalpita, pronta, la schiera dei nuovi sciacalli.
16 giugno – Ce l’hai fatta a superare la barriera del suono!
Con questa tua lettera finalmente mi hai dato la chiave di quella porta che ritenevo ormai chiusa. Ce l’hai fatta a superare la barriera del suono! Sei andato a ritroso fino a ritrovarci ragazzi, misurando in sei righe soltanto il tempo che ci ha portati fin qui. «È tutto uguale», concludi, «come allora e anche di più». La parola, frenata da rugginosi ingranaggi, che le hanno strappato la voce, ha saputo restituirla la mano con segni che restano. Questo testamento speciale che mi fa depositaria dei tuoi tanti segreti, mi giunge in un momento di particolare sconforto e per ciò straordinariamente gradito e di profondo sollievo. Ho la sensazione di aver ritrovato qualcosa che avevo perduto; forse la ruota di quel vecchio calesse che non voleva più saperne di andare e invece ancora qualche giro lo fa, aiutandomi a trascinare il telaio. Sento la mia commozione, seppure di natura diversa, molto vicina a quella del centravanti coreano del nord ai mondiali di calcio, con la differenza che lui è giovane e forse per questo non resiste alle lacrime; io invece, un po’ per rispetto all’età un po’ per evitarti qualche probabile trauma, le trattengo ma a stento.
Sei tanto contento di quello che hai fatto che ogni tanto mi guardi e sorridi e riesci anche a distrarti dalla partita di calcio che in circostanze diverse, sportivo così come sei, non ti avrebbe permesso di distogliere un attimo gli occhi dal video. Il vecchio calesse riprende il percorso che aveva interrotto; l’andatura non sarà come allora, quando superava in una specie di danza a sobbalzi ciottoli e fossi; ora c’è bisogno di tanta cautela e il passo incerto richiede più frequenti stazioni. Mi va bene così. Quel che conta è lo spirito che non conosce declino e anche quando sembra più spento è solo apparenza; è come sopito, e anche così vigila e sente. Non esiste soltanto la certezza su base scientifica ma c’è “l’altra” che appartiene al mistero, e io conto molto su questa. Lo sguardo ha una straordinaria potenza: sa guardare oltre ogni confine sensibile con una luce cui non rendono giustizia gli aggettivi più belli. È come se oltre quel limite gli obiettivi non esistessero più o ce ne fosse uno solo che sfora ogni spazio,e lo sguardo ne catturasse tutto l’insieme. In quegli occhi c’è molto di più della luce dell’anima. Ora che hai rotto il silenzio io divento cocchiera e tu il vice seduto a cassetta; non so quanto potremo andare lontano ma di sicuro il viaggio sarà più gaio e sereno. Cominceremo con riprenderci la libertà di non misurare più i giorni e le ore e non per voler fare torto all’amico ma perché lui, il tempo, l’abbiamo misurato abbastanza negli anni. Gli abbiamo consentito di concedersi a gocce anche quando la sete ci stringeva la gola e di fare della nostra andatura una corsa ad ostacoli che non prevedeva mai un traguardo finale. Ma lui, nella sua doppia natura, se da un lato ci negava ogni sosta, dall’altro rideva di noi che per rispettarlo tante volte si finiva al tappeto. Ora siamo noi a decidere quando e dove sostare o riprendere il viaggio, scegliendo un ritmo adeguato ai nostri bisogni. Le corse non c’interessano più; lasciamole a lui. La strada impervia non ci risparmierà scossoni e cadute ma vedrai, sarà un divertimento continuo perché sembreremo due zombi che gattonano nel tentativo di rimettersi in piedi.Tu, cercando di rialzarti, ti aggrapperai a me come il naufrago s’attacca al relitto ed io, per tirarti su, mi abbraccerò alla ruota e se il tuo peso, che abbondantemente supera il mio, mi farà ruzzolare, non ridere della comicità non voluta di una inevitabile scena. Quanto a me devo dire che, quando questo accadesse, vorrei sotterrarmi allo sguardo incredulo dell’equino sgomento. Vedi, il nostro corpo, che appartiene alla vita sensibile, ha bisogno di questa, per rialzarsi dopo tante cadute, ma lo spirito no; non ha bisogno della stampella, né della ruota o del telaio del vecchio calesse, ma di quella dimensione dove il tempo non si calcola più.
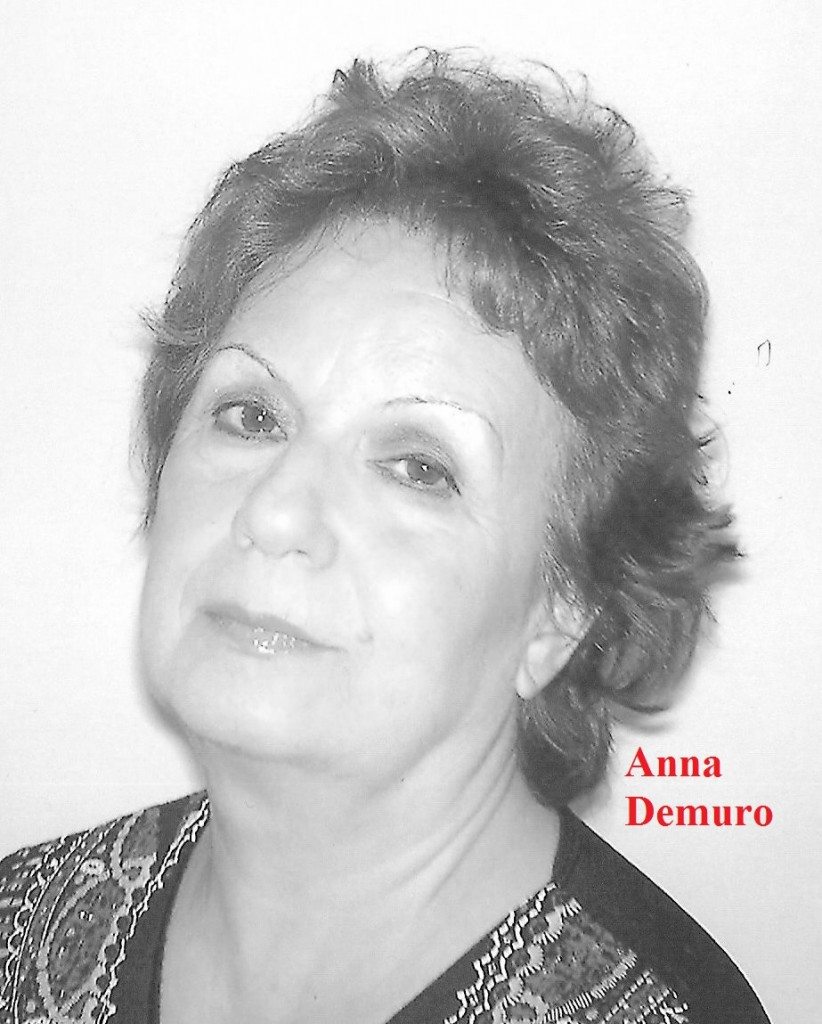
PARTE UNDICESIMA
18 giugno – Coscibianca la mitica e il re Trappadè
I gabbiani in volo sul centro abitato annunciano pioggia, vero? Li vedi là, sopra i tetti? Sembrano in visita sulla nostra città. Prova ad esprimere un desiderio e loro lo porteranno dove tu lo vorrai. Ora però, mentre pensi, mi preparo a fare la solita cosa. Per ritagliarmi qualche scampolo di tintarella, nelle calde ore del primo pomeriggio, mi espongo come vedi, ai raggi del sole in questo quadrato lontano da occhi indiscreti. Guarda, indosso il costume come fossi in spiaggia, così posso far cambiare colore a quelle parti del corpo che, per ovvie ragioni, si tengono sempre nell’ombra.
Dal ginocchio in su sono di un biancore che ricorda tanto quello di una donnina della Sassari antica, che amava la vita di strada; una sorta di barbona dell’epoca che, su questo o quell’altro gradino, non badava alla compostezza dello stare seduta e mostrava senza volerlo, l’alta gamba bianchissima tanto da farsi attribuire un nomignolo tutto speciale. L’hai conosciuta anche tu; ed entrambi abbiamo conosciuto l’amico. Non ricordi? Erano Coscibianca la mitica e il re Trappadè.
Che tempi! Lei indossava gonne scure lunghe al polpaccio, calze nere fino al ginocchio e un ampio scialle con frange che l’avvolgeva tutta fino alle chiappe. Non ho mai visto i capelli, inghiottiti da un fazzoletto sbiadito annodato sotto il mento, che le cocche nascondevano fino a metà. Non ricordo le scarpe, ma il colore non era certamente diverso né diverso poteva essere il pregio. Teneva in mano una specie di piccolo sacco a mo’ di borsetta. Non ho mai saputo che ci fosse là dentro. Associavo la sua immagine a quella della mamma del sole, che andava in giro nelle ore di punta a rastrellare i bambini che non volevano fare il riposino del pomeriggio. Le passavo lontano e, forse per soggezione o forse per oscura paura, mai ho pensato di darle fastidio, cosa che invece facevano in tanti. Trappadè era tutto un poema! Ricordo i piedoni intrappolati in una bolgia di pezze di vari colori, misure e spessore che finivano poi in scarponi di barche coi lacci pendenti che fungevano da frusta agli insetti. Il primo pastrano con lembi di varia lunghezza, ne nascondeva altri più corti e di foggia diversa, che si intuivano dalle sdruciture di quello a cappotto. Ho il vago ricordo di un borsalino scuro e variamente “ammaccato” che gli nascondeva buona parte del viso. L’andatura da ventre pesante aveva bisogno di gambe allargate, e qualche occhio di grossa pernice doveva fargli vedere le stelle. La camminata era lenta e l’alta statura, col suo ondeggiare, faceva pensare ad un rovescio sicuro. Coscibianca la mitica e il re Trappadè forse, per vivere in pace, hanno scelto la strada perché amavano la luce del sole invece delle stanze segrete; e le brutture degli uomini si nascondono là, dietro i muri di pietra. Forse sotto gli stracci si nascondeva una sensibilità mai conosciuta e, sia pure in modo così sconvolgente, hanno voluto celarla perché non ci fosse chi si curasse di loro. Nessuno doveva sapere chi fossero quei due che, rifiutando una normalità di sostanza e d’immagine, amavano tanto la vita da volerla vivere nella libertà più totale. Valgono forse di più i sepolcri imbiancati? Forse entrambi hanno sofferto pene d’amore e il sentimento negato ha giocato il suo jolly trasformandoli in menestrelli senza mandolino né canto. Bastava l’intesa e la comune scelta di vita a guidarli per i vicoli della vecchia città, dove ritrovavano nella penombra e negli angoli bui quella pace altrove negata; e insieme parlavano di storie passate, di affetti perduti, di giochi d’infanzia, di corse e risate. Coi ciottoli di porfi do e nero basalto dividevano confidenze fatte di sogni di bimbi di giovani amori, di lacrime e sangue, di indifferenza e abbandono; e sotto gli archi dei vicoli antichi sognavano fate leggiadre che carezzavano i loro capelli e tanti folletti che, nascosti sotto i pastrani, li scaldavano nelle notti di gelo. Sui gradini di sempre, tra la gente che passa e non vede, lo sfavillio delle luci e i lampioni di vecchie strade complici e amiche, parlavano di Natale e stelle comete, di pastori e capanne e forse anche di Dio.
20 giugno – Non voglio rassegnarmi all’idea che tu possa non parlarmi più nemmeno scrivendo
Aspetta, ti metto un po’ di profumo come ultimo tocco e ti accomodi con le gambe distese sul letto a poltrona.Guarda, sulla tua destra c’è una penna nuova di zecca e l’agenda con una consegna per te. Leggila e vedi di dare risposta. Non vorrei che il tuo comunicare si fermasse a quell’unica lettera, e insisterò su questo perché non voglio rassegnarmi all’idea che tu possa non parlarmi più nemmeno così. Non ti chiederò sacrifici superiori alle forze però il tuo impegno lo esigo.
I coinquilini criceti hanno appena fatto l’igiene e l’altalena alla ruota ed io riprendo il racconto di quello strano diario cominciato proprio l’otto di marzo. È una nuova avventura; viviamola insieme. Aiutami a portare a riva il nostro pescato e a raccontare dei pesci più belli che ci sono costati maggiori fatiche, quando le lampare erano le sole compagne delle nostre lunghissime attese. Chissà se la barca ci consentirà ancora di prendere il largo. Le rondini intrecciano voli in questo specchio di cielo a più ante e le tortore tubano sul tetto dei vicini di casa, che tu distrattamente sorvoli con gli occhi, per fermare lo sguardo tra i ciuffi di lana di un cielo ventoso che non vuole saperne di fare spazio all’estate. Anche quando il sole non c’è e questo quadrato si spegne, ci fa compagnia la quotidianità delle cose: il tuo silenzio assordante con cui ho imparato a convivere, l’orologio a parete che batte i secondi, il gorgoglio dell’ossigeno dentro l’ampolla e il fruscio dei roditori che del tubino di carta fanno lembi di nido. Sulle mensole a muro ci sono libri di scrittori e poeti che amo rileggere per sentirmi viva e partecipe di un mondo che, come la musica, imprime il suo fascino sulle pagine scritte. Siamo sempre in vantaggio in questo quadrato di sole che nella bella stagione è invaso di luce e d’inverno s’illumina della fiamma del nostro speciale camino. Non ci mancano, come vedi, riviste e giornali che però tu sfogli soltanto, limitandoti a leggere qualche notizia che riguarda lo sport. E c’è la tivvù sempre accesa. Per starti vicina mi sono rassegnata a pensare, leggere e scrivere con lei nel cervello, che funziona da trapano e a rinunciare a tante trasmissioni importanti per sorbirmi, come in questo periodo, i mondiali di calcio; io, che divento sportiva di parte solo in occasione dell’incontro finale. In quel giorno, sempre che a vincere sia la squadra italiana, mi associo col pensiero allo schiamazzo e ai cortei, strombazzo e sventolo anch’io il tricolore, diventando una delle tante pedine che questo sport così popolare muove a comodo suo. Se devo essere proprio sincera vorrei che questi mondiali li vincesse il Sudafrica o, comunque, una squadra del continente africano, Quei ragazzi sono umili e schivi, non amano stare in vetrina né giocano per bramosia di denaro. Per loro vorrei questa gioia. Poi c’è il nostalgico amore per l’Africa, terra di estremi contrasti; dai ritmi avvolgenti di antiche culture, dai colori di fuoco, d’ocra e d’avorio; terra di deserti e di dune, di carovane e cammelli, di eterni silenzi e d’infinito. E l’altra Africa, fatta di solitudini antiche, di guerre e massacri, di fame, di abbandono, di fughe, di niente. Ora però, torniamo a parlare di noi. Oltre lo sport t’incanta la musica, quella leggera. Non ti perdi un programma.È tutto qui il tuo mondo. Lo accetto e comprendo. Ora che sei vinto dal sonno posso guardarti a lungo senza essere vista, meditando sul rosario che non scorre di un grano tra le dita inceppate. Così puoi stare per ore se le mani, in caduta, non ti svegliano scuotendoti un po’ per poi riprendere il via e tornare a incepparsi. «Dammi un rosario e dimmi come si recita», mi chiedesti anni fa, quando ancora potevi farmi sentire la voce. E sei puntuale ogni sera. Ti si chiede di pregare per questo e per quello e tutti si raccomandano a te. Tu, instancabile, rispondi alle richieste di tutti senza mettere in conto che le forze ti vengono meno. Anche nella tua condizione c’è bisogno di te e tu non dici di no. Ora che ti sei svegliato voglio chiederti qualcosa per me. Se ti capita di vedere, ancora in vita, Colui che tutto comanda, digli che mi sono fatta anche male per rispettare il Vangelo; che tenga conto di questo anche se i risultati non sono quelli che si aspettava da me. Del resto, il vecchio calesse è ancora legato al telaio e se una ruota ha perduto il cerchione, l’altra l’accompagna spianando la strada. Digli che con questo non voglio pretendere di andare in paradiso accompagnata da suoni di tromba ma mi piacerebbe che mi convocasse solo come anima informata dei fatti.
22 giugno – Scarabocchi, parole e pensieri pescati nel caos
Guarda, voglio mostrarti scarabocchi, parole e pensieri pescati nel caos, frammenti di idee, righe, segmenti, triangoli e cerchi e tutto ciò che la mano disegna nella libertà più totale, mentre cerco di afferrare nel turbinio dei ricordi le cose di cui mi piacerebbe parlarti. Tutto emerge all’insensibilità del reale, al di là del pensiero che nei labirinti della mente sotterranei e confusi, sottrae agli angoli bui tracce di vissuti remoti e le consapevolezze del tempo presente. Sono geometrie irregolari disancorate e indistinte che pian piano prendono forma e diventano pagine scritte. Come le note di un pentagramma, i caratteri si aggrappano a linee continue e il loro scorrere, pur nella semplicità, diventa per noi una musica che connota in modo inusuale l’attesa della notte e del giorno. Raccontano ritmi, voci, rumori, lontananze e silenzi, caroselli di stagioni e battaglie perdute, fiori, colori, cobalto di cielo e tantissimo mare. Vanno per vie sconosciute e segrete, abbracciano il rischio e delle strade impervie affrontano pericoli e scansano ostacoli, superando dirupi e greppi scoscesi. Progettano viaggi, soste e capannelli di piazza e si accompagnano al tempo per ridere di scivolate e sfortune e consolarsi di disincanti e sconfitte. Raccolgono voci sommesse e risate beffarde di sciacalli che vanno via cavo e la disperazione e le lacrime di chi scava fango e macerie che hanno sepolto anche i ricordi. Cercano una normalità che ha cambiato colore, denunciano un sistema che difende il colpevole e condanna chi il male lo combatte ogni giorno, rivoltando le pietre di un diffuso sentire che di ogni schema fa saltare il rigore. Raccontano semplici cose e balzelli che rendono difficili i giorni, nuovi “salassi” e promesse di lotta, resistenza e cortei che fanno della nostra vita un inferno a stazioni. E parlano di te, di me, delle cose che tu non sai dire e del fiume di parole che tante penne traghetta a queste pagine scritte. Sono segni scomposti di corazze e armamenti costruiti a propria difesa nel marasma globale; ferite chiuse e segmenti di vita che vanno a singhiozzo come la penna che perde e ritrova l’inchiostro mentre scorre sul foglio.Ridono e piangono a seconda della sorte e del vento, nascondono emozioni e verità dolorose, condannano, assolvono e abbracciano la speranza di una nuova coscienza. Di sé non fanno mistero le strane strutture: mostrano angoli e punte, parallele, trapezi e cristalli di vetro caduti per caso, disegnando trasparenze nel loro musicale fluire. Ripescano lontananze di nebbia e rumori ovattati di memorie passate per restituire al presente, sia pure nelle tinte fisse di una tavolozza incagliata, la consolazione di colori mai spenti. Dall’assurdo quei segni traggono sostanza, per confluire nell’essere e determinarne l’essenza più profonda che dell’esistere vuole essere ragione.
23 giugno – Deroca Modea è una donnina pienotta
Ascolta, ti racconto una storia vera. Deroca Modea è una donnina pienotta; i capelli lunghi quasi sempre divisi dal grasso cutaneo, non conoscono taglio; li lava una volta ogni tanto, asciugandoli al sole. Porta sempre una sottana di troppo che sborda, lasciando vedere ora questo ora quello di tanti pizzi stinti e sdruciti, vecchi di anni tanto che non si riesce a indovinarne il colore. Solo d’inverno porta le scarpe che trascina sui ciottoli come tavole rotte perché sono più grandi del piede, diventato un membro della “coppia allargata” che l’estate la vive in totale
libertà. L’azzurro degli occhi sembra un pezzo di cielo ancorato al passato come un pesce tenuto alla lenza. Cammina curva un po’ per stanchezza, un po’ per l’età; si ferma ogni tanto per riprendere fiato, divaricando le gambe per meglio bilanciare il suo peso e porta ai fianchi le mani in un gesto consueto di momentaneo riposo. La si sente camminare sui ciottoli dei vicoli antichi e chiamare a gran voce ora uno ora l’altro dei figli. La vedovanza precoce ha accresciuto i disagi di una famiglia che già viveva una situazione precaria ma non le ha tolto il coraggio e la grinta che ne fanno una madre vigile e attenta. Deroca Modea vive in un sottano umido e freddo e fa parte di quella schiera di poveri che nessuno mai vede, perché non fanno schiamazzo né sono avvezzi a comportamenti violenti. Le sue ripetute richieste di una casa adeguata sono state ignorate; eppure tutti conoscono il buio, la muffa e i pezzi d’intonaco a terra che rendono quella stamberga un luogo di pena. Non si hanno mai occhi per vedere chi veramente sta male e la dignità è un valore che pochi conoscono. Lavora a ore presso alcune famiglie nel tempo che i fi gli passano a scuola. Solo allora la si vede calzata. Fuori orario deve risparmiare le suole. L’istruzione ha per lei un grande valore e mai accetterebbe che i fi gli ne fossero esclusi. A scuola infatti sono sempre puntuali ma diversi dagli altri scolari nel grembiulino che manca come nei vestitini dimessi e negli strumenti didattici che possono solo ammirare sul banco del vicino compagno. Nell’ora della merenda deglutirebbero solo saliva se qualcuno, a turno, non offrisse loro metà della propria porzione. La sazietà è una condizione che forse non hanno mai conosciuto e la magrezza, con gli occhi, parla di uno stomaco solo a metà. Col posto alla mensa almeno un pasto sicuro lo avevano ma i tagli alla scuola hanno tolto anche questo. La scuola, sempre oggetto del primo e più totale massacro: le si toglie tempo, qualità, cibo e istruzione. E quando le cose si mettono male per i nostri ragazzi, allora si dice che la scuola deve farsene carico. Quante volte ci si riempie la bocca dei diritti negati all’infanzia! Quante parole! Quante piene di pseudo coscienze, mostruosamente insozzate dall’ipocrisia più sfacciata, sfondano ponti e barriere e tutto portano al mare! Si parla sempre della “civiltà del terzo millennio” e della “globalizzazione” dei mercati che assumono dimensione mondiale; ed io voglio parlare della “globalizzazione delle sottocoscienze” che ai poveri assicura l’inferno per regalare paradisi a chi di questo è la causa. Deroca Modea si contenterebbe di una casa moderna in cambio di un tugurio malsano che d’inverno conosce solo il tepore di un braciere di ruggine che, se da un lato può dare l’illusione di poterti scaldare, dall’altro avvelena i polmoni. Per il resto può bastare anche il pane, non escluso il raffermo che qualche famiglia le passa perché non basta quello che compra. Lei non avrebbe pretese come non ne hanno tutti quelli che come lei sono vissuti nel poco e della povertà conoscono tutte le facce. Dividerebbe il poco pane con chi non ne ha perché solo i poveri sanno capire.
26 giugno – Considera che la crisi è totale, perciò non poteva non colpire anche il mondo del calcio
Parliamo un po’ dell’incontro Italia-Slovacchia che ci ha annegati già nel primo girone come non accadeva da oltre trent’anni. Cerca di fartene una ragione e considera che la crisi è totale, perciò non poteva non colpire anche il mondo del calcio. Ti fa male, lo so, perché il pallone è stato la tua più grande passione, però può consolarti l’opportunità che è stata data all’Italia di suonare trombette. Quel moscone ronzante, entrato nel nostro cervello, potremo tenerlo quanto vorremo perché ora le trombette sudafricane le producono anche nel nostro Paese e ciò, per “qualcuno”, potrebbe infonderci un sano ottimismo. La disfatta dei nostri, sono certa, non ti impedirà di continuare a seguire i mondiali perché i veri sportivi, e tu certamente lo sei, non si lasciano abbattere fi no al punto di rinunciare al consueto appuntamento serale con lo sport del cuore. La ragione della sconfitta non è certamente attribuibile al disagio di una situazione economica dei nostri ragazzi perché, come tutti sappiamo, godono di un trattamento direi scandaloso. Credo piuttosto che i primi diventino gli ultimi tutte le volte che si supera ogni misura, compromettendo così un sano equilibrio. Con la nuova stagione calcistica, sulla falsariga dei mondiali in Sudafrica, gli stadi saranno dei bugni, un po’ per consolarsi della gloria perduta, un po’ per esorcizzare la paura che questa vergogna possa ripetersi. Nel panorama italiano così variegato, mancava il disimpegno della nazionale di calcio che offrisse di noi al mondo un quadro completo. Tu stesso hai potuto vedere che non si è trattato di mancata fortuna, ma di un gioco privo d’azione e di cuore, indegno dei campioni del mondo. Chi, come noi, seguiva l’incontro in tivvù, ha sofferto anche per i grandi sportivi che hanno seguito gli azzurri fi n là; sul loro volto si leggeva un grande sconforto per un sogno andato in frantumi e una passione presa a legnate con la ferocia di chi non è riuscito a vincere neppure una volta. La tua delusione mi fa tanto male.
Avrei voluto per te, in questo particolare momento, la soddisfazione e la gioia che sarebbero derivate dal passaggio del turno. Conosco il tuo passato di bambino e adolescente sportivo che a pallone giocava con grinta e passione. Quando, da adulto, ti sei limitato a seguire il calcio solo in tivù e a sostenere, come socio, la squadra della nostra città, ho potuto apprezzare in te fedeltà ed entusiasmo che durano ancora. Ora gli sportivi italiani, orfani della squadra del cuore, dovranno scegliere una nazionale diversa e tifare per lei sino all’incontro finale. Tu mi dici che per te non c’è nessun’altra. In questo messaggio a singhiozzo così lapidario, colgo incredulità e delusione profonda per un sogno carezzato da sempre e perduto in pochi minuti. L’assenza totale di qualunque commento, anche minimo, durante tutto l’incontro e la risoluzione finale, mi rende difficile l’argomentare di attacco e difesa, di rigori e porte violate. Mi fa male saperti legato all’impossibilità di esprimere con gesti e parole anche soltanto la rabbia in un momento in cui avresti potuto dare sfogo a questo sentimento pulsante. Qualunque cosa aggiungessi a questo mio impietoso monologo, mi sembrerebbe inopportuna e banale. Si potrebbe cambiare discorso.
Prova a pensare al bruco cinese che sta “globalizzando” lo sterminio dei boschi con la sua mascella vorace o alla violazione di tombe, per strappare ai defunti anche l’ultimo dente che possa essere d’oro. Il degrado morale è una realtà inquietante. Davvero mi sembra di vivere in un mondo sconvolto dal male.
PARTE DODOCESIMA
3 luglio – Ora, con “Geomagazine”, andiamo per mare
Ora, con “Geomagazine”, andiamo per mare. Guarda la magnificenza di questi fondali! I colori non sono diversi da quelli che già conosciamo ma qui possiamo ammirarli tutti nello stesso momento, nelle straordinarie armonie che naturalmente sanno creare e nei superbi contrasti.
Sono i colori degli abitanti del mare che fluttuano nella trasparenza dell’acqua e offrono del mondo sommerso uno scenario fiabesco.
Guarda guarda quella colonia di pesci! Formano un vortice di grandiosa imponenza nel movimento congiunto di migliaia e migliaia e, quando sono attaccati dai predatori, a raggiera schizzano via come schegge d’argento. E le signore Meduse! Sembrano splendide dame dagli ampi cappelli che amano sedurre esibendosi in danze sinuose. I coralli rossi sono filigrane di sangue abbracciate agli scogli e i bianchi trine da sposa preparate per lo sposalizio del mare. Le razze dall’ampio mantello puoi vederle ora nel moto radente ora, celate sotto la sabbia, mostrarti un occhio di pietra appena velato. Il cavalluccio impettito, dall’alto della proboscide a trampolo, plana con l’occhio su pesci superbi che si gonfi ano a palla, e altri indiscreti che gli fi utano il “ricciolo”. Osserva, ci sono specie che più che animali sembrano fiori! Pensa che lo Spirografo, che ondeggia alle correnti marine come un fiore al vento, nel passato fu confuso con questo, prima che ne venisse riconosciuta la sua natura animale. Sai che le Spugne sono chiamate gli “architetti” del mare?
Puoi ammirarne di quelle a forma di coppa con la superficie esterna così lavorata da ricordare i soprammobili di vetro pregiato tanto di moda nel periodo liberty. E i Radiolari sono i “costruttori” di veri gioielli. Nel “Sole a cristalli” sembra quasi che dal centro siano state generate trasparenti capsule sferiche catapultate poi per forza centrifuga: i raggi sono l’effetto di una straordinaria “esplosione” di cui l’obiettivo pare abbia fermato l’immagine proprio in quel preciso momento. Nessun artista è mai riuscito a costruire qualcosa di simile. Sai, nel fantastico mondo sommerso esistono anche gli “ingegneri” del mare, costruttori di strutture silicee, sistemi rocciosi, atolli e imponenti barriere. I “rami” e i “ventagli” s’intrecciano ricamando nell’acqua preziosi arabeschi e i “fili di seta” si legano ai tentacoli dei “polipi” espansi in una danza che scivola lenta tra Pennatule e Alghe. Dalla straordinaria simbiosi dell’inerzia e del moto, di creature vive e fi ssi sostrati e dalle schegge di luce che l’acqua tramuta in tremolii di lamelle, nasce la sinfonia del mare che, cullando le onde, si dissolve con esse nei silenzi abissali. Come le distanze spaziali, il mare custodisce il mistero che operazioni dissennate di uomini ciechi seppelliscono nell’arbitrio e nell’avidità più totale. Non ci sono parole per esprimere sdegno e condanna. Nel Golfo del Messico sotto il catrame si è fermata la vita e la nera marea porta a riva solo grumi di pece che parlano di distruzione, di impoverimento del mondo e di estrema barbarie. Sai, mi torna in mente un’opera da me realizzata da almeno un decennio. Rappresenta il mondo con Continenti e Oceani che, spegnendo i colori, imbrattai di nero con un gesto impulsivo, quasi nervoso, che a distanza di anni ancora mi lascia perplessa. Anticipavo l’orrore.
9 luglio – È tornata l’estate, la nona dal ricovero che ha segnato il tuo doloroso declino
È tornata l’estate, la nona dal ricovero che ha segnato il tuo doloroso declino. Ai primi giorni di angoscia che ci vedevano annaspare nel buio, ne seguirono altri che rivelavano pian piano l’entità del danno che avevi subito. Il tempo, nel suo fluire dinamico, l’avevamo perso di vista: aveva sottratto a te qualunque interesse alle cose di sempre e a me prospettava una vita di custode della tua infermità. Ma lungo il percorso che lui mi ha tracciato ha predisposto per me delle piazzuole di sosta che mi consentono di scrivere pagine di un libro altrimenti impossibile. Seguire il tuo passo significa entrare nel vivo di un corpo sganciato dalla concreta realtà del suo equilibrio e dal gioco dinamico di qualsiasi movimento, percepire la paura che irrigidisce le membra e l’angoscia che può derivare dalla consapevolezza di non farcela più. Significa cadere insieme perché la disabilità non può far credito mai. È successo questa notte appena passata: ti tenevo per mano per controllare meglio il tuo equilibrio quando, come un’anguilla, mi sei scivolato battendo pesantemente la testa contro uno spigolo; mi hai trascinato con te e siamo fi niti a terra col tonfo di due sacchi ripieni. Io me la sono cavata con una contusione al ginocchio ma tu hai riportato una ferita che ha richiesto l’intervento del pronto soccorso. Seguire il tuo passo significa vivere nel terrore che possa succedere ancora, eppure ho il dovere di darti fiducia anche lasciandoti per qualche attimo solo, in nome di quella speranza che ogni infermo accarezza. Significa “origliare” per sentire il respiro e quando l’orecchio non basta, seguire il movimento lieve del petto. È come star di vedetta e dell’imprevedibile fare un compagno di viaggio che però vorresti tenere sempre come un cane alla cuccia. Camminare con te significa anche vedere, al mattino, che mi aspetti sveglio perché ti aiuti ad alzarti, che mi tendi le braccia e mi saluti con gli occhi, vederti contento di guardare le nuvole e il cielo sereno, il sole e la pioggia, e di consumare la colazione già pronta con i biscotti che piacciono a te. Significa cogliere sguardi che non sanno più domandare e carezze senza parole né gesti, osservare il tuo sonno, il riposo e l’inerzia forzata, il tremore della mano che vorrebbe afferrare il bicchiere e si blocca a mezz’aria tra il piatto e la bocca già aperta a ricevere il cibo. È l’attesa inutile quanto pietosa di sentire la voce che dia forma a parole e pensieri; è vedere gli occhi e la mente smarriti nel caos di suoni che, nel loro primitivo gioco di sintesi, non si ritrovano più. È lo smarrimento che leggi sul volto quando le gambe, inchiodate, mostrano di non sapere più come muovere i passi e le braccia tese a cercare un appiglio diventano una richiesta drammatica che non comunica più.
Allora ti accorgi che le tante ambizioni coltivate nel tempo hanno perso valore; le priorità diventano altre; magari quelle che avevamo relegato all’ultimo posto, dando per scontato che non fossero soggette a revisioni di sorta. Intanto ti senti crescere dentro, giorno per giorno, la voglia di vivere così come sei, con quello che hai, diventato improvvisamente importante e anche di più, oltre la comune logica di una vita normale. Cominci a fare progetti diversi, legati alla qualità della vita che potresti offrire a chi ha bisogno di tutto e riscopri sentimenti e valori forse sopiti o fi niti sotto il velo bruno di un antico smeriglio. E ti ritrovi a coltivare la sottile speranza di una concessione del tempo, che ti permetta di avanzare richiesta di usucapione del diritto alla vita per averla sempre e comunque amata per il suo immenso valore.
13 luglio – Ci sentiamo un po’ traditi
Sai, faccio delle riflessioni forse un po’ tardive. Se proviamo a fare un viaggio a ritroso nella nostra vita, vediamo tanti momenti di amarezza vissuti a tormentarci perché l’altro o l’altra ha deluso le nostre aspettative. Ci sentiamo, come dire, un po’ traditi. Scatta ferito l’amor proprio e l’orgoglio cresce come la gramigna; il muso lungo dura tre giorni, quando va bene, oppure settimane. Per fortuna il buon senso ci ricorda che la cosa non è poi tanto grave e si fa pace. Passano gli anni.Tornano i “momenti” e tu non riesci a capire perché non si è imparato.
L’amarezza diventa cosa d’altri tempi e cede il posto alla rabbia, sentimento molto meno delicato. Le sfuriate sono la nuova manifestazione del nostro disappunto ed essendo il prodotto di un approccio concitato, l’effetto non può essere che un botto. La riconciliazione, come tanti problemi aritmetici, può presentare diverse soluzioni e non manca, in questa fase, la comparsa di qualche compromesso. L’età che avanza, pare complichi le cose, tuttavia cominci a capire che, come i frutti, abbiamo tempi diversi di maturazione e ti ritrovi ad essere da cogliere mentre l’altro è ancora acerbo, e viceversa. Così il tempo ti accompagna, come può, tra gli strilli che mandi e quelli che ricevi, e se succede solo questo è merito del mitico buon senso che ha salvato tante situazioni. Ma la vita è un’altalena: uno vola quando l’altro spinge. È vero che il brivido e l’ebbrezza sarebbero del primo, sempre che mantenga i nervi saldi anche quando la paura pare voglia sciogliere le viscere, come fa il ragno con la preda, ma il merito è soprattutto del secondo che sa fornirti il carburante. Certo, la cosa più bella sarebbe poter volare insieme; ma dove s’è mai visto che l’altalena di famiglia non prevede l’alternanza? Passati i primi ‘anta, ci si combatte a muso duro mal sopportando che a poco sia servita la scuola della vita e domandandoci se l’età anagrafi ca sia un’invenzione della macchina del
tempo. Ma questa sarebbe solo una delle verità perché l’altra potrebbe addurre a sua difesa che della vita non sappiamo niente finché abbiamo tutto. Solo al “tramonto”, quando è vicina l’ora del riposo e l’animo si dispone alla quiete, quando il treno è passato e tu hai perso tante coincidenze, solo allora puoi ripercorrere in serenità i momenti della tua “giornata”, dando a ciascuno il giusto suo valore. Comprendi finalmente la banalità del contrasto e della divisione, del dissidio e dell’intolleranza e riesci a valutare quanto ci si guadagna a cogliere la vera essenza della vita senza lacci né lacciuoli che tolgono il respiro. Il fatto è che abbiamo la tendenza a renderci tutto molto complicato, come se la semplicità fosse un disvalore, e la corsa contro il tempo diventa il giro vorticoso di una giostra che, se da un lato può darci l’illusione di saper volare, dall’altro, senza pietà, la vita ce l’accorcia. E la saggezza è l’ultimo piatto che ci vien servito, quando saranno solo i ricordi a tenerci compagnia.
Sarà perché ci si vuole consolare di quei voli in giostra che non possiamo fare più.
16 luglio – Ci sono giorni in cui devo combattere le mie contraddizioni
Ci sono giorni come questo, in cui devo combattere le mie contraddizioni. Una cupa solitudine accompagna le mie ore togliendomi
tutto, anche il senso delle cose e visito la casa quasi cercando quello che mi manca. Lo sguardo si disancora da una realtà indifferente e scivola
inerte su ogni appartenenza. L’ordine statico dei soliti percorsi è come un abbandono e nella steppa dei pensieri non trovo acqua che disseti.
Non la mia relegazione è causa dell’aridità di queste ore come di altre, ma la tua, e la mansuetudine che accompagna la tua infermità non può lasciarmi indifferente. La tua totale accettazione m’impone delle riflessioni e la docilità della risposta ai tanti incitamenti è disarmante. Vedo più gravi le mie debolezze e sminuire la mia stessa vita. Direi che non mi aiuta a guardare oltre il dolore la mia natura incline a meditare i fatti del mondo che tingono di nero i nostri giorni, né possono farlo le vicende di tanti personaggi che dietro la maschera di “servitori dello Stato” nascondono il volto immondo di pseudouomini spregevoli quanto inverecondi. Rifletto sulle loro donne, sempre al sicuro da invadenti paparazzi e telecamere nei loro regni da nababbi a dividere il bottino, nei sollazzi e nella vanità, i cui miasmi arrivano fin qui. Medito sul degrado morale di una società che partorisce mostri di rivoltante cinismo e avidità, che tutto vorrebbero farci credere legittimo in nome della più torbida delle “trasparenze”. Sento la voce degli schiavi che, per volontà di questo o quel Paese, rimbalzano come palloni da un piede all’altro di putridi “padroni”, per languire in sotterranei maledetti, moderne foibe
dell’ultimo millennio. E c’è la politica dei “Cesari” che rivolta come calzini Popoli e Paesi col solo “ideale” di accrescere gli “Imperi” personali. La violenza fa da padrona nei portoni come sulle strade, nei Palazzi del Potere come nelle Chiese, servita per marchiare lo spirito e la carne di bambini, disabili e adulti rimasti indietro nella Storia, che ancora ripongono nell’altro una fiducia che non è dei nostri tempi.
Non parliamo poi della violenza inflitta dai decreti legge imposti in Parlamento che, mascherati di un buonismo ripugnante, si propinano come panacea di tutti i mali, col solo fi ne di sottrarre a qualunque controllo nonché a giudizi sconvenienti gente di malaffare che vuole agire indisturbata. Rifletto sulle odiose manovre sempre “onorate” da chi nulla ha più se non lacrime e sangue, e vergognosamente complici di tutti quei “baroni” cui sono riservati privilegi oltre all’arbitrio delle proprie azioni. Non è il sacrificio che fa male ma l’ingiustizia sociale che ne è alla base. In famiglia tutto viene condiviso. Si è mai visto che un fi glio venga nutrito e l’altro no? Un nuovo stile di vita è di rigore, ma sia per tutti! Sull’altare della menzogna e del ricatto si consuma invece il sacrificio di tutti i nostri fi gli, salvo quelli di Papà, spogliati di ogni cosa e condannati a tutte le rinunce. Le prossime generazioni perciò, “selezionate”, saranno frutto di perverse menti che richiameranno alla memoria orridi spettri di tempi non lontani. E arriva la violenza fi glia di violenza, più atroce della prima, che si consuma con qualsiasi arma, e in qualunque luogo, dopo anni d’infi nite vessazioni, calvari di cadute e minacce di morte più volte ripetute, fino all’ultima tragedia che cancella la famiglia. E se qualcuno, a torto, giudica il mio un pessimismo di tipo “universale”, non ha letto bene Schopenhauer.
PARTE TREDICESIMA
23 luglio – Ho ripescato in fondo ad un cassetto un raccoglitore elegante color blu con le foto di tutti i giocatori
Sono corsa da te con in mano la collezione ufficiale delle spille della tua mitica Inter, al tempo in cui la Gazzetta dello Sport invitava a farne la raccolta che avrebbe consentito la partecipazione ad un concorso. Ho ripescato in fondo ad un cassetto un raccoglitore elegante color blu con le foto di tutti i giocatori, del mister, delle maglie e tutte le notizie relative alla Società nata a Milano il 9 marzo 1908. Avevi già raccolto cinque spille con l’effi gie di altrettanti giocatori, e ci sono ancora. Ma tutto è fermo lì. Della squadra del cuore hai riconosciuto solo il nome scritto in bianco a caratteri giganti, e niente più. Hai mostrato una totale indifferenza, come se quei ricordi non ti fossero mai appartenuti. Quanti anni! Un pezzo della vita che non è più tuo. Mai avrei pensato che una passione così grande non potesse lasciare almeno qualche traccia.
Ho ancora aperto tra le mani il raccoglitore con le spille ancorate al cartoncino; leggo i nomi degli “eroi” che sorridono dietro il luccichio del vetrino trasparente. Altri tempi! Intristita, ripongo tutto nel cassetto senza badare a come avresti potuto farlo tu, che dell’assoluta precisione eri paladino. Torno alle mie occupazioni trascinando un fardello di amarezza e di sconforto che mi curva le spalle ogni giorno di più.
E tu sei lì, in attesa di me e, forse, di tutte quelle cose che non sono in grado di darti. Tutto, nella nostra casa, dovrebbe risvegliare in te l’interesse per il tempo che è stato e quello che è, eppure non sai più dove posare lo sguardo. La tua mi sembra la stanchezza dell’ultima resa e non devi permetterlo anche perché ci potrebbe essere un pericoloso contagio. Non voglio finire nella scarpata prima del tempo e in ogni caso vorrei potermi aggrappare qua e là e fare della mia caduta una specie di scivolo. Tu le cadute invece te le vai a cercare, facendo acrobazie assolutamente imprevedibili che mi lasciano allibita. Forse immagini di essere un trentenne che fa le giravolte per voler sembrare ancora un ragazzino. Devo ricordarti che ogni notte ti diverti ad accendere la luce per il solo gusto di guardare l’orologio. Ti guardo, sai. Con un ampio gesto da bullo intraprendente porti il polso sotto il naso e, con l’occhio semichiuso, credi di leggere sempre l’ora giusta. Non mi sai dire mai perché lo fai. Così non dormi tu e privi me di quel riposo che mi servirebbe per affrontare tutti i disagi di una giornata più che faticosa.
Per evitare tutto questo ho pensato di svitare un po’ la lampadina. Mi sono detta: quando non riesce ad accendere la luce, forse pensa che è mancata la corrente e si rassegna. Invece no. Ho sentito il tonfo e sono corsa. Ti ho trovato con una mano agganciata a quello che è stato una volta un delicato lume a muro, e l’altra alla barra d’acciaio che regge l’ampolla della bombola d’ossigeno. Il viso di profi lo, schiacciato contro il comodino, non corrispondeva affatto alla traiettoria che avrebbero dovuto seguire le pupille che, rovesciate nell’occhio completamente bianco, cercavano soccorso da tutt’altra parte. Non riuscendo nel tuo intento e ritenendo forse l’interruttore non idoneo a risolverti il problema, hai cominciato le manovre per arrivare chissà dove, fi nché hai pescato il supporto a muro della lampadina, e ti ci sei attaccato, esercitando tutta la forza che potevi per raggiungere lo scopo. Il risultato: sei caduto a terra come un sacco tirandoti dietro quel supporto che, da ramo in ferro battuto decorato di foglie e roselline, è diventato una balestra sgangherata con punte e lame micidiali che avrebbero potuto ferirti malamente. Ci hanno rimesso le ginocchia contuse e lacerate che rendono ancora più precaria la camminata già difficoltosa.
3 agosto – Devo raccontarti un’avventura di tanti anni fa
Devo raccontarti un’avventura di tanti anni fa, in uno stazzo abbarbicato a una montagna. La mia decisione di raggiungere a piedi il centro abitato
non proprio vicino alla pensione, non è condivisa dai padroni di casa, che si sentono investiti del ruolo di custodi della mia incolumità. La signora, donna di poche parole e molto riservata, mi suggerisce di essere prudente, che forse è meglio evitare, perché ci sono molte serpi nascoste tra i sassi lungo il sentiero, e potrei fare qualche brutto incontro. Son passati già diversi mesi dal mio insediamento nella nuova scuola e il bisogno di scambiare quattro chiacchiere coi colleghi di “città” accorcia la distanza e rende il percorso meno impervio. La mia decisione è, si capisce, di volerci andare ma devo farlo con la compagnia di Franco, il loro fi glioletto di dieci anni che frequenta con me la quinta classe, e l’unico mezzo di cui possono disporre: un somarello. Franco mi suggerisce scarpe adatte che mi proteggano da rovi, sterpaglie e animali di passaggio; sella l’asino con cura e mette in bisaccia pane, formaggio stagionato e un otre d’acqua fresca dalla fonte. Mi vesto da cavallerizza in previsione di dover cavalcare il somarello, ma mi piace tanto camminare. Strada facendo, parliamo del forno a legna che suo padre sta ristrutturando e del pane fatto in casa dalla mamma, donna di grandi tradizioni in fatto di dolci e piatti d’eccellenza. Parliamo della zuppa gallurese che ha preparato per il pranzo del mio arrivo e della cena con le trote pescate da suo padre, della vita, della storia e della cultura dello stazzo, di amici, balli, arrostite e feste campagnole che conservano il fascino di un mondo contadino ancora intatto. La maestra che siede al loro desco è sempre accolta con premure e riverenze, circondata di attenzioni e tenuta al corrente di ogni avvenimento di rilievo che possa interessare la famiglia, di cui è parte attiva. La sacralità dell’amicizia non si mette in discussione e l’accoglienza va curata e coltivata tanto che non deve mai accadere che qualcuno bussi alla porta e non trovi ristoro con pane e companatico. La tradizione vuole che si manifesti in questo modo la disponibilità e il senso forte della fratellanza. I genitori di Franco sono delle rocce in questo senso e l’educazione dei figli è sempre al primo posto. Il capofamiglia, signor Rocco, è alto, magro, coi capelli brizzolati e sempre occupato nell’orto e nella vigna. Signora Nicoletta, piccola e tondetta, è perennemente indaffarata nella cura della casa e del pollaio e Franco, il più grandicello di tre figli, è l’ometto di famiglia che non perde mai di vista i fratellini, e ha il governo del porcile. Nico ha solo due anni e Viola sei e frequenta con me la prima classe. Abbiamo camminato tanto e Franco, da perfetto cavaliere, m’invita a cavalcare l’asinello per far riposare un po’ le gambe alquanto affaticate. È un bambino straordinario e già immagino l’uomo che sarà. L’invito non posso che accettarlo. Avvicina l’animale a un grosso masso sul ciglio del sentiero, che dovrà farmi da pedana, e con agilità e compostezza mi dimostra come dovrei fare per montare in sella. Comincio a fare qualche tentativo che però si ferma tale. Gli dico, imbarazzata, che i pantaloni che indosso vanno bene ma forse gli stivali mi legano troppo i movimenti. Mi risponde con tanta comprensione che va tutto bene. È serio. M’incoraggia e mi offre la mano da perfetto cavaliere. Al forte disagio che mi fa sudare per i vari tentativi andati in fumo si aggiunge, una volta in sella, l’umiliazione di fronte al diniego del somaro di riprendere il cammino. Per la seconda volta gli ordino di andare, usando il linguaggio dei padroni che ormai conosco bene, ma capisco che non è questa la ragione del rifiuto. Per lui sono nessuno e non si schioda. Avevo immaginato di guidarlo a modo mio; di rallentargli l’andatura o accelerarla o di ordinargli di fermarsi se a me fosse piaciuto. Per qualche attimo ho sognato di essere un’amazzone, senza mettere in conto che il somarello non mi conosceva; al massimo poteva avermi solo vista. Non sapevo niente di lui né dell’intesa sua con Franco e non potevo immaginare l’affetto e la stima che li univa. Il nostro non è stato amore a prima vista né gli ho dato in alcun modo l’opportunità di fare conoscenza, standogli lontana e negandogli quelle cure e quelle tenerezze che il padroncino gli sapeva regalare. Vuole il dovere morale ch’io precisi che tale atteggiamento non era certo dettato da un sentimento di avversione; al contrario, un profondo rispetto stava alla base della mia ritrosia. Mi era rimasta dentro la paura di toccare qualsiasi animale da me non conosciuto, memore del grave rischio corso da bambina: solo per miracolo non fui centrata dal calcio di una mucca per averle toccato la mammella con la punta di un bastone. Franco coglie il mio disagio e, mostrando tutta le fermezza, gli ordina di riprendere il cammino, facendogli capire col tono della voce che anche il mio era un ordine che doveva rispettare. Il somarello segue il sentiero a testa bassa, forse risentito con me per essersi beccato un ordine che aveva tutta l’aria di un rimprovero. Franco, silenzioso, lo segue passo passo ed io, che ho perso tutto, anche la reputazione, mi sento bruciare sotto quella sella che non sono stata in grado di onorare. Anche l’asino conosce di me quella che sono.
6 agosto – Mentre riposi, con Rai Storia entro in un luogo di pena spaventoso
Mentre riposi, con Rai Storia entro in un luogo di pena spaventoso.
All’ingresso sta scritto: ERGASTOLO. REPUBBLICA ITALIANA. Un senso profondo di sconforto mi pervade prima ancora di varcare il cancello che mi sovrasta come una fortezza. Mai nessun altro luogo fu più lugubre né altre chiavi hanno prodotto mai tanto fragore da cancellare ogni altro segno di presenza umana.
PORTO AZZURRO
Un promontorio di dolore oltre una lingua di mare, dove la vita s’è fermata per chiudere ai polsi e al cuore le catene e mostrare al mondo libero solo le garitte. Un secondino ci introduce nell’androne, dove all’oscurità si aggiunge l’odore acre e il tetro colore della muffa; quindi ci guida al piano superiore, lungo un braccio freddo e incolore che mostra alle grate delle celle volti spenti di ogni età e mani abbandonate tra le maglie. L’ora d’aria viene consumata in un cortile diviso in rettangoli di pochi metri quadri; in ciascuno non ci sono più di cinque detenuti che vanno avanti e indietro a passo svelto. Ci viene spiegato che alla suddivisione degli spazi corrisponde una maggiore e più sicura vigilanza.
Chiediamo come si svolge la giornata di un recluso e ci viene risposto che si legge, si lavora, si coltivano interessi e i meritevoli possono lasciare la cella per partecipare agli incontri musicali in calendario. Lo spazio è limitato, come sono limitati in verità coloro ai quali è fatta concessione. Sono pochi gli strumenti: qualche chitarra e una fisarmonica. Al microfono un detenuto canta e la voce tremula tradisce una forte commozione. Gli occhi dei pochi spettatori si accendono improvvisamente della luce della vita e quell’angolo perde i confini della costrizione per diventare la ribalta, dove forse qualcuno si ricorda ancora di sognare. Un detenuto sui trent’anni ci introduce nella cella per mostrarci, dietro nostro invito, come passa il tempo. Nei pochi metri quadri c’è la branda, uno scaffale fatiscente e un piccolo tavolo quadrato su cui dispone, seguendo un ordine che noi non conosciamo, una serie di inchiostri che presentano dinamiche e forme sconvolgenti. Sono intrecci e sovrapposizioni di elementi curvi e lineari e vuoti pieni e piani convessi in fuga di alternanze. Un linguaggio misterioso partorito da una mente che dalla pena a vita esclude la speranza. È l’orrore che si fa materia nella fissità di un labirinto senza uscite; è il fluire perverso di memorie e la percezione tardiva di una caduta che riflette il buio cupo di un girone. L’iniziale timido imbarazzo del giovane recluso cede il posto alla rassegnata osservanza delle crude leggi del penitenziario, e lo sguardo, già spento, s’inabissa in un’agonia collettiva. Ci si stringe la mano e si va oltre il dolore. Sì, perché oltre l’ergastolo c’è la “polveriera”.
Le celle qui sono “murate”: non ricevono luce diretta ma solo da una grata piccolissima, a quattro metri d’altezza e forse più. Nel “pozzo”, con la contenzione, si piega nel recluso qualsiasi resistenza. Per i detenuti a rischio della vita ci sono le “imbottite”, dove si combatte una lotta animalesca tra la condanna e il rifi uto della pena. Qui la disperazione dell’uomo diventa irrazionale. Sulla via del ritorno conto i passi del piccolo drappello che ha voluto conoscere gli abissi del dolore. Rimbomba il tacchettio nei corridoi di solitudine, dove la luce fi oca si colora di esclusione e di distacco, uniti a un senso penoso d’impotenza che mi stringe la gola mozzandomi il respiro. Immagino i pensieri e l’abissale senso di abbandono dei sepolti vivi, quando cala la sera e tace anche l’ultimo rumore di chiavi e di cancelli. Sento provenire dalla “polveriera” l’urlo disumano di chi sta in fondo al “pozzo”, di chi non può vedere più nemmeno la luce della grata e di chi prende a testate il muro delle orride “imbottite” per porre fi ne all’agonia. Il secondino chiude il cancello che ci ha visti entrare e ci congeda con saluto militare. Si accendono le prime luci della sera. Dall’auto che si allontana piano, scorro con la mente il profilo assente dei dimenticati e con gli occhi la fortezza bianca che riflette nell’acqua il ghiaccio delle mura e inghiotte la dolente umanità che vi racchiude. Sono andata all’inferno e son tornata e tu riposi ancora.
13 agosto – Voglio raccontarti di me oggi
Voglio raccontarti di me oggi.Della mia primissima infanzia conservo, se così si può dire, soltanto parvenze piuttosto che veri ricordi.Sono segmenti di vita, di giochi, presenze indistinte, memorie sfuocate di nenie e racconti. Sono ombre leggere, fluttuanti, che ora si accostano ad un fi ume sonnolento e insidioso, ora ad un gaio ruscello che gorgoglia tra i sassi. Sono veli che la brezza leggera sospinge a lambire graniti e sorgenti, sentieri e fontane, pergole e pampini di bianchi stazzi di quella Gallura che porto nel cuore. Memorie bucoliche che mi accompagnano ancora e colorano di una dorata luce soffusa la mia vita presente.
Alla seconda infanzia appartiene il ricordo di un vestitino che la mamma fece per me con lana grezza bianchissima e qualche mazzetto di foglie verdi e rosse ciliegie, anche’esse di lana, disposto qua e là tutt’intorno, a un palmo dall’orlo. Era bellissimo ma imbarazzante per me; quando andavo a scuola i bambini incuriositi mi giravano intorno ed io dovevo difendere le mie ciliegie dall’impertinenza di qualcuno che voleva strapparle. Dell’ultima infanzia è il mio primo ed unico amore bambino: bruno, magro, più alto di me. Mi piaceva tutto di lui; peccato che mi vedesse solo come compagna di giochi. Forse i miei sogni cominciarono lì. Una matassa intricata che più diventava impossibile, più mi esaltava, e l’adolescenza fu tutta un fervore di sentimenti e di vita, tra amici e compagni di studi e vacanze nei luoghi più cari legati a memorie lontane.
Ogni cosa sapeva darmi emozioni incredibili. La notte, sui gradini di casa, mi parlava di stelle e mondi fantastici usciti da un libro di straordinaria bellezza che sfogliavo nel più totale silenzio. Non potevo arrivare a toccare quel mondo, ma potevo vederlo! Indovinavo segreti di vite fantastiche che il tramonto del sole, chissà dove, portava con sé, e l’alba sul mare era un mistero di fascino di nobile opale di estati da sogno. La risacca strappava agli scogli l’ultimo granello di sabbia per un viaggio straordinario di ritorni impossibili e le scaglie lucenti dell’acqua cullavano dolci ricordi di arrivi e partenze e ormeggi da favola in pensieri roventi. Se il mare alimentava i miei sogni, i monti mi avvicinavano a
Dio. Lì perdevo completamente la mia dimensione reale. Le cime innevate erano il percorso degli spiriti eletti ed io mi perdevo nei silenzi di distanze stellari. Folgorata dalle vette superbe dell’Appennino abruzzese, porto ancora nella mente e nel cuore il brivido della suprema bellezza terrena in perfetta simbiosi con la grandezza di Dio. Le cime ammantate di bianco toccavano il Cielo e il colore evanescente di questo si perdeva nella madreperla di quelle, quando i primi bagliori annunciavano l’alba in un tripudio di luci soffuse di divina bellezza.
Mai vidi quadro più bello né colori più puri. Quei ricordi conservano intatto il potere di farmi sognare, e ancor oggi mi perdo nell’ametista e nell’arancio di tanti tramonti e nel puro smeraldo dei nostri fondali.
Sarà per questo che ho visto la vita sempre come una sfi da stupenda, un viaggio da favola anche in mezzo al dolore e se questo mi mostra il suo volto peggiore, guardo il Cielo e torno a sorridere. Forse in una vita passata sono stata una ninfa dei boschi e dei monti che, ornata di veli e ghirlande, volteggiava sull’acqua insieme alle tante libellule o tra gli alberi con le farfalle dalle ali dipinte, e sulle cime più alte si univa agli angeli in un concerto di suoni. Forse sono stata nereide o forse sirena per vivere, libera, la stupenda vita del mare. Sono stata solitaria per scelta, vestale della bellezza e del canto, di principi e ideali che, se non si usano più, mi danno tuttavia la vitalità che mi serve per continuare a combattere il nichilismo strisciante di una società in continuo declino.
L’insolenza di tanti ha origini molto lontane; si perdono nei tanti rifi uti lasciati sulle spiagge e nei prati, e per le strade come se non fossero nostre; così la natura ferita perde i colori per diventare cancrena. Si sta ribellando alla violenza dell’uomo. Ci stanno sfuggendo valori di vitale importanza: è sotto gli occhi di tutti l’impoverimento materiale e morale che sconcerta e addolora. La terra, ara sacrifi cale offerta al cieco egoismo, arde e frana inghiottendo alberi e case, mentre il mare diventa catrame nel pozzo nero del cinismo dell’uomo.
19 agosto – Se penso al tempo che ho vissuto mi sembra lungo se ne conto gli anni
Non so se per te sia così ma se penso al tempo che ho vissuto mi sembra lungo se ne conto gli anni; non è così se provo a immaginarmi sui banchi della scuola, quando vi lasciavo inciso il nome con la penna, sognando che potesse leggerlo il ragazzo che mi avrebbe amata. Il volto da bambina mi tradiva e la natura taciturna mi giocava sempre qualche brutto tiro, quando mi sarebbe piaciuto essere notata, specialmente da un ragazzo riccio e biondo di cui mi ero innamorata, senza mai farglielo capire. Ora dico: quanto tempo perso! Conobbi il suo nome sbirciando sulla copertina di un quaderno lasciato sul tavolo della sala d’attesa di una stazione ferroviaria. Mai avrei potuto fare altro né altro feci e non per voler fare la preziosa ma perché mi piaceva fosse lui a corteggiarmi.
Quella testa bionda mi costò tanta distrazione e qualche interrogazione andata male e il suo ricordo mi accompagnò per lungo tempo. È vero che la mia timidezza non mi ha favorita però l’intraprendenza delle giovinette non era ancora salita alla ribalta. Non farei mai il primo passo; oggi però, un uomo mi piacerebbe fulminarlo almeno con lo sguardo. I diciott’anni sono sì cose d’altri tempi ma non così lontani come potrebbero sembrare. È il gioco stupendo della nostra mente che tutto ripone nella memoria perché resti vivo, e il tempo si fa puro cristallo per mostrarci il passato in trasparenza. E vedo i primi incarichi per me: la scuola serale e i Corsi Televisivi per adulti frequentati solo da maschi, quando il rispetto prima di tutto era un valore. Oggi è impensabile questo ed è penoso constatare che la fiducia nell’uomo sta scemando. Ma voglio tornare al tempo che ho vissuto e a quello che avrei potuto fare e non ho fatto, sempre pensando che la vita è lunga. Così finisce che il passaporto che ti danno i diciott’anni lo usi come il vestito della festa; ora direi che non ho saputo vivere il mio tempo ma così pensando so di sbagliare un’altra volta, come sarebbe stato allora se avessi voluto bruciare tante tappe. Gli anni, è vero, corrono veloci invitandoci con loro a voli straordinari e a volte folli, ma allora del mondo avremmo solo una visione come patinata e chi, per tanta fretta, ci renderebbe il non vissuto? E poi, se ho dei ricordi, è perché sono parte del reale; le cose sensibili ho potuto toccarle con le mani e le sensazioni hanno fatto vibrare la mia pelle; lo spirito ha tante volte respirato l’infi- nito e tante altre il cuore ha pianto, e posso dire di non essere passata a occhi chiusi. La maturità mi ha vista accelerare l’andatura ma non è bastato; tante cose sono rimaste solo nella mente. Non so tu ma io il mondo vorrei cambiarlo come quando avevo diciott’anni, con la differenza che allora volevo farlo forse per quella irragionevole spinta giovanile che accompagna la voglia pazza di fare cose al di là di ogni limite di consapevolezza e di misura; oggi, con l’esperienza dell’età matura e tutta la rabbia di una vita travagliata, vorrei dargli un volto nuovo ribaltando carrozza e carrozziere. Darei la vista ai ciechi e l’udito ai sordi, togliendoli a chi non ha voluto rispettare questi doni, facendone un uso distorto e incontrollato tanto da generare una babele di proporzioni planetarie. Non si capisce più chi ha torto e chi ragione, non sai se dire sì oppure no a questo o a quello dei tuoi interlocutori, né se dare il proprio nome a ogni colore; ti confondono la mente coi refusi e tu, per salvarti in dignità, dovresti registrare la sequenza di sproloqui e di proclami e farne edotti quanti negano di averne fatto uso. Renderei ai muti la favella togliendola a chi, con la lingua, crede di poter ferire a morte come con la spada, e a chi non paga il debito d’offesa chiederei la provvigione a vita. Questo, è vero, è un sogno più pazzo di quello che si potrebbe accarezzare a diciott’anni, ma oggi c’è la consapevolezza che lo fa reale anche se resta solo nel pensiero. Il tempo che ho vissuto mi sembra lungo se ne conto gli anni, ma non è così se guardo ai sogni che tali restano a qualunque età.
25 agosto – Devo confessarti che sono preda di una noia spaventosa
Devo confessarti che sono preda di una noia spaventosa. Lo dico quasi con vergogna perché cose da fare ne avrei tante, troppe forse, ma se provo ad elencarle, non ne trovo una che vorrei fare. Penso che la noia possa avere origini diverse: può nascere dall’incapacità di applicarsi a qualunque attività perché nessuno lo ha mai insegnato; può essere frutto di azioni “vuote” sempre uguali ripetuti all’infi nito, o derivare da uno stato d’animo legato ad una sofferenza spirituale, come dalla solitudine
imposta da eventi contingenti. Posso dire, senza paura di sbagliare, che la mia non so da cosa esattamente mi derivi, ma ho la certezza che si tratti di una situazione di non pace. Mi manca qualcosa che non trovo e questo mi procura una strana sofferenza che somiglia a tante cose messe insieme. Vorrei analizzarle per venirne a capo ma è un lavoro che mi pesa e ci rinuncio. Forse, se tu provassi a dirmi qualche cosa ritroverei il fi lo che ho perduto e, come a “qualcuno” accadde, riuscirei a lasciare il labirinto. Mi sento quell’Arianna fi glia di Minosse re di Creta, che s’innamorò di Teseo e con lui partì, ma venne abbandonata dal suo innamorato nell’isola di Nasso. Non credi che la mia somigli alla sua storia? È un’isola anche questa stanza e tu non parli più. Ti ho fatto una domanda stamattina ed è già sera e tu non mi hai dato la risposta. Forse la cosa che non trovo è proprio quella e la mia strana “malattia” è lo sconforto che mi toglie spesso la linfa, vita della mia vita quotidiana.
Vado per casa, cercando con lo sguardo una fonte d’interesse ma tutto sfi la lentamente sotto una coltre di totale indifferenza. Il mio è un torpore che somiglia al pianto della povera Arianna; ma tu non sei Teseo. Inventa se ti pare un’altra storia, che sia diversa dalla nostra poco importa, e prova a raccontarla. Io sarò tutta orecchie senza fare la gelosa; mi basterà sentire la tua voce per ritrovare quello che ho perduto. Dammi anche tu un fi lo che possa condurmi fuori da questo labirinto, nel cui silenzio io mi sto perdendo. Guarda che a tenere la bocca sempre chiusa si rischia di irrugginire le ganasce, impedendo le funzioni naturali. E poi, non vorrei dirtelo, ma così facendo tu mi esponi ad un pericolo concreto oltre che costante: se qualche malintenzionato s’introducesse nella nostra casa e tentasse di aggredirmi, così come sei con le labbra sigillate, non saresti in grado di dire una parola in mia difesa. La cosa si mette molto male perché la voce che tu hai perso la parola corre già e non posso garantirti che terrò la porta chiusa, perché significherebbe la mia definitiva sepoltura. Non ho intenzione di lasciare questo mondo senza un funerale perché, se mi lasciassi morire con la porta chiusa, nessuno avrebbe la possibilità di rendermi l’ultimo saluto. Non mi aspetto il tributo di speciali onori; mi piacerebbe che dietro la mia cassa, in prima fi la, avanzasse lento, con passo cadenzato a sottolineare il rigore del silenzio, l’antico calesse amico di una vita; e per sottolineare anche nel momento della dipartita l’ineludibile principio di giustizia sulla parità dei diritti tra i diversi sessi, vorrei che sorella morte ne fosse la cocchiera. Per l’occasione, mi piacerebbe che al nostro antico palafreno fosse concesso l’onore di una bianca bardatura, quale omaggio festoso più che riverente all’indiscussa fedeltà e totale dedizione. Non per vanità ma solo per testimoniare che nulla finisce e tutto si trasforma, vorrei poter rivivere in una della ruote (l’altra sarebbe sempre tua) di quel mitico calesse che volle con me girare il mondo e dividere insieme l’arte e la vita.
30 agosto – Pensavo a noi due e al percorso insieme che abbiamo fatto fin qui
Pensavo a noi due e al percorso insieme che abbiamo fatto fin qui. Era molto romantica l’antica strada sterrata: non erano troppe le buche per reprimere i sogni, né era comoda e larga; abbiamo camminato a lungo senza però correre mai. Le curve, è vero, nascondevano ostacoli; tante volte siamo fi niti contro il costone facendoci male, ma tante altre ci siamo consolati all’ombra di acacie e di ulivi e dissetati alle fonti dove l’acqua è più chiara, tra cespugli e antichi tratturi. Quella è l’età in cui, anche se dura e insidiosa, la vita quasi sempre sorride, e noi, se tante volte abbiamo celato dietro un sorriso le nostre amarezze, tante altre abbiamo gioito in pienezza dei doni che la vita ci offriva. Ci siamo avventurati su pareti rocciose e greppi scoscesi per issarvi le nostre bandiere; abbiamo graffi ato muri di gomma e più volte siamo caduti senza però perderci mai. Sulla strada sterrata hanno steso catrame perché fosse più scorrevole e comoda e noi ci siamo passati portandoci dentro delusioni e speranze. Siamo stati giullari per esorcizzare paura
e sfortuna e abbiamo fatto gli acrobati per superare barriere e ancorarci agli arpioni che il caso ci offriva. Il serpente d’asfalto che sembrava nato per assicurarci una strada scorrevole ci ha rotto le ossa e il tempo non ci ha risparmiato percosse e scossoni, mettendo a rischio il nostro equilibrio. Tante volte però, dietro l’angolo buio è spuntata la luce e camminando sui trampoli siamo arrivati a toccarla. I sogni non li abbiamo sepolti neppure quando la tempesta infuriava e abbiamo colto fi ori nelle tante stazioni per farne tappeti nei giorni di pace. Abbiamo vegliato sotto le stelle, ascoltato la voce del mare e consegnato alla luna le nostre promesse. Ci siamo sempre cercati dopo i venti di guerra.
La strada a catrame è tornata sterrata: gli anni e i rigori del tempo hanno roso l’asfalto e macinato graniglia, ora gonfiandola, ora svuotandone il ventre. Non era poi tanto difficile, allora, percorrerla a valle; ora invece è tutta in salita e al primo tornante ti sei arenato. Vorrei capire perché Nostro Signore ha scelto di riservarci tutta questa fatica al tempo in cui le forze ci vengono meno. Ora, dimmi tu, se già per te è tanto difficile provvedere a te stesso, che potrò fare io a provvedere per due? E la strada è lunga; parecchi tornanti ci aspettano ancora. Devo dire che mi sembra piuttosto imprudente lasciare che a questa età si ripercorrano simili strade; non siamo i corridori del Giro di Francia; e se, voltandoci a guardare di sotto il già precario equilibrio ci traesse in inganno? Se, rotolando, ancora vivi toccassimo il fondo, dovremmo ricominciare tutto da capo. A dire la verità mi sembra un po’ troppo. Hai abbandonato le scarpe perché le sentivi pesanti e il bacolo ti è stato offerto come supporto alle gambe malferme, ma i piedi non vogliono saperne di schiodarsi da terra. Ti prendo per mano e alla forza che esercito per farti arrivare da me opponi la tua che da me ti allontana. La nostra è la lotta tra forze contrarie che ci inchiodano allo stesso mattone. Dove pensi che potremo arrivare? Se un giorno riusciremo a toccare la cima del monte, oh, sarà una grande vittoria! Allora accenderemo un falò coi legni secchi delle cose perdute e di quelle mancate, e sarà così grande che la sua luce
arriverà alle stelle. Il suo calore dissolverà la nebbia che aveva reso difficile il passo e nascosto alla vista l’impervia salita un po’ per pietà, un po’ forse, per alimentare in noi la speranza di farcela ancora.
Ciao, Ni’, a domani…

A conclusione,riporto una breve recensione del libro fatta da Caterina Fiori, una giovane di Sorso autrice del libro “Giannetto Masala e il suo tempo”, pubblicato nel 2008, e vincitrice del premio “TesiSarda”.
Viaggio nei ricordi
di Caterina Fiori
Il quadrato di sole è un viaggio nei ricordi, la narrazione segue i giorni e le ore che l’autrice ci regala con ricchezza di linguaggio e dovizia di particolari. Questi svelano un mondo intimo, una realtà attuale fatta di attese silenzi, nostalgie, tristezze ma anche amore e gioia “quei bagliori” che nonostante le difficoltà hanno accompagnato e accompagnano questo viaggio nella vita che dura da quasi cinquant’anni.
Quando si scorre nella lettura i sentimenti che ti pervadono sono molteplici, le lacrime scorrono sul viso nel rivivere le solitudini degli altri che diventano le tue ma, poco dopo la tristezza lascia spazio al sorriso
“mi punti un piede nelle chiappe … e spingi, spingi e spingi … e con mio grande disappunto arrivo al pavimento” e quel quadrato di sole diventa, ancora una volta, un cerchio con raggi di luce che pervadono il racconto e subito dopo si affievoliscono come la metafora del calesse e delle ruote che girano.
Quel pennello privo di colori che ora dipinge il corso della vita in bianco e nero porta in primo piano l’autrice che per tutto il racconto ne è la protagonista.
E il rivivere quel mitico viaggio anche nell’ultimo saluto dove le ruote del calesse, ritornato ad essere i due protagonisti che vollero girare il mondo e condividere l’arte e la vita. Insieme ripercorreranno verdi pascoli e la luce del focolare illuminerà tutti fino alle stelle e per sempre.

Immagini da infermo di Nino realizzate dalla stessa Demuro





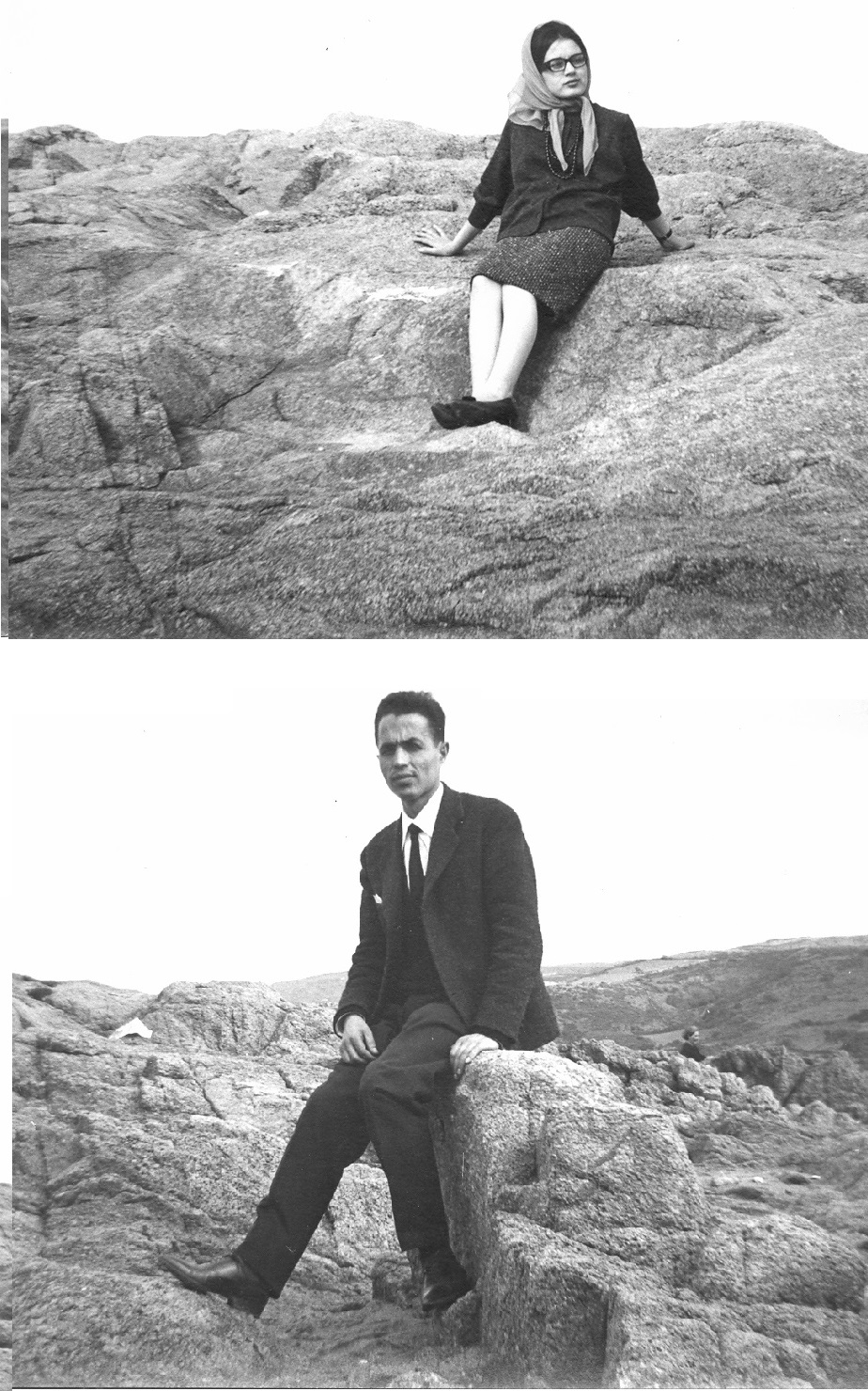


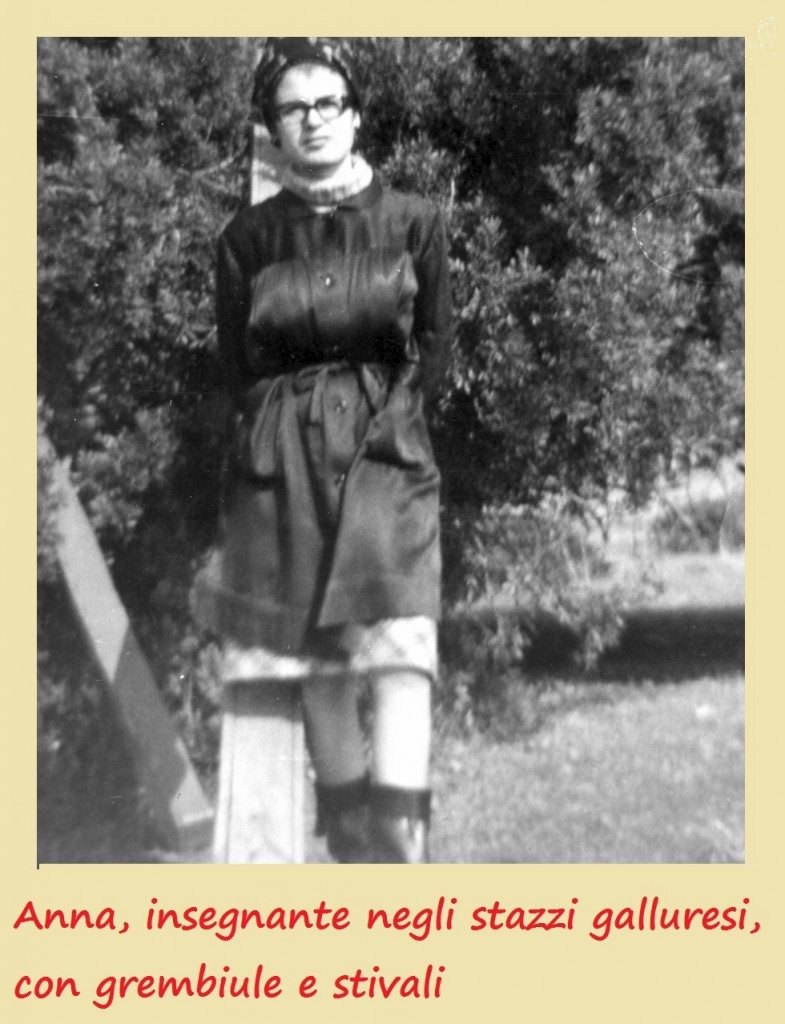



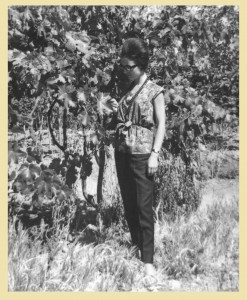
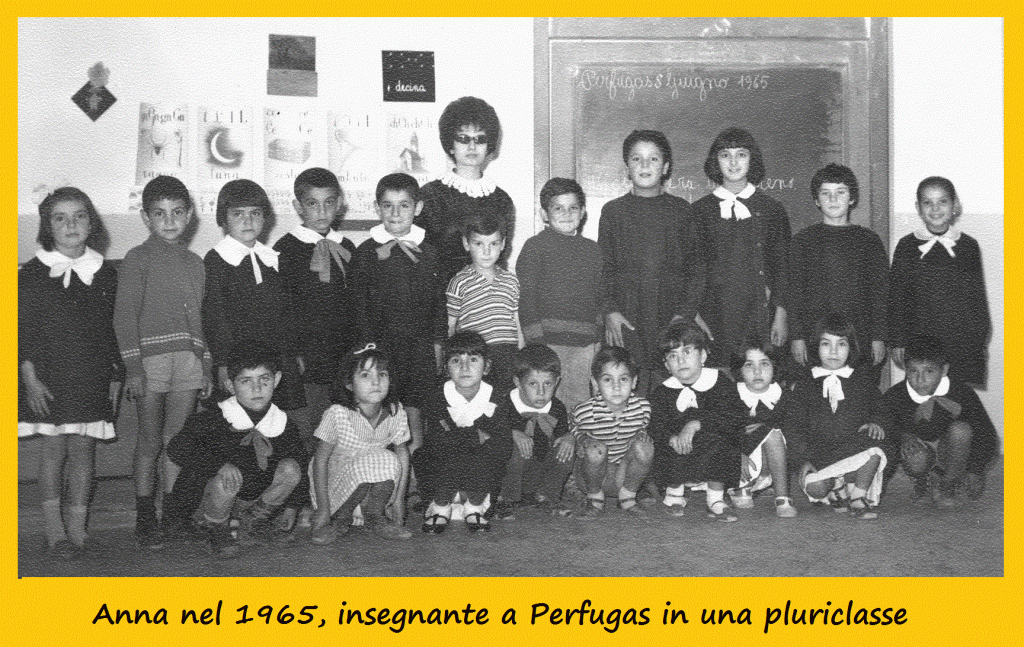

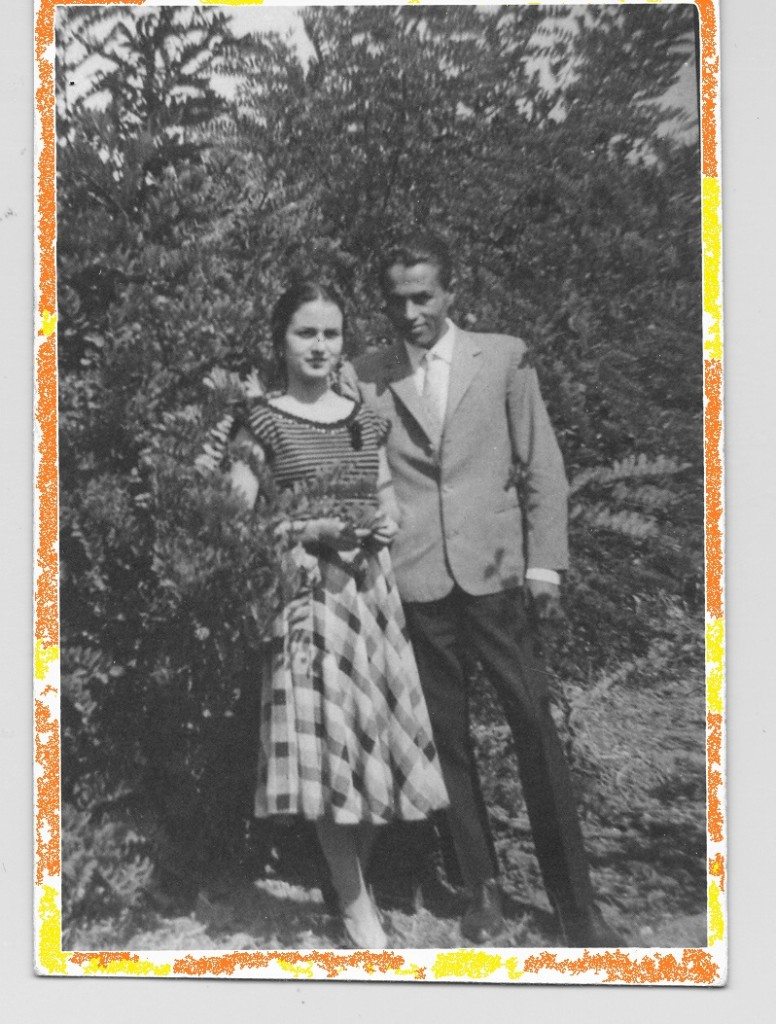


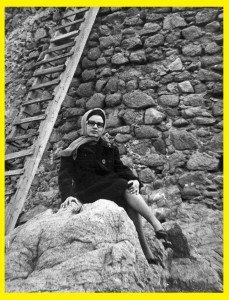
 l
l