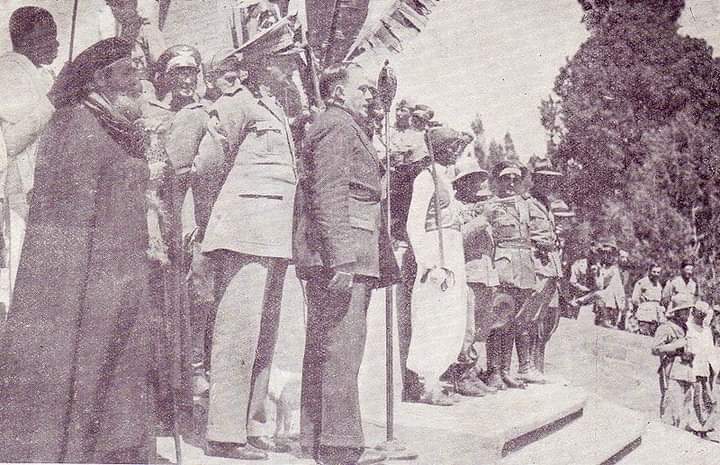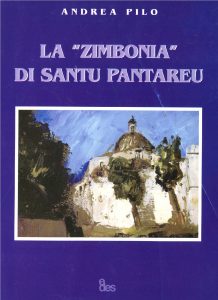La chiamata di Dio è cosa misteriosa, perché avviene nel buio della fede.
In più essa ha una voce sì tenue e sì discreta, che impegna tutto il silenzio interiore per essere captata.
Eppure nulla è così decisivo e sconvolgente per un uomo sulla terra, nulla più sicuro e più forte.
Tale chiamata è continua: Dio chiama sempre! Ma ci sono dei momenti caratteristici di questo appello divino, momenti che noi segnamo sul nostro taccuino e che non dimentichiamo più.
Tre volte nella mia vita intesi questa chiamata.
La prima determinò la mia conversione a 18 anni. Ero in un villaggio di campagna, maestro elementare.
Venne, in occasione della Quaresima, una missione per il popolo. Vi presi parte, e di essa mi rimase il ricordo di una predicazione antiquata e noiosa. Posso dire che non furono certo le parole a scuotere il mio stato d’indifferenza e di peccato. Ma quando mi inginocchiai dinanzi ad un vecchio missionario, di cui ricordo gli occhi chiari e semplici, per esporre la mia confessione, avvertii nel silenzio dell’anima il passaggio di Dio.
Da quel giorno mi sentii cristiano e constatai che la mia vita era cambiata.
La seconda volta fu a 23 anni. Pensavo a sposarmi; e nemmeno sapevo che poteva esistere qualche altra via per me.
Incontrai un medico che mi parlò della Chiesa e della bellezza di servirla con tutto il nostro essere, pur restando nel mondo. Non so che cosa avvenne in quei giorni e come avvenne; il fatto si è che, pregando in una chiesa deserta dov’ero entrato per sfogare il tumulto dei pensieri che agitavano la mia mente, sentii la stessa voce che avevo udito durante la confessione col vecchio missionario. “Tu non ti sposerai; tu mi offrirai la tua vita. Io sarò il tuo amore per sempre”.
Non fu difficile rinunciare al matrimonio e consacrarmi a Dio, perché tutto era cambiato in me; a me sarebbe parso strano innamorarmi di una ragazza, tanto Dio riempiva la mia vita.
Furono anni pieni di lavoro, di passioni, di incontri con anime, di grandi sogni. Gli stessi sbagli – e furono molti – erano dovuti alla violenza di ciò che bruciava dentro di me e che non era ancora purificato.
Passarono molti anni; e molte volte mi sorpresi in preghiera a domandare di risentire il suono di quella voce che tanta importanza aveva avuto per me.
Fu a 44 anni che ciò avvenne; e fu la chiamata più seria della mia vita: la chiamata alla vita contemplativa. Essa si determinò nel più profondo della fede, là dove il buio è assoluto e le forze umane non aiutano più.
Questa volta dovevo dire di sì senza nulla capire: “Lascia tutto, e vieni con me nel deserto. Non voglio più la tua azioni, voglio la tua preghiera, il tuo amore”.
Qualcuno, vedendomi partire per l’Africa, pensò ad una crisi di sconforto, di rinuncia. Nulla è più inesatto di ciò. Sono così ottimista per natura e ricco di speranza, che non conosco ciò che sia lo sconforto o la rinuncia alla lotta.
No; fu la chiamata decisiva. E mai la compresi come quella sera dei Vespri di S. Carlo del 1954, quando dissi di sì alla Voce.
“Vieni con me nel deserto”. C’è una cosa più grande della tua azione: la preghiera; c’è una forza più efficace della tua parola: l’amore!
E andai nel deserto.
Senza aver letto le Costituzioni dei Piccoli Fratelli di Gesù, entrai nella loro Congregazione; senza conoscere Charles de Foucauld mi misi alla sua sequela.
Mi bastava aver sentito la voce che mi aveva detto: “Questa è la tua strada”.
Fu camminando coi Piccoli Fratelli sulle piste del deserto che scoprii la bontà della via; fu seguendo il Padre de Foucauld che mi convinsi che proprio quella era la mia via.
Ma Dio me l’aveva già detto nella fede!
Ma faccio bene a scrivere queste cose?
Quando giunsi a El Abiod Sidi Seik per il noviziato, il mio maestro mi disse con la calma più perfetta d’un uomo che aveva vissuto vent’anni nel deserto: “Il faut faire une coupure, Carlo”.
Io capii cosa voleva dire quella frase e decisi di fare il taglio anche se doloroso.
Avevo nella mia sacca conservato un grosso quaderno su cui erano annotati gli indirizzi dei miei vecchi amici: ce n’erano migliaia.
Il Signore nella sua bontà non m’aveva mai lasciato mancare la gioia dell’amicizia e su un vero fiume d’amore aveva navigato la barca della mia vita.
Se restava in me una sofferenza nascosta era certamente quella di non poter – al momento della mia partenza per l’Africa – parlare a ciascheduno di loro, spiegare il motivo dell’abbandono, dire che obbedivo ad una chiamata chiara di Dio e che, anche se da un’altra trincea, avrei continuato a militare con loro nel campo dell’apostolato.
Ma bisognava fare la famosa “coupure”ed io la feci con coraggio e con una grande fiducia in Dio.
Presi l’indirizzario che era per me come l’ultimo legame al passato ed andai a bruciarlo dietro una duna durante una giornata di ritiro.
Rivedo ancora i resti anneriti del quaderno trasportati lontano dal vento del Sahara.
Ma bruciare un indirizzo non significa distruggere l’amicizia, né questo mi era richiesto; anzi…
Mai ho amato e pregato tanto per i miei vecchi amici come nella solitudine del deserto. Ne rivedevo i volti, ne sentivo i problemi, le sofferenze acuite dalla distanza.
Essi erano diventati per me come un gregge che mi sarebbe appartenuto per sempre e che io dovevo condurre con me ogni giorno alla fonte della preghiera.
Quasi fisicamente li sentivo attorno a me quando entravo nella chiesa di stile arabo a El Abiod o, più tardi negli eremitaggi famosi costruiti dallo stesso padre de Foucauld a Tamanrasset, all’Assekrem.
Pregare era diventato il mio maggiore impegno, la mia più dura fatica quotidiana e avevo per vocazione cosa significasse “portare gli altri” nella nostra preghiera.
Ebbene: a distanza di anni posso dire di aver mantenuto il mio impegno, mentre s’è fatta sempre più chiara la certezza che a pregare non si perde il proprio tempo e che non esiste forma più adatta per aiutare coloro che amiamo.
Rimane il problema dell’indirizzario che non posseggo più, ma questo non ha molta importanza perché esistono altri mezzi per raggiungere gli amici.
Ecco, vorrei dare a loro l’appuntamento in uno dei tanti angoli meravigliosi del Sahara verso la sera al calar del sole, e ritrovarci tutti come ci siamo trovati allora in quella sera famosa del settembre 1948 nella piazza di S. Pietro. Ricordate?
Qui non ci sarebbe bisogno di fiaccole, tanto il cielo è chiaro di stelle.
Ci sederemmo sulla sabbia e trascorreremmo la notte a raccontarci la vita di questi anni, le tappe compiute, le prove subite.
Penso che la stella del mattino ci troverebbe ancora a conversare.
Per conto mio, ho voluto annotare qui in queste “lettere dal deserto” le cose che direi, se mi fosse data una simile occasione, e che rappresentano certamente una parte di me stesso.
Niente di sistematico, niente di importante. Alcune idee maturate nella solitudine e gravitanti attorno ad un’attività che è stata senza alcun dubbio il più grande dono che mi ha fatto il Sahara: pregare.
Se ho fatto bene o male a scrivere, lo direte voi, i miei cari vecchi amici; ma sento che se non altro la cosa avrà servito a ripensare con esperienza nuova i problemi che sono stati alla base della nostra amicizia.
Vostro piccolo fratello
Carlo Carretto
Sotto la grande pietra
La pista, bianca di sole, si snodava dinanzi a me con tracciato incerto. I solchi nella sabbia, fatti dalle ruote delle grandi cisterne dei “petrolieri”, m’obbligavano ad una ginnastica continua per mantenere la direzione della jeep.
Il sole era alto e mi sentivo stanco. Solo il vento che soffiava sul muso della macchiana permetteva ancora alla jeep di procedere, benché la temperatura fosse infernale e l’acqua bollisse nel radiatore. Di tanto in tanto il mio sguardo si posava sull’orizzonte. Sapevo che nella zona c’erano grossi blocchi di granito emergenti dalla sabbia: ricercatissimi luoghi d’ombra per fare il campo e attendere la sera per proseguire il viaggio.
Difatti, verso mezzogiorno, trovai ciò che cercavo. Grosse rocce apparvero sulla sinistra della pista; ed io mi avvicinai, sicuro che avrei trovato un po’ d’ombra.
Non ne fui deluso. Sulla parete nord d’un gran macigno alto una decina di metri una lama d’ombra si proiettava sulla sabbia rossa. Misi la jeep contro vento per raffreddare il motore e scaricai il “ghess”, cioè l’indispensabile per fare il campo: una stuoia, il sacco dei viveri, due coperte e il treppiede per il fuoco.
Ma, avvicinandomi alla roccia in ombra, mi accorsi che c’erano già ospiti: due vipere se ne stavano raggomitolate nella sabbia calda e mi sorvegliavano senza muoversi. Feci un salto indietro, m’avvicinai alla jeep senza perder di vista i due serpenti; e presi il fucile, un vecchio aggeggio che un indigeno m’aveva prestato per aiutarlo a liquidare gli sciacalli che attaccavano i suoi greggi, spinti dalla fame e dalla siccità.
Misi una cartuccia con piombo medio; e mi allontanai, cercando di colpire le due vipere d’infilata per non sprecare un altro colpo. Tirai e vidi le due bestie saltare in aria tra un novolo di sabbia. Ripulendo la zona dal sangue e dai resti delle vipere, vidi che dal ventre squarciato di una di esse usciva un uccellino non ancora digerito.
Stesi la stuoia, che nel deserto è tutto: cappella, sala da pranzo, camera da letto, salotto di ricevimento; e mi sedetti.
Era l’ora sesta e presi il breviario.
Recitai qualche salmo, ma con un certo sforzo, data la stanchezza e la faccenda di quelle due vipere che di tanto in tanto mi saltavano a pezzi sui versetti. Una vampa calda veniva dal sud e la testa mi doleva. Mi alzai; calcolai l’acqua che mi rimaneva prima di giungere al pozzo di Tit, e decisi di sacrificarne un po’. Ne attinsi dalla “gherba” di pelle di capra una ciotola ddi un litro e me la versai sulla testa. L’acqua imbibì il turbante, mi scese sul collo e sui vestiti; ilvento fece il resto; e la temperatura, da 45 gradi, discese in pochi minuti a 27. Con quel senso di refrigerio mi stesi sulla sabbia per dormire, perché nel deserto la siesta precede il pranzo.
Per star più comodo, cercai una coperta per mettermela sotto il capo. Ne avevo due, e ben lo sapevo. Una coperta rimase accanto a me, inutilizzata e, guardandola, non mi sentivo tranquillo.
Ma se volete capire, dovete ascoltare la storia.
La sera prima ero passato da Irafok, un piccolo villaggio di negri, ex schiavi dei Tuareg. Come al solito, quando si giunge in un villaggio, la popolazione corre a far ressa attorno alla jeep, sia per curiosità, sia per quei piccoli servizi che si fanno da chi frequenta la pista del deserto: portare un po’ di tè, distribuire medicine, consegnare qualche lettera.
Quella sera avevo notato il vecchio Kadà che tremava dal freddo. Sembra strano parlare di freddo nel deserto, eppure è così; tanto che la definizione del Sahara è la seguente: “paese freddo dove fa molto caldo quando c’è il sole”. Ma il sole era tramontato; e Kadà tremava.
Mi venne l’impulso di dargli una delle due coperte che avevo con me e che formava il mio “ghess”; ma mi distrassi volentieri da quel pensiero. Pensavo alla notte, e sapevo che anch’io avrei tremato. Quel po’di carità ch’era in me tornò all’assalto, facendomi notare che la mia pelle non valeva più della sua e che avrei fatto bene a dargkiene una; e che, se anche avessi tremato un po’, era ben giusto per un piccolo fratello.
Quando partii, le due coperte erano ancora sulla jeep; ed ora erano là davanti a me e mi davano fastidio.
Cercai d’addormentarmi coi piedi appoggiati alla grande roccia, ma non ci riuscii. Mi venne in mente che un Tuareg un mese prima era stato schiacciato da un massoproprio mentre faceva la siesta. Mi alzai per assicurarmi della stabilità del masso: vidi che era piuttosto in bilico, ma non proprio da essere pericoloso.
Mi ricoricai sulla sabbia. Se vi dicessi che sognai, vi sembrerebbe strano. Ma il più strano è che sognai che dormivo sotto la grande pietra e che ad un certo punto… Non mi pareva affatto un sogno: vidi la pietra muoversi; e mi sentii venire addosso il masso. Che brutto momento!
Ero liquidato. Sentii scricchiolare le ossa e mi trovai morto. Mi stupivo che nessun osso mi dolesse: ero solo immobilizzato. Aprii gli occhi e vidi Kadà che tremava davanti a me a Irafok. Allora non esitai più a dargli la coperta, tanto più che era inutilizzata vicino a me, a un metro di distanza. Cercai di allungare la mano per offrirgliela; ma il masso che mi aveva immobilizzato mi impediva il più piccolo movimento. Capii che quello era il purgatorio e che la sofferenza dell’anima era di “non poter più fare ciò che prima si poteva e si sarebbe dovuto fare!”. Chissà per quanti anni avrei visto quella coperta vicino a me, in quella scomoda posizione, a testimoniare il mio egoismo e quindi la mia immaturità ad entrare nel Regno dell’Amore.
Provai a pensare quanto tempo sarei rimasto sotto il masso. La risposta me la suggerì il Catechismo: “Fin tanto che sarai capace di un atto di amore di amore perfetto!”. In quel momento non mi sentivo capace.
L’atto d’amore perfetto è l’atto di Gesù che sale il Calvario per morire per tutti noi. A me, membro del suo Corpo Mistico, si chiedeva se ero giunto a tanta maturità d’amore da desiderare di seguire il mio Maestro sul Calvario per la salvezza dei miei fratelli. La presenza della coperta negata a Kadà la sera prima mi diceva che avevo ancora molta strada da percorrere! Capace di vedere un fratello che trema e passar oltre, come sarei stato capace di morire per lui ad imitazione di quel Gesù che morì per tutti? Qui compresi che ero perduto; e che, se non fosse intervenuto Qualcuno ad aiutarmi, io avrei trascorso epoche ed epoche geologiche senza più potermi muovere.
Guardai altrove e mi accorsi che tutti quei grossi massi del deserto non erano altro che sepolcri di altri uomini. Anch’essi, giudicati nell’amore e trovati freddi, erano là ad attendere Colui che un giorno aveva detto: “Io vi risusciterò nell’ultimo giorno”.
Sarete giudicati sull’amore
Ancora oggi non saprei dirvi se l’episodio della grande pietra sia stato un sogno e che genere di sogno.
Ha esercitato così fotre influenza sui miei pensieri, ha talmente cambiato le prospettive in cui si vedono le cose, che non l’ho mai potuto attribuire a ciò che comunemente intendiamo quando, svegliandoci, diciamo: “Ho fatto un sogno.”
No, no: è stato qualcosa di più. Per me, quel tratto di deserto tra Tit e Silet rimane il luogo del mio purgatorio, l’ambiente dove si raccoglie volentieri la mia anima a meditare le cose di Dio e dove… probabilmente chiederò d’andare, dopo morte, a continuare la mia espiazione, se non sarò stato capace in vita di compiere un atto d’amore perfetto.
Ecco la grande pietra sotto il sole accecante del Sahara, la lama d’ombra sulla sabbia calda, la distesa fino all’orizzonte dell’oued solcato dalle tracce dei camion e delle jeep dei petrolieri e dei geologi.
“Sarete giudicati sull’amore” mi ripete sulla mia immobilità questo luogo; e i miei occhi bruciati dal sole guardano lontano il cielo senza nubi.
Non mi voglio più ingannare; non mi posso più ingannare: la realtà è che non sono stato capace di dare la mia coperta a Kadà per paura della notte fredda; il che significa che io amo più la mia pelle di quella del mio fratell, mentre il comandamento di Dio mi dice: “Ama la vita degli altri come la tua.”
E ciò appartiene ancora al Vecchio Testamento, alla prima rivelazione di Dio all’uomo: “Ama Dio sopra ogni cosa e il prossimo tuo come te stesso.” (Dt 6, 5).
Che se veniamo al Nuovo e alla Rivelazione di Gesù, le cose si complicano. “Amatevi tra di voi come Io vi ho amato.” (Gv13, 34).
Come Io! cioè non solo la coperta ma la vita stessa. In realtà l’atto d’amore perfetto consiste nell’essere disposto a fare ciò che fece Gesù: cioè a morire per Kadà, per me, per tutti.
Sotto questa visuale, il Cielo è quel luogo dove ciascuno dei presenti dev’essere talmente “maturo all’amore”, da offrire la sua vita per tutti gli altri. È l’amore perfetto, universale, radicale, senza ombra d’avversità, d’antipatia, di limite, colati in esso come nel fuoco.
Chi è pronto a ciò, alzi la mano!
Per questo, dopo la visione della grande pietra, vedo il mio purgatorio lungo, terribilmente lungo, forse lungo come le epoche geologiche.
Questa sabbia che tocco con le mani, che scorre tra le mie dita appartiene al “Primario”. Un qualunque geologo mi dice: è vecchia di 350 milioni d’anni.
I grandi rettili che popolarono questi luoghi e di cui ho visto i resti nelle fosse sahariane appartengono al secondario: 130 milioni d’anni. Quei cammelli che portano il sale dal Niger e che mi passano dinanzi in carovane lunghe ed eleganti, annoverano i loro progenitori nel lontano terziario: 70 milioni d’anni. E l’uomo, questo uomo così grande e nello stesso tempo così piccolo, con quanta lentezza marcia sui cimiteri di anumali che l’hanno preceduto!
È del quaternario, di ieri: 500.000 anni.
Dio non ha fretta nel fare le cose; e il tempo è suo e non mio. Ed io, piccola creatura, uomo, sono stato chiamato da essere trasformato in Dio per partecipazione. E ciò che mi trasforma è la carità, che Dio ha infuso nel mio essere.
L’amore mi trasforma lentamente in Dio.
E il peccato, è proprio qui: resistere a questa trasformazione, saper e poter dire di no all’amore.
Vivere nel nostro egoismo significa fermarsi allo stato di uomo e impedirne la trasformazione nella carità divina.
E fin tanto che non sarò trasformato “per partecipazione” in Dio, attraverso la carità, sarò di “questa terra” e non di “quel cielo”.
Il Battesimo mi ha elevato allo stato soprannaturale; ma tale stato deve essere maturato, e tutta la vita ci è data per tale maturazione; ed è la carità, cioè l’amore di Dio, che ci trasforma.
L’aver resistito all’amore, il non essere stato capace di accettare la sollecitazione di tale amore che mi aveva detto: “Da’ la coperta al tuo fratello”, è talmente grave, che crea, tra me e Dio, la porta del mio purgatorio.
Che vale dire bene l’Ufficio divino, ascoltare la S. Messa e non accettare l’amore?
Che vale aver rinunziato a tutto, l’essere venuto qua tra la sabbia e il caldo e resistere all’amore?
Che vale difendere la verità, battersi per i dogmi coi teologi, scandalizzarsi di coloro che non hanno la stessa fede e p[oi restare per epoche geologiche sulla porta del purgatorio?
“Sarete giudicati sull’amore”: ecco ciò che mi grida quel pezzo di deserto tra Tit e Silet.
“Sarete giudicati sull’amore” mi dice la grande pietra sotto la quale trascorrerò il mio purgatorio in attesa di maturare in me la carità perfetta, quella che Gesù mi ha recato sulla terra e mi ha donato col prezzo del Suo Sangue, accompagnandolo col grido della grande speranza: “Io vi risusciterò nell’ultimo giorno! ” (Gv 6, 40).
Che quel giorno non sia troppo lontano!
Sei nulla
La grande ricchezza del noviziato sahariano è senza dubbio la solitudine e la gioia della solitudine, il silenzio. Un silenzio, il vero, che penetra per ogni dove, che invade tutto l’essere, che parla all’anima con una forza meravigliosa e nuova, non certo conosciuta dall’uomo distratto.
Quaggiù si vive sempre in silenzio e si impara a distinguerne le sfumature: silenzio della chiesa, silenzio della cella, silenzio del lavoro, silenzio interiore, silenzio dell’anima, silenzio di Dio.
Per imparare a vivere questi silenzi, il maestro dei novizi ci lascia partire per qualche giorno “di deserto”.
Una sporta di pane, qualche dattero, dell’acqua, la Bibbia. Una giornata di marcia: una grotta.
Un sacerdote celebra la S. Messa; e poi parte lasciando nella grotta, su un altare di sassi, l’Eucaristia. Così per una settimana, si resterà soli con l’Eucaristia esposta giorno e notte.
Silenzio nel deserto, silenzio nella grotta, silenzio nell’Eucaristia. Nessuna preghiera è così difficile come l’adorazione dell’Eucaristia. La natura vi si ribella con tutte le forze.
Si preferirebbe trasportare sassi sotto il sole. La sensibilità, la memoria, la fantasia, tutto è mortificato. Solo la fede trionfa; e la fede è dura, è buia, è nuda.
Mettersi dinanzi a ciò che ha l’aspetto di pane e dire: “Lì c’è Cristo vivo e vero”, è pura fede.
Ma nulla nutre di più della pura fede; e la preghiera nella fede è vera preghiera.
“Adorare l’Eucaristia non c’è gusto”, mi diceva un novizio. Ma è proprio questa mortificazione del gusto che rende salda e vera la preghiera.
È l’incontro con Dio al di là della sensibilità, al di là della fantasia, al di là della natura.
Ed è qui il primo aspetto dello spogliamento. Fin tanto che la mia preghiera resta ancorata al gusto, saranno facili gli alti e bassi; le depressioni seguiranno gli entusiasmi effimeri. Sarà sufficiente un mal di denti per liquidare tutto il fervore religioso dovuto ad un po’ di estetismo o a un moto di sentimento.
“Occorre spogliare la tua preghiera”mi dice il maestro dei novizi. “Occorre semplificare, disintellettualizzare. Mettiti dinanzi a Gesù come un povero: senza idee, ma con fede viva. Rimani immobile in un atto di amore dinanzi al Padre. Non cercare di raggiungere Dio con l’intelligenza: non ci riuscirai mai; raggiungilo nell’amore: ciò è possibile”.
La battaglia non è facile; perché la natura vuole la sua rivalsa, vuole la sua razione di godimento, e l’unione con Gesù crocifisso è tuttáltra cosa.
Dopo qualche ora – o qualche giorno – di questa ginnastica, il corpo si placa. Visto che la volontà gli rifiuta il piacere sensibile, non lo cerca più; diventa passivo. Si addormentano i sensi. Il poco mangiare, il molto vegliare e il pregare con umile insistenza rendono la casa dell’anima una dimora silenziosa, pacificata. I sensi dormono. Meglio, come dice S. Giovanni della Croce, è la “notte dei sensi” che comincia. Allora la preghiera diventa una cosa seria, anche se dolorosa e arida. Così seria che non se ne può più fare a meno. L’anima entra nel lavoro redentivo di Gesù.
Inginocchiato sulla sabbia, dinanzi al rudimentale ostensorio che conteneva Gesù, pensavo al male del mondo: odi, violenze, turpitudini, impurità, menzogne, egoismi, tradimenti, idolatrie, adulteri. Attorno a me la grotta era diventata vasta come il mondo; e i miei occhi interiori contemplavano Gesù oppresso sotto il peso di tanto male.
L’Ostia non è forse, nella sua stessa forma, come pane schiacciato, tritato, cotto? E non conteneva essa forse l’Uomo dei dolori, il Cristo vittima, l’Agnello sgozzato per i nostri peccati?
E qual era la mia posizione vicino a Lui?
Per molti anni avevo pensato di essere “qualcuno”nella Chiesa. Avevo perfino immaginato questo sacro edificio vivente come un tempio sostenuto da molte colonne piccole e grandi e sotto ogni colonna la spalla di un cristiano.
Anche sulle mie pensavo gravasse una sia pur piccola colonna.
A forza di ripetere che Dio aveva bisogno degli uomini e che la Chiesa aveva bisogno di militanti, vi avevamo creduto.
L’edificio gravava sulle nostre spalle.
Iddio, dopo aver creato il mondo, s’era messo a riposo; il Cristo, fondata la Chiesa, era scomparso nel Cielo. Tutto il lavoro era restato a noi, alla Chiesa. Soprattutto noi dell’Azione Cattolica eravamo i veri facchini, che sostenevano il peso della giornata.
Con questa mentalità non ero più stato capace d’andare in vacanza; anche la notte mi sentivo militante. Ed era tanto il lavoro, che, per espletarlo, il tempo non era più sufficiente. Si procedeva sempre di corsa da un impegno all’altro, da una adunanza all’altra, da una città all’altra.
La preghiera era affrettata, i discorsi concitati, il cuore agitato.
Siccome tutto dipendeva da noi e il tutto andava così male, si aveva ben ragione di essere inquieti.
Ma chi si era accorto di ciò? Sembrava sì giusta e sì vera la via dell’azione!
Già da piccoli s’era incominciato col ritornello: “Primi in tutto per l’onore di Cristo Re”; quindi, diventati giovani: “Tu sei guida”; diventati adulti: “Sei un responsabile, sei un capo, sei un apostolo”… A forza di essere “qualcosa” sempre, la piega dell’anima era stata presa; e le parole di Gesù: “Voi siete servi inutili”, “Senza di me non potete far nulla”, “Chi di voi vuol essere il primo sia l’ultimo” sembravano dettate per altra gente, per altri tempi; e scorrevano sulla pietra dell’anima senza più intaccarla, bagnarla, ammorbidirla.
È caratteristica la parabola della mia vita. Il mio primo maestro mi aveva detto: “Primo in tutto per l’onore di Cristo Re”; e l’ultimo, Charles de Foucauld, mi aveva suggerito: “Ultimo di tutti per l’amore di Gesù Crocifisso”.
Eppure può darsi che tutti e due avessero ragione e che il colpevole fossi io a non capire bene la lezione.
In ogni caso ora ero là, in ginocchio, sulla sabbia della grotta che aveva preso le dimensioni della Chiesa stessa; e sentivo sulle mie spalle la famosa colonnina del militante. Forse era questo il momento di vederci chiaro.
Mi trassi indietro di colpo, come per liberarmi da quel peso. Che cosa avvenne? Tutto rimase al suo posto, immobile. Non una scalfittura nella volta, non uno scricchiolio.
Dopo venticinque anni mi ero accorto che sulle mie spalle non gravava proprio niente e che la colonna era falsa, posticcia, irreale, creata dalla mia fantasia, dalla mia vanità.
Avevo camminato, corso, pedalato, organizzato, lavorato, credendo di sostenere qualcosa; e in reltà avevo sostenuto proprio nulla.
Il peso del mondo era tutto su Cristo Crocifisso. Io ero nulla, proprio nulla.
Ce n’era voluto a credere alle parole di Gesù che da duemiola anni mi aveva già detto: “Voi, quando avete fatto tutto ciò che vi è stato comandato dite: Siamo servi inutili, perché abbiamo solo fatto il nostro dovere” (Lc 17, 10).
Servi inutili !
Chi guida le cose del mondo?
La prima impressione che mi lasciò questa avventura fu quella della libertà. Una libertà nuova, ampia, autentica, gioiosa.
L’aver scoperto che ero nulla, che non ero responsabile di nessuno, che non ero un uomo importante, mi diede la gioia di un ragazzino in vacanza.
Venne la notte e non dormii. Mi allontanai dalla grotta e camminai sotto le stelle in pieno deserto.
“Dio mio, ti amo; Dio mio, ti amo”, gridavo verso il cielo nello straordinario silenzio.
Stanco di camminare, mi stesi su una duna di sabbia e immersi gli occhi nella volta stellata. Come mi erano care quelle stelle; e come il deserto me le aveva avvicinate! A forza di passare le notti all’addiaccio, ero stato spinto a saperne il nome, poi a studiarle, a conoscerle ad una ad una. Ora ne distinguevo il colore, la grandezza, la posizione, la bellezza. Sapevo orientarmi su di esse al primo colpo d’occhio; e dalla loro posizione deducevo l’ora senza bisogno di orologio.
Ecco la costellazione del Cigno, che sembra in conversazione con Altair, chiara come un brillante. Saetta e il Delfino sembrano ascoltare, chiusi nella loro umile piccolezza. Pegaso sta montando ad oriente col suo quadrato di stelle, mentre Perla scompare ad occidente. Tra poco la rossa Angol mi condurrà l’eleganza di Perseo.
Ritorno con gli occhi su Andromeda. Ed è così chiara la notte, che incomincio a scorgere la nebulosa che porta il nome della costellazione.
È il corpo celeste più lontano dalla terra, visibile ad occhio nudo: 800 mila anni luce.
Tra quella enorme distanza e la più piccola – quattro anni luce di Proxima, che mi apparirà tra due anni nella costellazione del Centauro – ci sono le distanze di tutto questo ammasso di 40 miliardi di stelle a cui ammonta la Galassia alla quale noi – piccolo granello di sabbia chiamato Terra – apparteniamo.
E al di là della nebulosa di Andromeda, altri milioni di nebulose e miliardi di stelle che i miei occhi non vedono ma che Dio ha creato.
Perché non mi è mai saltato in testa che una pur piccola colonna che regge il cosmo non gravi sulle mie spalle? Ed è forse il cosmo diverso dagli uomini?
Ed io l’avevo pensato.
È vero che Gesù aveva detto: “Andate e istruite tutte le genti” (Mt 28, 18), ma aveva aggiunto: “senza di me non potete far nulla”(Gv 15, 5). È vero che S. Ignazio aveva detto: “Fate come se tutto dipenda da voi”; ma aveva aggiunto: “però aspettate come se tutto dipenda da Dio”.
Dio è il creatore del cosmo fisico, come è il creatore del cosmo umano. Dio è il reggitore delle stelle come è il reggitore della Chiesa. E se ha voluto, per amore, rendere gli uomini collaboratori suoi nella salvezza, il limite del loro potere è ben piccolo e determinato: è il limite del filo rispetto alla corrente elettrica.
Noi siamo il filo, Dio è la corrente. Tutto il nostro potere sta nel lasciar passare la corrente. È certo: abbiamo il potere di interromperla, abbiamo il potere di dir di no; ma nulla di più.
Non l’immagine, quindi, di colonna che sostiene, ma di filo che trasmette un potere.
Ma altro è il filo, altro è la corrente; son di natura ben diversa; e il filo non può certo insuperbire, anche se è un filo che trasmette corrente ad alta tensione.
Il pensare che le cose del mondo, come quelle degli astri, siano in mano a Dio – quindi in buone mani – , oltre ad essere la pura verità, è cosa che dovrebbe fare immenso piacere a chi ci tiene che le cose vadano bene.
Dovrebbe essere fonte di fede serena, di speranza gioiosa e soprattutto di pace profonda. Che cosa posso temere, se il tutto è guidato e sorretto da Dio? Perché agitarmi tanto, come se tutti questi problemi dipendessero da me o dai miai colleghi, gli uomini; e non cercare, invece, di capire che ci sono altre vie più interessanti e più efficaci da battere?
Eppure è così difficile credere radicolmente all’azione di Dio nelle cose del mondo! Ed è, penso, la tentazione più frequente e prolungata, a cui siamo sottoposti su questa povera terra.
Tutta la Bibbia è là a testimoniare questo dramma; e, in fondo, la storia del popolo eletto non è altro che la storia d’un pugno d’uomini a cui Dio chiede continuamente e in ogni occasione: “Credi in me? Io sono il Dio di Abramo, d’Isacco e di Giacobbe. Io sono il Dio che con mano forte ti ho tratto dalla schiavitù d’Egitto, t’ho guidato in una terra riarsa, t’ho nutrito di manna dal cielo e t’ho dato a bere l’acqua scaturita dalla roccia. Per te ho colpito i primogeniti d’Egitto, per te ho atterrato re potenti. E che hai fatto per ricompensarmi di questi prodigi, di questa assistenza continua? Ti sei costruito idoli di legno e d’argento e ha abbandonato ma, tuo Dio”.
“Invece di adorare Colui che ti ha creato e salvato le mille volte dai tuoi nemici, su colli prominenti e in boschi sacri, hai bruciato incensi a dei stranieri; dei che nulla possono, nulla sanno; dei che hanno le mani e non toccano, hanno piedi e non camminano, e nessun suono esce dalla loro bocca”(Sal 113, 5).
Questa è la storia di sempre, storia d’Israele e storia nostra. Anche noi crediamo in Dio; ma poi ci fidiamo dei potenti, crediamo alle loro raccomandazioni e finiamo di pensare che le cose di questo mondo sono salde nelle loro mani e che a loro dobbiamo chiederle.
Anche noi crediamo in Dio e lo preghiamo; ma poi ci convinciamo che sono i grandi predicatori a convertire le anime; e riduciamo la nostra preghiera per l’estensione del Regno a un qualche cosa di futile, come la petizione ad un ufficio da cui non speriamo quasi nulla.
Così, sotto un cielo strano, in una penombra di fede e di sentimentalismo, in una equidistanza tra Dio e il mondo, trascorre la nostra povera vita religiosa mescolata di preghiere, di contraddizioni e di compromessi.
Il pensare che le cose del mondo, come quelle degli astri, siano in mano a Dio – quindi in buone mani – , oltre ad essere la pura verità, è cosa che dovrebbe fare immenso piacere a chi ci tiene che le cose vadano bene.
Dovrebbe essere fonte di fede serena, di speranza gioiosa e soprattutto di pace profonda. Che cosa posso temere, se il tutto è guidato e sorretto da Dio? Perché agitarmi tanto, come se tutti questi problemi dipendessero da me o dai miei colleghi, gli uomini; e non cercare, invece, di capire se ci sono altre vie più interessanti e più efficaci da battere?
Eppure è così difficile credere radicalmente all’azione di Dio nelle cose del mondo! Ed è, penso, la tentazione più frequente e prolungata, a cui siamo sottoposti su questa povera terra.
Tutta la Bibbia è là a testimoniare questo dramma; e, in fondo, la storia del popolo eletto non è altro che la storia d’un pugno di uomini a cui Dio chiede continuamente e in ogni occasione: “Credi in me? Io sono il Dio di Abramo, d’Isacco e di Giacobbe. Io sono il Dio che con mano forte ti ho tratto dalla schiavitù d’Egitto, t’ho guidato in una terra riarsa, t’ho nutrito di manna del cielo e t’ho dato da bere l’acqua scaturita dalla roccia. Per te ho colpito i primogeniti d’Egitto, per te ho atterrato re potenti. E che hai fatto per ricompensarmi di questi prodigi, di questa assistenza continua? Ti sei costruito idoli di legno e d’argento e hai abbandonato me, tuo Dio.”
“Invece di adorare Colui che ti ha creato e salvato le mille volte dai tuoi nemici, su colli prominenti e in boschi sacri, hai bruciato incensi a dei stranieri; dei che nulla possono, nulla sanno; dei che hanno le mani e non toccano, hanno piedi e non camminano, e nessun suono esce dalla loro bocca.” (Sal 113, 5)
Questa è la storia di sempre, storia d’Israele e storia nostra. Anche noi crediamo in Dio; ma poi ci fidiamo dei potenti, crediamo alle loro raccomandazioni e finiamo di pensare che le cose di questo mondo sono salde nelle loro mani e che a loro dobbiamo chiederle.
Anche noi crediamo in Dio e lo preghiamo; ma poi ci convinciamo che sono i grandi predicatori a convertire le anime; e riduciamo la nostra preghiera per l’estensione del Regno a un qualcosa di futile, come la petizione ad un ufficio da cui non speriamo quasi nulla.
Così, sotto un cielo strano, in una penombra irreale di fede e di sentimentalismo, in una equidistanza tra Dio e il mondo, trascorre la nostra povera vita religiosa mescolata di preghiere, di contraddizioni e di compromessi.
Dio solo è, Dio solo sa, Dio solo può. Questa è la verità; e la mia fede me la fa scoprire di giorno in giorno più profondamente.
Dio solo è reggitore del cosmo, Dio solo sa quando morrò, Dio solo può convertire la Cina.
Perchè assumersi responsabilità che non abbiamo, perchè stupirci se l’Islam non ha ancora scoperto il Cristo e se il Buddismo regna senza inquietudini e crisi in milioni di fratelli? Verrà l’ora; ma questa non dipende da me.
C’è o non c’è una geografia di Dio, una storia sacra per tutti i popoli, un procedere nel tempo verso una maturità?
Abramo non conobbe il Cristo, se non nella speranza della promessa; ma non per questo andò perduto o fu dimenticato dal Padre. Non era giunto il tempo dell’Incarnazione; e se Gesu quando venne, e non prima, ha seguito certamente le indicazioni della Saggezza Eterna. Ci sono i piani di Dio, e questi contano; ci sono i piani umani, e questi non contano, o almeno contanoin rapporto al loro sincronizzarsi con i primi.
Ma è Dio che precede, non l’uomo. Maria stessa poteva morire nell’attesa senza vedere il Cristo, se Dio non decideva esser giunta l’ora dell’Incarnazione. Gli uomini di Galilea avrebbero continuato a pescare nel lago e a frequentare la sinagoga di Cafarnao, se non fosse venuto Lui a dire: “Venite”.
Ecco la verità che dobbiamo imparare nella fede: l’attesa di Dio; e questo non è un piccolo sforzo come atteggiamento dell’anima. Questo “attendere”; questo “non preparare piani”; questo “scrutare il cielo”; questo “far silenzio” è la cosa più interessante che compete a noi.
Poi verrà anche “l’ora della chiamata”; l’ora in cui si deve parlare, in cui la mano sarà stanca di battezzare; l’ora della messe, insomma. Ma ciechi, ciechi noi se in tale ora penseremo di essere gli attori di tali meraviglie; la meraviglia, semmai, è che Dio si serva di noi così miserabili e così poveri.
Non volevo giungere a questo punto, perchè già sento nell’aria la tristezza di una domanda. E il solo fatto di porre una domanda è un errore o una mancanza di fede.
“Pregare o agire? Attendere o partire? Scendere in piazza o entrare in Chiesa?”
Ed eccoci da capo; là dove l’uomo trasforma tutto in problematica senza mai saziarsi, tanta è la brama di curiosità più che la buona volontà di realizzare la parola di Dio.
Ma oggi non entro più in polemica; non voglio più discutere, non credo più al potere di convincere un uomo con la forza delle parole.
Mi taccio sotto queste stelle d’Africa e preferisco adorare il mio Dio e Signore.
Ma, cedendo all’insistenza vostra o giovani che mi avete scritto fin quaggiù, dico solo una parola che mi pare esatta e, in più, sofferta. Ricordatevi che al mondo tutto è problema, meno una cosa: la carità, l’amore. L’amore solo non è un problema per chi lo vive.
Ebbene vi dico: vivete l’amore, cercate la carità. Essa vi darà la risposta volta per volta a ciò che dovete fare.
La carità, che è Dio in noi, vi suggerirà la strada da percorrere; vi dirà: “ora inginocchiati” oppure “ora parti”.
È la carità che dà valore alle cose, che giustifica “l’inutilità di restare ore e ore in ginocchio a pregare mentre tanti uomini hanno bisogno della mia azione, e la inutilità della mia povera azione dinanzi alla considerazione che la morte distruggerà tutte le civiltà”.
È la carità che gerarchizza le intenzioni degli uomini e che uniforma ciò che è diviso.
La carità è la sintesi della contemplazione e dell’azione, è il punto di sutura tra il cielo e la terra, tra l’uomo e Dio.
Ripeto ancora, dopo aver conosciuto l’azione più sfrenata e la gioia della vita contemplativa nel quadro più sfolgorante del deserto, le parole di S. Agostino: “Ama e fa’ ciò che vuoi”. Non preoccuparti, fratello, di che cosa fare; preoccupati di amare. Non interrogare il Cielo con ripetuti e inutili: “Qual è la mia strada?”; studiati invece di amare.
Amando, scoprirai la tua strada; amando ascolterai la Voce; amando, troverai la pace.
È l’amore la perfezione della legge e la regola di ogni vita, la soluzione di ogni problema, lo stimolo di ogni santità.
“Ama e fa’ ciò che vuoi”.
No; non è più possibile fare ciò che voglio quando amo.
Quando amo devo fare la volontà dell’amato.
Quando amo sono prigioniero dell’amore; e l’amore è tremendo nelle sue esigenze, specie quando questo amore ha per oggetto Dio e un Dio Crocifisso. Non posso più fare la volontà mia; debbo fare la volontà di Gesù, che è volontà del Padre.
E quando avrò imparato a fare questa volontà, avrò realizzato pienamente la mia vocazione sulla terra e raggiunto il grado della mia perfezione.
La volontà di Dio: ecco ciò che regge il mondo, ciò che muove gli astri, ciò che converte i popoli, ciò che chiama alla vita e dona la morte.
La volontà di Dio ha suscitato Abramo, padre della fede, ha chiamato Mosè, ispirato Davide, preparato Maria, sorretto Giuseppe, incarnato il Cristo e chiesto il suo sacrificio, fondato la Chiesa. E sarà ancora la volontà di Dio a continuare l’opera di redenzione fino alla fine dei tempi.
Essa chiamerà i popoli ad entrare ad uno ad uno nel corpo visibile della Chiesa nel momento giusto della loro maturità dopo appartenuto a motivo della loro retta intenzione e volontà “buona” alla sua Anima invisibile.
Che tu sia sulla sabbia in ginocchio ad espiare, ad adorare o che tu sia sulla cattedra ad insegnare, che conta se non lo fai nella volontà di Dio?
E se la volontà di Dio ti spinge a cercare i poveri o a donare i tuoi averi o a partire per terre lontane, che conta tutto il resto?
O se ti chiama a fondare una famiglia, a prendere un impegno nella città terrena, perché dubitare?
“In la sua volontade è nostra pace” dice Dante; ed è forse l’espresione più riassuntiva di tutta la nostra dolce dipendenza da Dio.
Purificazione del cuore
Che noi siamo fatti per amare è evidente. Il difficile però è stabilire che cosa amare e come amare.
Penso che non sia sbagliato e contrario al nostro fine “amare la creatura”. Ed è certamente secondo il nostro fine “amare Dio”. Quindi dovremmo amare la creatura e dovremmo amare il Creatore.
Ma perché nella tradizione cristiana questi due amori si sono posti in contraddizione, in antagonismo, quasi che amando l’una non sia più possibile amare l’Altro?
La causa risiede in noi, va ricercata in noi.
È il nostro cuore che non è più capace di amare, che è come uno strumento deteriorato e che funziona male.
Il cuore, questo benedetto cuore, quando ama la creatura, troppo facilmente perde l’equilibrio.
Si lancia su di essa, la vuole fare sua, esclusivamente sua; aderisce ad essa con tale passione, da perdere di vista l’insieme. In più, avvelena la creatura con rapporti sregolati; la rovina, la fa schiava, o, meglio, si fa schiavo di essa.
Caratteristico in tal senso, perché più violento, è l’amore esclusivo del sesso, con tutta la serie orribile di gelosie ed egoismi.
Non meno caratteristica è la cosiddetta “amicizia particolare”, nella quale il cuore umano si attacca all’amico perdendo la pace, la serenità, la visione equilibrata delle cose; nel peggiore dei casi, anche la purezza.
Che diremmo poi dell’amore del denaro? Della schiavitù in cui tiene l’uomo l’amore della ricchezza?
Perfino l’amore del lavoro diventa pericoloso, tanto più se ammantato di virtù! Quanti contadini non sono più capaci di riposarsi la domenica, dominati dalla passione che, come frenesia, li sospinge nei campi!
E quanti industriali trasformano la loro vita in un inferno, ingoiati dalla macchina degli impegni.
E più si sale peggio è: l’amore allo studio può creare mostri di egoismo; e la passione della ricerca, collezionisti pazzi e ciechi come termiti nella loro galleria oscura.
In tale situazione è evidente che l’amore della creatura è in opposizione all’amore di Dio.
Questo – l’amore di Dio – è per sua natura universale, casto, equilibrato, santo.
Chi è sotto il suo dominio, vive in una pace profonda, ha la visione gerarchizzata delle cose, sa che cos’è la libertà.
Ma anche l’amore di Dio, passando nel cuore dell’uomo, deve essere lavorato, coltivato, potato, fecondato; e Dio stesso ne è l’abile e intransigente agricoltore.
Soprattutto tale amore deve essere purificato.
Che cosa significa purificare l’amore?
Significa purificarlo dalle pastoie della sensibilità, dal vischio del gusto; in altri termini, significa renderlo “gratuito”.
Rendere gratuito l’amore! Quale difficile impresa per creature come noi, ripiegate dal peccato su se stesse, chiuse il più delle volte nel loro onnipossente egoismo!
Sovente non ci rendiamo conto della profondità del male, che è abissale.
Non parlo solo dell’egoismo del ricco che accumula per sé; del violento che sacrifica tutto al proprio godimento; del dittatore che respira l’incenso dovuto solo a Dio.
Parlo dell’egoismo dei buoni, delle anime pie, di coloro che son riusciti, a forza di ginnastica spirituale e di rinunce, a poter dire dinanzi all’altare dell’Onnipotente la superba professione: “Signore, non sono come gli altri uomini” (Lc 18, 11).
Sì, abbiamo avuto il coraggio – in certi periodi della nostra vita – di crederci diversi dagli altri uomini. E qui sta la menzogna più radicale, dettata dall’egoismo più pericoloso: quello dello spirito. E su tale menzogna il nostro egoismo fa la sua costruzione babelica, riuscendo a servirsi della stessa pietà, della stessa preghiera per soddisfarsi.
È il momento dell’assalto all’altare, è il momento in cui lo stesso desiderio di santità è rovesciato: non è amore e imitazione di Cristo Crocifisso, è desiderio di gloria; non è carità, è egoismo.
Non dubito nel dire che un’alta percentuale dei desideri che spingono l’anima a cercare Dio è inquinata di egoismo. Si può giungere al punto di consacrarsi a Dio per egoismo, di farci religiosi per egoismo, di costruire ospedali per egoismo, di fa penitenza per egoismo.
Non c’è limite a tale menzogna. E la via, una volta infilata, è così sdrucciolevole e pericolosa, da obbligare Dio, per salvarci, a trattarci male; direi apparentemente, a diventare crudele con noi.
Ma non c’è altra via per aprirci gli occhi.
È la via del dolore. All’anima che dà l’assalto al Cielo per egoismo, Dio sbarra il cammino col freddo, con l’aridità, con la notte. Le consolazioni si trasformano in amarezze, le gioie in assenzio, le spine crescono per ogni dove. le nubi sembrano fatte per arrestare la preghiera.
Ma sovente non basta. Rovesci, malattie, disillusioni, vecchiaia si abbattono come uccelli di rapina sulla povera carcassa che aveva avuto il coraggio di affermare a se stessa: “Signore, non sono come gli altri uomini”.
Rimane ben poco per sostenere la tesi di essere diverso dagli altri, quando ci si accorge che si grida, che si piange, che si ha paura, che si è deboli, si è vili proprio come gli altri uomini.
Ecco la voce dell’uomo nel Salmo 87:
Signore mio Dio
tutto il giorno io ti chiamo
e la notte gemo davanti a Te.
La mia anima è abbeverata di mali,
la mia vita è un bordo dell’inferno.
Io sono già come colui che discende nella tomba,
come l’uomo stremato di forze.
Tu mi hai gettato nella fossa profonda,
nelle tenebre, nell’abisso.
Su di me
s’è appesantito il tuo furore;
sulla cresta dell’onda Tu mi schiacci.
È la purificazione dell’amore, è il fuoco che brucia le scorie per metterci a nudo.
E Dio stesso, che è l’Amore, non può far nulla. Anzi, perché è l’Amore appesantisce la mano.
Se l’anima non si libera attraverso la croce, non potrà esser liberata.
È la tremenda operazione chirurgica che il Padre stesso compie sulle carni del figlio pue di salvarlo. Ed è dogma di fede che senza croce “non fit remissio”.
È un mistero ma è così. Il dolore purifica l’amore; lo rende vero, autentico, puro; e, in più, elimina ciò che non è amore.
Distacca l’amore dal gusto che come maschera lo falsa; lo rende gratuito.
Quando il diluvio del dolore è passato sull’anima, ciò che resta di vivo può considerarsi autentico. È certo che non resta molto. Sovente è ridotto ad un arbusto esile, esile; ma su di esso la colomba dello spirito può posarsi per portare i suoi donio; è ridotto a un “sì” mormorato tra le lacrime e le angosce, ma ad esso fa eco il “sì” onnipotente di Gesù agonizzante; è ridotto a un bimbo che ha cessato di fare polemiche con Dio e con gli uomini, ma al quale soccorre l’abbraccio del Padre.
In questo stato, l’uomo è capace di amore gratuito; anzi non può più sopportarne d’altro timbro: prova nausea dinanzi al sentimentalismo, ha ribrezzo delle cose amate per calcolo. È entrato finalmente nella logica di Dio, spesso illogica all’uomo di questa terra.
Ecco la logica della più famosa parabola sulla gratuità dell’amore.
Sentiamola:
Il Regno dei Cieli infatti è simile a un padre di famiglia il quale uscì di primo mattino per assoldare lavoratori per la sua vigna.
Accordatosi coi lavoratori per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna.
E uscito verso la terza ora, vide altri che stavano in ozio sulla piazza e disse loro: “Andate anche voi nella mia vigna ed io vi darò ciò che è giusto. E quelli vi andarono.
Uscito ancora verso la sesta e la nona ora, fece altrettanto. Uscito poi verso l’undicesima ora, ne trovò altri che se ne stavano là; e dice loro: “Perché ve ne state qui tutta la giornata in ozio?”.
Gli dicono: “Perché nessuno ci ha assoldati”.
Dice loro: “Andate anche voi alla vigna”.
Fattasi sera, il padrone della vigna dice al fattore: “Chiama i lavoratori e paga loro il salario a cominciare dagli ultimi fino ai primi.
Vennero quelli dell’undicesima ora e presero un danaro ciascuno.
Quando vennero i primi, credettero di prendere di più; ma anch’essi ricevettero un danaro ciascuno. Mentre lo prendevano, mormoravano contro il padre di famiglia, dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto; e tu li hai trattati come noi che abbiamo portato il peso della giornata e il caldo”.
Ma egli, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, non ti fo torto. Non hai pattuito con me per un denaro? Prendi quel che ti spetta e vattene. Voglio dare a quest’ultimo come a te.
“O non mi è permesso di fare quel che voglio della mia roba?Non posso fare delle mie cose quello che voglio?
“Oppure il tuo occhio è maligno perché io sono buono?” (Mt 20, 1ss).
Capire questa parabola, per noi che abbiamo “l’occhio maligno”, non è facile. Fortunato colui che la capisce qualche giorno prima di morire. Significa che il suo occhio vede ora giusto e quindi può entrare nel regno della gratuità, che è il regno del vero amore.
In cammino verso la “preghiera”
Son venuto nel deserto per pregare, per imparare a pregare.
È stato il grande dono che mi ha fatto il Sahara, dono che vorrei trasmettere a tutti coloro che amo, dono incommensurabile, dono che riassume ogni altro dono, il “sine qua non” della vita, il tesoro sepolto nel campo, la perla preziosa scoperta sul mercato.
La preghiera è il sunto del nostro rapporto con Dio.
Potremmo dire che noi siamo ciò che preghiamo.
Il grado della nostra fede è il grado della nostra preghiera; la forza della nostra speranza è la forza della nostra preghiera; il calore della nostra carità è il calore della nostra preghiera. Né più né meno.
La nostra preghiera ha avuto un principio perché noi abbiamo avuto un principio; ma non avrà fine, e ci accompagnerà nell’eterno, e sarà il respiro della nostra contemplazione estatica di Dio, e il canto della nostra felicità eterna, quando saremo “saziati al torrente delle delizie di Dio”(Sal 35).
La storia della nostra vita terreno-celeste sarà la storia della nostra preghiera. È, quindi, e innanzi tutto una storia personale.
Come non c’è fiore uguale ad altro fiore, una stella uguale ad un’altra stella, così non c’è uomo uguale ad un altro uomo. Ed essendo la preghiera il rapporto di questo uomo con Dio, tale rapporto è diverso per ciascun uomo. Non c’è quindi una preghiera uguale ad un’altra preghiera.
È una parola che varia sempre, fosse anche ripetuta all’infinito con le stesse sillabe e con lo stesso tono di voce.
Ciò che varia è lo spirito del Signore che l’anima; e questo non si ripete mai, è sempre nuovo.
S. Bernardetta Soubirous, che non sapeva dire se non “Ave Maria”; o il mistico che non può più ripetere se non un monosillabo “Dio”, hanno la preghiera più varia e personale che immaginar si possa; perché, sotto il velo di quell’unica parola, passa solo e tutto lo spirito di Gesù che è lo spirito del Padre.
Per capire bene la preghiera, è necessario capire che si parla con Dio.
Ci sono quindi due poli: l’uno piccolo piccolo, debole debole: la mia anima; uno immenso e onnipotente: Dio!
Ma qui sta la prima grandezza e la prima sorpresa: che Lui, così grande, abbia voluto parlare con me, così piccolo; Lui, Creatore, con me creatura.
Non sono stato io che ho voluto la preghiera; è Lui che l’ha voluta. Non sono stato io che l’ho cercato; è stato Lui che mi ha cercato per primo. Vano sarebbe stato il mio cercare Lui se prima di tutti i tempi non fosse stato Lui a cercare me.
La speranza su cui poggia la mia preghiera sta nel fatto che è Lui che vuole la mia preghiera. E se vado all’appuntamento è perché Lui c’è già ad attendermi.
Se Lui fosse rimasto nel suo silenzio e nel suo isolamento, io non avrei potuto rompere il mio. Nessuno s’è mai messo lungamente a parlare con un muro, un albero, una stella. Se l’ha fatto, ha smesso ben presto, non ottenendo risposta.
Con Dio, è tutta la vita che parlo; e non ho che incominciato!
C’è un’altra cosa che va detta parlando della preghiera: non viene dalla terra, ma dal Cielo.
Il grido che mi gonfia il petto e che mi fa esclamare: “Dio, ti amo”; lo sforzo che fa ripetere a Faraggì, il musulmano cieco, quando cammina sulla pista vicino a me: “Com’è grande Iddio!”; il pianto di Davide: “Miserere”; l’esaltazione di Maria: “Magnificat”; la lacrima che spunta sulle ciglia di chi si confessa: “Gesù perdonami”; l’improvviso arrestarsi estatico dello scienziato dinanzi alle meraviglie dell’universo, sono opere dello Spirito Santo.
È lo Spirito del Signore che riempie il mondo e che ci fa gridare: “Padre!”; che immette in noi la corrente della preghiera.
A noi il compito di prestare leste le labbra e riconoscente il cuore al passaggio della corrente divina; e di ripetere, ripetere ciò che lo Spirito di Gesù ci ha suggerito e ci dà forza di dire.
È certo che possiamo resisterGli – come per l’amore -; possiamo dire di no, possiamo disperdere nel pozzo nero della nostra anima la corrente che passa, possiamo chiudere le labbra, possiamo tacere. Ed è ciò che facciamo il più delle volte; perché, se fossimo solleciti al richiamo, saremmo in continua preghiera.
Per essere precisi, dobbiamo aggiungere che c’è anche una preghiera diremo “nostra”, cioè nata sulla terra, nel cuore dell’uomo. Ma questa preghiera non è gran cosa: sovente è un po’ di pettegolezzo spirituale; un domandare cose che non servono al nostro vero bene e che ci farebbero del male se ci fossero concesse; un riempire la bocca di parole pie per paura della solitudine o del dolore, da cui Gesù ci aveva già tenuto in guardia. “Quando pregate… non fate come i pagani…”(Mt 6, 7).
Se vogliamo un paragone sul valore di questa preghiera (diremo “non isrpirata”) rispetto all’altra, la vera, quella dettata in noi dallo Spirito del Signore, diremmo che tra le due s’interpone la stessa distanza che passa tra ciò che di Dio ci han detto i filosofi e ciò che di Lui ci han detto la Bibbia e la Chiesa. I Filosofi, dopo prestigiose elucubrazioni e infinite dissenzioni, son riusciti a mala pena a mettersi d’accordo sull’esistenza di Dio. La Chiesa ha di Dio una conoscenza personale vivente, calda, appassionata, anche se oscura e racchiusa nel buio della fede.
In ogni caso, di questa preghiera non c’è gusto d’interessarsi: ben la conosciamo.
Quante volte ci siamo ritrovati con la bocca piena di essa, lontani dallo Spirito di Dio! Quante volte ci siamo rifugiati in essa proprio per sfuggire allo Spirito di Dio, alla Sua Volontà!
Siamo andati in coro a recitare il breviario, mentre il nostro dovere era d’andare in parlatorio a ricevere qualche povero noioso e puzzolente; abbiamo detto il rosario mentre andavamo ad un appuntamento pericoloso per la nostra anima; abbiamo acceso una candela per diventare ricchi; abbiamo piegato la nostra testa in adorazione mentre il nostro cuore era pieno d’amore impuro.
Questa preghiera non viene dal Cielo, ma dalla terra; e sulla terra rimane, ricca solo della sua inutilità e del suo inganno.
Di essa il Profeta dirà: “Metterò le nubi per fermarla”(Lam 3, 43). Ma credo che non ci sia nemmeno bisogno delle nubi, perché essa non si alza di un palmo, al di sopra della nostra cieca cocciutaggine.
Sì; cieca cocciutaggine che può durare anni, decenni; che crea in noi un’ambiguità farisaica, che ci vede all’altare di giorno e con l’amante di notte, ricchi di danaro e col rosario in mano, ripiegati sul nostro egoismo e con la mente piena di belle idee per riformare la Chiesa.
Non ci son lacrime a sufficienza per piangere questi nostri misfatti, questa nostra falsa testimonianza a Gesù Verità e Amore, questo velare la potenza folgorante del Vangelo sotto la cortina fumosa d’una religiosità che non cerca e non compie la volontà di Dio.
Perché qui sta il punto: la vera preghiera comincia quando si cerca la volontà di Dio.
In fondo, le cose sono semplici, estremamente semplici: basta ascoltare ciò che ci ha detto Gesù, basta prendere il Vangelo e mettere in pratica ciò che Egli ci ha detto.
Insomma, si tratta di volontà, non di parole.
L’ispirazione divina cerca in noi la buona volontà. Lo spirito di Gesù si posa là dove la volontà lo desidera, perché è l’Amore; e per fare l’amore bisogna essere in due.
Quando io mi chino al suo Amore, Egli non tarda a venire; anzi, è già venuto, perché mi ama ben di più di quanto io, povera creatura, possa amare Lui.
E l’amore si dimostra a fatti, come per il figliuol prodigo:
l’alzarsi è un fatto, l’abbandonare i porci è un fatto.
Bisogna che l’anima dica seriamente: “Ora torno al Padre”(Lc 15, 18).
I tempi della preghiera
La preghiera è innanzitutto parola, recitazione, canto.
China, o Signore, il tuo orecchio
e ascoltami,
perché misero e povero io sono.
Guidami, o Signore, per la tua via;
ch’io cammini nella Tua verità.
Si rallegri il mio cuore
a temere il tuo nome. (Sal 85)
Sovente racchiude un grido, un pianto, un lamento d’angoscia:
O Signore, Dio della mia salvezza, di giorno e di notte io grido dinanzi a Te. Giunga al Tuo cospetto la mia preghiera, perché satura di mali è l’anima mia e la mia vita è vicino all’averno.
Son contato tra quei che scendono nella fossa.
Son diventato come un uomo senza soccorso.
Tra i morti sono, benché libero e vivo ancora.
Come gli uccisi che dormono nei sepolcri dei quali più non ti ricordi e alla tua mano sono stati strappati. (Sal 87)
Qualche volta un’esplosione di felicità:
Io t’amo, mio Dio, mia forza.
Il Signore è il nio sostegno.
Il mio Dio è l’aiuto in cui spero. (Sal 17)
Un’ammirazione estatica delle sue opere:
I cieli narrano la gloria di Dio,
e le opere delle sue mani
annunzia il firmamento. (Sal 18)
La lode appassionata della Sua Provvidenza:
Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca.
In erbosi pascoli mi fa posare.
Presso refrigeranti acque mi nutre,
ristora l’anima mia.
Mi guida per retti sentieri a motivo del suo nome.
Quand’anche camminassi nell’ombra della morte,
non temerei sciagure, poiché Tu sei con me. (Sal 22)
Questa maniera di parlare con Dio è di tutte le epoche, e di tutti i luoghi. Dall’inizio della vita spirituale al termine, l’uomo si servirà di questo mezzo – la parola – per esprimere i suoi sentimenti col suo Creatore.
Ma anche qui è come nell’amore: le parole abbondano al principio, poi si fanno più rare e più profonde, finché si riducono a qualche monosillabo che racchiude però tutto.
Normalmente un’anima parla molto al tempo della sua conversione, nel periodo del suo noviziato, nei primi anni della sua scoperta di Dio. È il periodo più facile per l’anima, anche perché tutto concorre a rivestire la preghiera: novità, sentimento, fantasia, arte, passione.
E Dio, in più, mette la sua parte di consolazione. E tutto fluisce come ai primi tempi di un matrimonio felice.
Pronto è il mio cuore, o Dio,
pronto è il mio cuore.
Canterò e inneggerò a Te.
Sorgi, mia gloria, sorgi
arpa e cetra.
Voglio destare l’aurora.
Ti celebrerò fra i popoli,
o Signore.
E inneggerò a Te fra le nazioni;
perché grande, oltre i cieli
è la tua benignità
e sino alle nubi
la tua fedeltà. (Sal 107)
* * *
Un altro tempo della preghiera è la “meditazione”. Qualche volta segue dappresso la parola. Specie quando l’anima è matura, s’intercala con essa, si fonde con essa. Qualche volta vien dopo, accompagnata da una serie di verità e di luce.
È il tempo del libro, il tempo in cui si cerca di sapere ciò che altri han detto di Dio; è il tempo fervido della riflessione, dello studio teologico; tempo di discussioni filosofiche, tempo di incontri d’anime, tempo bello, molto bello.
Se il mondo sapesse la gioia che prova un cristiano in questo periodo, la pace che regna nel suo cuore e l’equilibrio che domina le sue facoltà, ne rimarrebbe stupito, incantato.
Io l’ho conosciuto tale periodo; e ho avuto la fortuna di viverlo con centinaia, con migliaia di altri giovani. Dio, la Chiesa, le anime erano le nostre sole pasioni. Ci sembrava ad ogni alba di dover forgiare un mondo nuovo, ci si lanciava contro l’errore come Davide contro Golia, ci si incontrava numerosi per pregare e parlare di Dio.
Che importavano le notti insonni, i lunghi viaggi in terza classe, le galoppate in bicicletta nelle campagne per destare il movimento, i sacrifici economici e le ferie sacrificate per fare una volta all’anno gli Esercizi Spirituali? Questi restano tra i più cari ricordi della mia vita, ricordi a cui torno con gioia e pace serena.
* * *
Ma torniamo alla meditazione. Ci sono mille maniere di fare meditazione, ed è bene che ciascuno faccia la sua esperienza. Si accorgerà, camminando, ciò che gli è più adatto. Vorrei soltanto dire qui due cose che ho imparato dal mio grande maestro S. Giovanni della Croce: l’una sul metodo della meditazione e l’altra sul libro da scegliere.
Sul metodo – S. Giovanni lo divideva in tre parti – e fin qui niente di nuovo.
1. Rappresentazione immaginativa del mistero sul quale si vuol meditare.
2. Considerazione intellettuale dei misteri rappresentati (anche qui nulla di nuovo).
3. (ed è importante) Ri poso amoroso e attento a Dio per raccogliere il frutto là dove s’apre all’illuminazione divina la porta della intelligenza.
Questo sforzo amoroso, profondamente umano, deve sfociare in una serenità, in un riposo affettuoso dinanzi a Dio. Cioè, dev’essere una meditazione orientata nettamente verso la semplificazione e il silenzio interiore.
Sul libro da scegliere – Innanzitutto scegliete la Bibbia. Se potete, leggete pure tutti i libri di meditazione che volete, ma ciò non è indispensabile; indispensabile invece è leggere e meditare la Sacra Scrittura. Basta con un cattolicesimo senza Bibbia! Basta con una predicazione senza midollo, perché non ancorata alla Scrittura. Basta con una formazione religiosa non scaturita dal Vangelo.
La Bibbia è la lettera che Dio stesso scrisse agli uomini nei millenni della loro storia. È il sospiro verso il Cristo (Vecchio Testamento) e il racconto della sua venuta tra noi (Nuovo Testamento).
Quando bruciò il tempio di Gerusalemme, gli Ebrei, che ben se ne intendevano di tesori, abbandonarono alle fiamme tutto, ma salvarono la Bibbia. S. Paolo conosceva la Bibbia a memoria; e S. Agostino disse: “Ignoranza della Scrittura è ignoranza di Cristo”.
Il Verbo fatto parola è la Bibbia, il Verbo fatto carne è l’Eucaristia. Non dubito di metterli entrambi sull’altare e di inginocchiarmi dinanzi.
C’è un risveglio biblico, grazie a Dio; ma siamo ancora molto indietro.
* * *
Dicevo dianzi che la preghiera è come per l’amore: le parole abbondano al principio, le discussioni sono dei primi tempi. Poi si fa silenzio e ci si intende a monosillabi. Nelle difficoltà è sufficiente un gesto, uno sguardo, un nulla: basta amarsi.
Viene quindi il tempo in cui la parola è di troppo e la meditazione è pesante, quasi impossibile.
È il tempo della preghiera di semplicità, tempo in cui l’anima si intrattiene con Dio con uno sguardo semplice, amoroso, anche se sovente accompagnato da aridità e sofferenza.
In questo periodo fiorisce la cosiddetta preghiera litanica: cioè ripetizione all’infinito di identiche espressioni povere di parole ma ricche, straricche di contenuto.
Ave Maria… Ave Maria… Gesù ti amo… Signore abbi pietà di me…
Ed è strano come in questa preghiera litanica, monotona, semplice, l’anima si trovi a suo agio, quasi si cullasse nelle braccia del suo Dio.
È il tempo del Rosario vissuto e amato come una delle più alte e ispirate preghiere.
Sovente, nella mia vita di europeo, ho avuto modo di assistere o prendere parte a discussioni animate sul pro e contro del Rosario. Ma, alla fine, non ero mai pienamente soddisfatto. Non ero in condizione adatta per comprendere a fondo questa maniera di pregare.
“È una preghiera meditata”, diceva qualcuno. Bene! Allora han ragione i giovani di lamentarsi delle distrazioni che dà alla meditazione del mistero questa ripetizione inutile di dieci Ave Maria. Annunziate il mistero e lasciatemi pensare.
“No; è una preghiera di lode”, dicevano altri; e bisogna pensare a ciò che si dice, parola per parola.
Ma è impossibile! Chi è capace di dire 50 Ave Maria, distratto da cinque rappresentazioni di misteri, senza perdere il filo?
Io debbo confessare che nella mia vita, pur facendo uno sforzo qualche volta, non sono mai riuscito a dire un solo Rosario senza distrarmi. E allora?
E allora fu nel deserto che compresi che coloro che discutono – come io discutevo in tal maniera – sul Rosario, non hanno ancora capito l’anima di questa preghiera.
Il Rosario appartiene a quel tipo di preghiera che precede di poco o che accompagna la preghiera contemplativa dello Spirito. Meditate o non meditate, distraetevi o meno, se amate il Rosario a fondo, e non potete trascorrere la giornata senza recitarlo, significa che siete uomini di preghiera.
Il Rosario è come l’eco di unónda che percuote la riva, la riva di Dio: “Ave Maria… Ave Maria… Ave Maria…”.
È come la mano della Madre sulla votra culla di bambino; è come il segno di un abbandono di ogni difficile ragionamento umano sulla preghiera per l’accettazione definitiva della nostra piccolezza e della nostra povertà.
Il Rosario è un punto di arrivo, non un punto di partenza. Per Bernardetta il punto di arrivo giunse molto presto, perché predestinata a vedere su questa terra la Madonna; ma normalmente è una preghiera della maturità spirituale. Se un giovane non ama dire il Rosario, se dice di annoiarsi, non insistere. Per lui è meglio la lettura di un testo scritturale o una preghiera più intellettuale. Ma se incontrate un bimbo in una campagna deserta, o un vecchio sereno, o una donna semplice che vi dice di amare il Rosario, senza capirne il perché, rallegratevi e gioite, perché in quei cuori c’è lo Spirito Santo che prega. Il Rosario è una preghiera incomprensibile per l’uomo del “buon senso”, come è cosa incomprensibile ripetere a un Dio, che non si vede, mille volte al giorno: “Ti amo”; ma è una preghiera comprensibilissima per i puri di cuore, per chi è stabilito “nel Regno”; per chi vive le Beatitudini.
Gli orientali, anime altamente contemplative, hanno sviluppato una preghiera litanica simile al nostro Rosario e lo chiamano la “preghiera di Gesù”.
Si tratta di ripetere, ripetere lentamente e con l’anima disposta alla pace il famoso “Kirie eleison”.
Signore, abbi pietà di me:
sono un uomo peccatore;
Cristo, abbi pietà di me:
sono un uomo peccatore.
E giungono in questa preghiera litanica ad una ginnastica spirituale che piace alla loro mentalità, cadenzandola con il respiro e addirittura col battito del cuore.
Grande impresione mi ha fatto a questo proposito la lettura di un volumetto pubblicato in Francia: Le pèlerin russe, accompagnato più tardi da un altro di un monaco ortodosso della Abbazia di Chevetogne: La preghiera di Gesù.
* * *
Mentre la preghiera si fa scarsa di parole e ricca di contenuto, la meditazione si fa pesante e vuota di gusto.
Ciò che prima era motivo di piacere intellettuale ora è causa di aridità e sofferenza.
Si ha l’impressione che la vita interiore abbia subito un arresto; qualche volta si pensa che, invece di procedere, si torni indietro. Il cielo ha perduto i suoi colori vivi, il grigio domina l’atmosfera dell’anima. S’incomincia a capire ciò che significa “andar avanti nella fede nuda”. Fortunoto colui che in tal momento della sua evoluzione spirituale ha una buona guida e più ancora ha l’umiltà di farsi condurre.
Non è facile; perché la presunzione di saper fare da soli è cosa ben solida nella nostra anima, e solo i buoni e ripetuti capitomboli la intaccano a misura.
Da che cosa dipende questa aridità nel meditare, questa repulsione a fissare il nostro pensiero sulle cose spirituali prese l’una dopo l’altra?
Evidentemente può dipendere da qualche nostra colpa, può dipendere da qualche attacco disordinato del nostro cuore, dalla mancanza di vigilanza, dalle spine in cui abbiamo lasciato soffocare il buon grano.
Non sempre la difficoltà a meditare è il segno di un avanzare dell’anima verso Dio, di un passaggio ad una preghiera più elevata.
Ma può – grazie a Dio – esserne il segno. Come distinguere?
Sempre il grande S. Giovanni della Croce ci dice come.
Ci sono tre segni che indicano il passaggio dalla preghiera discorsiva alla preghiera contemplativa.
1. – L’attività dell’immaginazione si fa senza gusto; anzi, diviene impossibile.
2. – L’immaginazione o i sensi non hanno più nessuna inclinazione per le cose particolari. Nessuna consolazione nelle cose create, n’r gusto, né sapore per qualsiasi cosa.
3. – L’anima prende piacere a restare sola con attenzione amorosa verso Dio, in pace interiore, quiete e riposo, senza atti né esercizi di facoltà.
Ecco, questa terza condizione è buona. E se c’è nell’anima, giustifica le altre due. Se cioè ho difficoltà a meditare le cose di Dio, se non riesco più a fissarmi su questo o su quel mistero della vita di Gesù, su questa o su quella verità, ma… ho sete di restare solo e in silenzio ai piedi di Dio, immobile, senza pensiero, ma in un atto d’amore, significa… significa una grande cosa; e ve ne voglio parlare pacatamente a parte, perché è uno dei più bei segreti della vita spirituale.
La preghiera contemplativa
Ed eccoci al punto giusto sulla preghiera, alla rivelazione più straordinaria che immaginar si possa, al segreto più profondo del cuore di Dio, alla vera dimensione del nostro “essere cristiani”.
Gesù, nella notte in cui fu tradito, disse: “Se mi amate osservate i miei comandamenti, ed Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga sempre con voi, lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede né lo conosce; ma voi lo conoscete, perché dimorerà in voi” (Gv 14, 15ss).
Poi aggiunse: “Chi ha i miai comandamenti e li osserva mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio ed io l’amerò e mi manifesterò a lui” (Gv 14, 21).
E per terminare: “Se uno mi ama, osserverà la mia parola; il Padre mio lo amerà e verremo a lui, e faremo dimora presso di lui” (Gv 14, 23).
Ci sono tre offerte da parte di Dio all’uomo: il suo Spirito, la sua Presenza, la sua Manifestazione. E, per queste tre offerte, una sola condizione: “Se uno mi ama”.
L’anima dell’uomo che accetta di amare Dio diviene un “paradiso in terra”, con la presenza reale della Trinità in sé, con l’attività folgorante dello Spirito e con la volontà suprema da parte di Dio “di manifestarsi, cioè di farsi conoscere all’uomo”.
Queste tre realtà, meritate dal sangue di Cristo, e realizzate in noi dopo la Pentecoste, investono la nostra anima di una tale grandezza, da superare qualsiasi possibile sogno umano.
Naturalmente, e in primo luogo, investono la nostra preghiera come il naturale rapporto tra la creatura e il Creatore, e danno ad essa qualcosa d’infinito; meglio, di divino.
* * *
Parliamo innanzi tutto di questa “presenza”:
Verremo a lui e faremo dimora presso di lui.
È La Trinità che diventa Ospite dell’anima; è la Terra che diventa Cielo.
Perché cercare ancora Iddio al di là delle stelle, quando Lui è così vicino, anzi, dentro di noi?
Il Cielo, questo luogo “celato”, non è più una lontananza astronomica, fisica di Lui, nell’universo, ma è una vicinanza amante, intima e così a portata di mano, che ogni luogo diventa buono per parlare con Lui, per stare con Lui, per adorare Lui.
E lo Spirito Santo in noi?
Ecco l’artefice forte e preciso della nostra unione con Dio. È Lui che ci incorpora a Cristo Gesù, Lui che ci insegna che cosa dobbiamo dire al Padre, Lui che ci reca uno Spirito “nuovo”, dacché il nostro “vecchio”s’è mostrato incapace e cattivo, Lui che con “gemiti inenarrabili”prega l’Altissimo e dà valore eterno al nostro esile sforzo di bimbi per sollevarci all’altezza di Dio.
Che dire ancora a me stesso: “Chi m’insegnerà a pregare?”, quando ho un simile Maestro al centro del mio essere? Che dubitare della potenza della mia preghiera, quando – pur sì povera e balbuziente – è sostenuta nel suo volo dallo stesso Spirito creatore del cosmo?
No; non cercherò più me stesso nella preghiera, non mi ripiegherò sul mio povero io, dacché nella mia fede ho scoperto che lo Spirito di Dio s’è diffuso nel mio cuore.
Ma non basta. La promessa di Gesù parla di una presenza sua, di una attività del suo Spirito, e parla ancora di una “rivelazione”.
“Io mi rivelerò a voi“.
Rivelarsi l’uno all’altro è il compito dell’amore, che non deve mai finire, nemmeno nell’amore umano, perché sempre deve restare qualche cosa ancora di “misterioso” da scoprire e da conoscere nella persona amata.
Immaginiamo con Dio dove “tutto” è da scoprire! Ma qui, a proposito di Dio, va detto qualcosa di ben preciso.
Dio è inconoscibile all’uomo. Tutto ciò che sappiamo di Lui, non è Lui: è un’immagine, un simbolo, un richiamo; ma non è Dio. Solo Dio conosce se stesso; e la sua conoscenza rimane per noi “mistero”.
Ma Dio ha deciso nel suo amore di farsi conoscere dall’uomo, di rivelarsi a lui; e ciò avviene in modo soprannaturale, con un linguaggio intraducibile sulla terra. Colui che è sotto l’azione di questa “rivelazione” non può dire nulla: la vive sperimentalmente, ma non la può ripetere.
Ciò è decisivo a sapersi per chi vuole imparare a pregare.
Troppo tempo io ho perduto, perché tardi ho conosciuto questa verità. Eppure era chiara nel Vangelo.
Io pensavo che nel pregare tutto dipendesse da me, dal mio sforzo, dalla bontà dei libri che avevo tra le mani, dalla bellezza delle parole che sapevo introdurre nel mio colloquio con Dio.
Più grave ancora: pensavo che la conoscenza di Dio che andavo facendo attraverso lo studio e il ragionamento fosse la vera e l’unica e non mi ero ancora accorto che era solo un’immagine, un involucro, un avviamento alla vera, autentica, soprannaturale, sostanzionsa, eterna rivelazione di Dio.
Dio è l’Inconoscibile, e solo Lui può rivelarsi a me attraverso vie tutte sue, parole mai ripetute, concetti al di là di ogni concetto.
Nella vera preghiera, quindi, mi è richiesta più passività che attività; più silenzio che parole, più adorazione che studio, più disponibilità che movimento, più fede che ragione.
Devo capire “a fondo”mche l’autentica preghiera è frutto di un dono del Cielo alla Terra, del Padre a suo Figlio, dello Sposo alla Sposa, di Colui che ha a collui che non ha, del Tutto al nulla.
E più questo Tutto s’avvicina al nulla, più l’inconoscenza si fa senza confini.
È classico il discorso che voi potete fare all’uomo che scende dalla montagna, dopo aver parlato lungamente con Dio.
“Parlaci di Lui”!
E lui ci ripeterà con Angela da Foligno, una delle grandi mistiche italiane:
“Davanti a Dio l’anima è avvolta nelle sue tenebre, e in esse, si fa di Lui una conoscenza più grande di quella ch’io mai avessi immaginato potersi fare; e con tale splendore, tale certezza e con sì profondo abisso, che non c’è cuore che possa poi in alcun modo comprendere né pensare una tal cosa.
“L’anima non può dire assolutamente nulla, perché non c’è parola con cui essa la dica e la esprima. Anzi; non v’è pensiero né intelligenza che possa estendersi a quella cosa, tanto essa sopravanza tutto; come Dio non può essere spiegato per cosa che sia.
“Quando tornai in me, conobbi certissimamente che coloro i quali più sentono Dio meno ne possono parlare. Proprio perché sentono alcunché di quel bene infinito e indicibile, meno ne possono parlare.
“Piaccia al Cielo che quando vai a predicare, tu comprenda. Poiché allora tu non sapresti dire nulla affatto di Dio. E allora qualunque uomo si tacerebbe. Ed io allora verrei vicino a te a dirti: – Fratello, parlami ora un poco di Dio. – E tu non sapresti dire nulla, né pensare nulla di Dio, tanto la bontà infinita ti sorpasserebbe.
“Eppure l’anima non perde conoscenza, né il corpo la perde in alcuno dei suoi sensi. Anzi, la conoscenza è intera in noi.
“Ma tu diresti al popolo con forza: – Andate con la benedizione di Dio, perché io non posso dire nulla!
“Ed io comprendo che tutte le cose che son dette sulle Scritture e da tutti gli uomini dal principio del mondo fino ad oggi, mi sembrano non poter quasi nulle esprimere della midolla, neppure ciò che è un grano di polvere in confronto all’universo” (Le livre de la bienheureuse Angéle de Foligno, Paris p. 173).
* * *
Così per Angela da Foligno; così per tutti. Se sente che la conoscenza di Dio aumenta in noi man mano aumenta per Lui il nostro amore; e di questa conoscenza non sappiamo dir nulla. Sappiamo che è una conoscenza sapida, misteriosa, personale, oscura di Lui; ma non sapremmo aggiungere sillaba.
“Io mi rivelerò a voi“.
Questa “rivelazione” che Dio fa di se stesso all’uomo è l’anima, il frutto, il respiro della preghiera così detta “contemplativa”; ed è un’autentica anticipazione della vita eterna. La definizione l’ha data Gesù stesso: “Questa è la vita eterna: che conoscano Te, Padre, e Colui che hai mandato, il Cristo” (Gv 17, 3).
Signore, il mio cuore non s’è inorgoglito
né i miei occhi fatti alteri.
Non ho cercato un cammino di grandezza
o prodigi inopportuni.
No, ho tenuto la mia anima in pace e in silenzio
come un bambino contro sua madre.
La mia anima è in me come un bimbo slattato. (Salmo 130).
Questo è il salmo della preghiera contemplativa. L’uomo nel cammino verso la radice del suo essere, verso il suo fine, verso il suo Creatore, dopo aver superato i primi gradi della preghiera, dopo averla purificata nella sofferenza e nell’aridità dal gusto umano e dall’egocentrismo, si trova come sulla soglia dell’infinito; là, dove le sue forze a nulla possono, dove la meditazione stessa diventa impossibile e la parola, una volta così fluente, non sa se non ripetere qualche monosillabo di amore o di lamento.
Nessuna immagine riassuntiva di tutto ciò è così esatta come l’immagine del bimbo slattato sul grembo della madre. Ed è ancora Gesù che ci dice: “Se non vi farete piccoli, non entrerete nel Regno dei Cieli” (Mt 18, 3). Ma l’anima ormai si è fatta piccola e ha capito che deve tutto ricevere e che l’unico suo potere è quello di amare.
No; c’è anche l’altro potere: quello di conoscere. Ma… a che cosa gli serve in tali momenti?
Dice l’anonimo autore del libro sulla preghiera La nube dell’inconoscenza: “Ogni creatura intelligente, angelo o uomo, ha in se stesso due facoltà principali: l’una chiamata la facoltà di conoscere, l’altra chiamata la facoltà di amare.
“Di entrambe Dio è il Creatore: ma se Egli resta sempre incomprensibile per la prima, è ivece attingibile alla seconda, secondo il grado differente per ciascuno.
“Talché soltanto l’anima che ama può, per virtù del suo amore, attingere Colui che pienamente basta a saziare tutte le anime e tutti gli Angeli della creazione”.
Questa è l’infinita meraviglia, questo il miracolo dell’amore: L’esercizio non ne sarà mai interrotto, perché Dio lo rinnovella senza posa.
E perché? Perché Egli può essere amato, non pensato: l’amore può coglierlo e tenerlo; il pensiero no…, mai!
Parrebbe strano, a prima vista; ma nulla dà il senso dell’universalità di Dio, della giustizia di Dio, più di questa verità. Se Dio fosse raggiungibile con l’intelligenza, quanto sarebbe ingiusto!
Avrebbe facilitato il compito ai saggi, ai grandi di questo mondo; e si sarebbe reso incomprensibile ai piccoli, ai poveri, agli ignoranti. Invece, no: ha trovato Lui stesso la regola per essere uguale con tutti: la rivelazione sua avviene nell’amore, proprio in quella facoltà in cui siamo tutti uguali.
Ama la regina come ama la contadina, ama l’uomo sapiente come ama l’ignorante. “Ti ringrazio, Padre, che hai nascoste queste cose ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli” (Mt 11, 25).
“Rimanete nel mio amore”.
Ma che cosa divengono i concetti? Essi non sono soppressi; ciò sarebbe contrario alla natura stessa della nostra intelligenza. Dunque, essi sussistono sempre. Ma tutti i concetti distinti tacciono, dormono come gli apostoli sul monte.
Ecco ciò che si chiama contemplazione infusa o conoscenza mistica.
Essa si nutre di silenzio.
Essa non ricorre all’uso attuale dei concetti come mezzo proprio di conoscenza.
Essa diventa negativa in un senso nuovo e assoluto.
Dice la Hadewijk, la Beghina: “La verità una e nuda abolisce ogni ragione, mi tiene in questa vacuità, mi adatta alla semplice vita dell’Eterno. Qui cessa ogni discorso. Chi non ha mai compreso la Parola di Dio vorrebbe invano spiegare ciò ch’io ho trovato senza mezzo, senza velo, più su d’ogni ragione”.
S’io qualcosa desidero, lo ignoro, perché son prigioniero stabilmente dell’abissale ignoranza. Chi crede poter dire ciò che sta nel profondo, tradisce l’inesperienza sua.
Ma Dio, quale avventura non intendere più, non più vedere… Se altra volta avevamo “qualche cosa”, l’amore adesso ci ha ridotti al nulla. (Poémes spirituels, “Nova et Vetera”1938, n. 4, pp. 362, 367).
* * *
Sì; l’amore ci ha ridotti al nulla. Ci ha tolto ogni presunzione di sapere, di essere; ci ha ridotti alla vera infanzia spirituale.
Ho tenuto la mia anima
in pace e in silenzio
come un bambino
contro sua madre.
Ecco lo stato più alto della preghiera: essere bimbi nelle braccia di Dio: tacere, amare, godere.
E se, per questa benedetta voglia di dir qualcosa, di far qualcosa, proprio ti è necessario aprir la bocca, allora fa’ così: scegli una parola, una piccola frase che esprima bene il tuo amore per Lui; e poi ripetila, ripetila con pace, senza cercare di formulare pensieri, senza muoverti, ridotto ad un piccolo punto amante dinanzi a Dio Amore.
E, trasformata questa parola o questa frase in un dardo d’acciaio, simbolo del tuo amore, batti, batti contro la spessa nube dell’inconoscenza di Dio.
Non distrarti, qualunque cosa avvenga. Caccia via anche i buoni pensieri; non servono a nulla.
Il grado superiore della contemplazione, qual si può ottenere in questa vita, risiede tutto interoin questa oscurità e nube d’inconoscenza e con uno slancio di amore e uno sguardo cieco si portano sull’essere nudo di Dio, in Lui stesso e di Dio solo.
Un cieco slancio d’amore che si porta su Dio, considerato in Lui stesso, e che preme segretamente sulla nube dell’inconoscenza è più profittevole alla tua anima, più nobile di qualsiasi altro esercizio.
Esso veramente piace a Dio, ai Santi e agli Angeli del Cielo; ed è veramente utile a tutti coloro che tu ami d’un’amicizia spirituale o naturale, vivi o morti.(Le nuage de l’inconnaissance, p. 38 ss).
Questo, fratello, è il mio augurio, sintesi di tutti i doni che il deserto mi ha fatto.
La contemplazione sulle strade
A questo punto mi sembra avvertire in te, amico, una domanda, accompagnata da un sorriso leggermente triste:
“E allora: bisogna andare tutti nel deserto? Quale valore ha l’azione, l’impegno tra gli uomini, l’immergersi come lievito in questa città terrena? Com’è possibile ciò? Il deserto è lontano; mai potrò…”.
Sapevo che tu pensavi a ciò; ed è assolutamente necessario spiegarci con tutta chiarezza; perché ne va di mezzo addirittura uno scandalo per la tua anima, di cui posso involontariamente essere la causa.
Charles de Foucauld un giorno ebbe a dire: “Se la vita contemplativa fosse solo possibile dietro le mura di un convento o nel silenzio del deserto, dovremmo, per essere giusti, dare un piccolo convento ad ogni madre di famiglia e il lusso di un po’ di deserto ad un povero manovale che è obbligato a vivere nel chiasso di una città per guadagnarsi duramente il pane”.
Non è così?
Fu la visione stessa della realtà in cui vive parte dell’umanità povera a determinare in lui la crisi centrale della sua vita, quella crisi che lo doveva portare così lontano dalla sua prima concezione di vita religiosa.
Charles de Foucauld, come sapete, era trappista e aveva scelto la trappa più povera che esistesse, quella di Akbes in Siria.
Un giorno il suo Superiore lo mandò a vegliare un morto, vicino al convento. Era un arabo cristiano deceduto in una povera casa. Quando fratel Carlo si trovò nel tugurio del morto e vide attorno al cadavere la vera povertà fatta di figli affamati e di una vedova indifesa, debole e senza alcuna sicurezza sul pane del giorno dopo, entrò in quella crisi spirituale che lo avrebbe fatto uscire dalla Trappa, cercando un quadro di vita religiosa così diverso dal primo.
“Noi che abbiamo scelto l’imitazione di Gesù e di Gesù crocifisso, siamo ben lontani dalle prove, dalle pene, dall’insicurezza e dalla povertà a cui sono sottoposte queste popolazioni.
“Non voglio più un convento troppo stabile; voglio un convento piccolo come la casetta di un povero operaio che non è sicuro se domani troverà lavoro e pane e che partecipa con tutto il suo essere alla sofferenza del mondo”.
“Oh, Gesù, un convento come la tua casa di Nazaret per annientarmi, scomparire come hai fatto Tu quando sei venuto fra noi” (Charles de Foucauld, Écrits spirituels).
E uscito dalla Trappa, costruirà la sua prima fraternità a Beni Abbes nel Sahara e poi a Tamanrasset, dove morirà trucidato dai Tuareg.
La “fraternità” doveva somigliare alla casa di Nazaret, quindi ad una delle molte case che tu incontri lungo le strade del mondo.
Ma allora aveva rinunciato alla contemplazione? allora aveva affievolito il suo ardente spirito di preghiera? No; aveva fatto un passo avanti: aveva accettato di vivere la vita contemplativa lungo le strade, in un quadro di vita somigliante a quello di tutti gli uomini.
Ciò è ben più duro!
E Dio voglia che l’umanità faccia questo passo.
Per questo Charles de Foucauld è all’alba di un periodo nuovo, d’un periodo in cui molti si sforzeranno di fare la sintesi tra contemplazione e azione, attuando in una concretezza vitale il primo comandamento del Signore: “Ama Dio sopra ogni cosa e il prossimo come te stesso”.
“Contemplazione sulle strade”: ecco l’impegno di domani per i piccoli fratelli, per tutti i poveri.
* * *
E incominciamo ad analizzare questo elemento “deserto”, che dev’essere presente, specie oggi, nell’attuazione di un sì impegnativo programma.
Quando si parla di deserto all’anima, quando si dice che il deserto deve essere presente nella tua vita, non devi intendere solo la possibilità di andare nel Sahara o nel deserto di Giudea, o dell’Alta Valle del Nilo.
È certo che non tutti possono procurarsi questo lusso o attuare praticamente questo distacco dal vivere comune. Il Signore mi ha condotto nel vero deserto per la durezza della mia pelle. Per me, fu necessario così; e tanta sabbia non mi è bastata a raschiare la sporcizia della mia anima, come capitò alla marmitta di Ezechiele.
Ma non per tutti c’è la stessa via. E se tu non potrai andare nel deserto, devi però “fare il deserto”nella tua vita.
Fare un po’ di deserto, lasciare di tanto in tanto gli uomini, cercare la solitudine per rifare nel silenzio e nella preghiera prolungata il tessuto della tua anima, questo è indispensabile, e questo è il significato del “deserto” nella tua vita spirituale.
Un’ora al giorno, un giorno al mese, otto giorni all’anno, per un periodo più lungo, se necessario, devi abbandonare tutto e tutti e ritirarti solo con Dio. Se non cerchi questo, se non ami questo, non illuderti; non arriverai alla preghiera contemplativa; perché essere colpevole di non volersi – potendo – isolare per gustare l’intimità con Dio, è un segno che manca l’elemento primo del rapporto con l’Onnipotente: l’amore. E senza amore non c’è rivelazione possibile.
Ma il deserto non è il luogo definitivo; è una tappa. Perché, come ti dissi, la nostra vocazione è la contemplazione sulle strade. Lungo la via dobbiamo tornare dopo la pausa del deserto.
A me, questo, costa assai. È così forte il desiderio di continuare a vivere qui per sempre, nel Sahara, che sento di già la sofferenza in previsione di un ordine dei Superiori, che certamente verrà: “Fratel Carlo, parti per Marsiglia, parti per il Marocco, parti per il Venezuela, parti per Detroit…”.
Devi tornare tra gli uomini, devi mescolarti a loro, devi vivere la tua intimità con Dio nel chiasso della loro città. Sarà più difficile; ma devi farlo. E non ti mancherà, per questo, la Grazia di Dio.
Ogni mattina prenderai la strada, dopo la S. Messa e la Meditazione, e andrai a lavorare in una bottega, in un cantiere; e quando tornerai la sera, stanco, come tutti gli uomini poveri costretti a guadagnarsi il pane, entrerai nella Cappellina della fraternità e resterai lungamente in adorazione; portando con te, alla preghiera, tutto quel mondo di sofferenza, di oscurità e sovente di peccato in mezzo al quale hai vissuto per otto ore, pagando la tua razione di pena e di fatica quotidiana.
Contemplazione sulle strade: è una bella frase, ma costa assai. Certo, sarebbe più facile e più dolce restare qui, nel deserto; ma sembra che Dio non voglia.
La voce stessa della Chiesa si fa sempre più sentire per indicare ai cristiani la realtà del Corpo Mistico e l’apostolato in esso, per richiamare alla carità vissuta, per invitare tutti ad un’azione, che partendo dalla contemplazione, ritorna ad essa sul versante della testimonianza e della presenza tra gli uomini.
I muri dei conventi si fan sempre più sottili e più bassi; si moltiplicano coloro che vivono la verginità nel mondo; i laici stessi prendono coscienza della loro missione e cercano la loro spiritualità.
È davvero l’alba di un mondo nuovo, al quale non parrebbe retorico dare come consegna “la contemplazione sulle strade” e gli esempi per attuarla.
* * *
Ma non vorrei chiudere questa lettera senza dire due parole su un altro elemento basilare per la vita contemplativa, soprattutto se vissuta nel mondo: la povertà!
È troppo importante, specie oggi.
Per povertà non s’intende avere o non aver denari, avere o non aver pidocchi addosso. La povertà non è cosa materiale: è una beatitudine: “Beati i poveri in spirito”. È un modo di essere, di pensare, di amare; è un dono dello Spirito.
Povertà è distacco, è libertà, è soprattutto verità.
Entrate nelle case borghesi, anche se cristiane, e vi convincerete della mancanza di questa beatitudine della povertà. I mobili, gli oggetti, l’insieme è spaventosamente eguale in tutte le case; esso è determinato dalla moda, dal lusso; non dal bisogno, dalla verità. C’era un vecchio tavolo robusto, comodo, ricco di ricordi. No; bisogna metterlo in cantina e sostituirlo inutilmente, con un altro che ha solo delle pretensioni, che sarà vuoto di senso, e che avrà solo il merito di far dire all’amico: “È di moda”.
Questa mancanza di libertà, meglio, questa schiavitù della moda è uno dei diavoli che tiene avvinghiato solidamente un gran numero di cristiani.
Al suo altare, quanti denari si sacrificano! E senza tener conto che si potrebbe fare tanto bene.
L’essere povero in spirito significa innanzitutto essere liberi da ciò che si chiama moda, significa libertà.
Non compero una coperta perché è di moda; compero una coperta perché ne ho bisogno. Senza coperta, il mio bambino trema nel letto.
Il pane, la coperta, il tavolo, il fuoco sono cose necessarie in sé. Il servirsi di esse è realizzare il piano di Dio. “Tutto il resto vien dal maligno”, si potrebbe dire parafrasando un’espressione di Gesù a proposito della verità. E questo “resto” è la moda, la consuetudine, il lusso, l’impinguamento, la ricchezza, la schiavitù, il mondo.
Non ciò che è vero si cerca, ma ciò che piace agli altri. C’è bisogno di questa maschera: senza di essa non si è più capaci di vivere.
Ma le cose si fanno gravi quando entrano di mezzo gli “stili” e le spese diventano astronomiche. “Questo è un Luigi XIV…, questo è Barocco puro…, questo ecc., ecc.”.
E diventano più gravi ancora quando “gli stili” entrano nelle case degli uomini di Chiesa chiamati per vocazione ad evangelizzare i poveri.
C’è sì una giustificante, ed è che in questi ultimi secoli, dalla Rinascenza al Barocco, il trionfalismo della Chiesa e il bisogno sentito dalle folle d’onorare degnamente Dio e le cose di Dio si sono espressi in un lusso e in una pompa davvero straordinarie.
E i poveri non ne avevano scandalo, anzi piaceva loro tutto quel luccichio e quella sontuosità.
Ricordo mia madre, che pur era povera, parlare con orgoglio di cristiana e con soddisfazione della bellezza della casa del Vescovo e della lunghezza delle macchine dei prelati che parcheggiavano sotto la finestra.
Ma le cose son cambiate e non stanno più così e se sapesse o meglio sentisse i moccoli che splodono dietro la sua elegante macchina americana quel Monsignore, mio vecchio amico, farebbe in fretta a raccorciarla o combiarla con una utilitaria di tinta bigio-sporco o, meglio ancora, andrebbe in bicicletta.
Si parla della “Chiesa dei poveri”e non credo sia una frase retorica.
Ma bisogna intendersi sul significato delle parole.
Quando si parla della povertà della Chiesa non si deve identificarla con la “beatitudine della povertà”. Questa, la beatitudine, è una virtù interiore e non posso e non debbo giudicarla nel mio fratello.
Anche colui che è ricco di beni, anche il Pontefice coperto di un piviale d’oro possono e debbono avere la beatitudine della povertà: nel cuore, possono e debbono essere “poveri in spirito”. Nessuno può giudicarli su quella frontiera, specie nella Chiesa.
Ma quando si parla della povertà nella Chiesa si intende la povertà sociale, il volto povero di essa, l’attenzione ai poveri, l’aiuto ai poveri, l’evangelizzazione dei poveri.
E la cosa è ben diversa.
Quando si parla di povertà nella Chiesa si intende il rapporto con gli altri ed è questo che scandalizza il povero, come scandalizzava S. Paolo il modo di fare dei cristiani di Corinto.
“Radunandovi dunque assieme non è che mangiate la Cena del Signore, poiché ciascuno s’affretta a prendere e consumare la propria cena e c’è chi patisce la fame e chi invece s’ubriaca. O non avete la vostra casa per mangiare e bere? Avete forse in dispregio la Chiesa di Dio, e volete fare arrossire quelli che non possiedono nulla?” (1Cor 11, 20).
E non facciamo noi forse arrossire il povero quando gli passiamo vicino con la nostra potenza e ricchezza mentre lui non ha i soldi per pagare l’affitto? Come potremo evangelizzarlo stando dall’alto della nostra sicurezza economica mentre lui non sa se domani avrà lavoro e pane?
* * *
Ma la povertà come beatitudine non è solo verità, libertà e giustizia; è e resta amore, e i suoi confini divengono infiniti come i confini delle perfezioni divine.
Povertà è amore verso Gesù povero, cioè verso l’accettazione volontaria d’un limite. Gesù poteva essere ricco; non aveva bisogno di un limite ai sui desideri. No; volle essere povero per partecipare alla limitazione universale dei poveri, per sopportare la mancanza di qualcosa, per soffrire nella sua carne la dura realtà che pesa sull’uomo che cerca il suo pane, e nel suo spirito l’instabilità perenne di chi non possiede.
Questa povertà autentica, sopportata per amore, è la vera beatitudine di cui parla il Vangelo.
Troppo facile parlare di povertà spirituale, riempirsi la bocca di parole pie e non mancare di nulla e avere casa sicura, disponsa ben fornita e conti in banca.
No; non facciamoci illusioni e non cambiamo i termini delle cose più preziose dette da Gesù.
Povertà è povertà, e resta povertà; e non è sufficiente fare il voto di povertà per essere poveri in spirito.
C’è uno scandalo oggi nelle anime dei poveri; e per toglierlo sarebbe meglio parlare meno del solito tema sulla castità e mettere maggiormente l’accento su questa beatitudine che minaccia davvero di essere spazzata via dalla realtà del cosiddetto “vivere da cristiani”.
Se è vero, com’è vero, che la perfezione della legge sta nella carità, tale perfezione deve investire in pieno i miei averi, le mie ricchezze; altrimenti non conoscerò la beatitudine.
Se amo, se veramente amo, come potrò sopportare che un terzo dell’umanità sia minacciata di morire di fame, mentre io conservo tutta la mia sicurezza e la mia stabilità economica? Facendo così, sarò un buon cristiano, ma non sarò certamente un santo; ed oggi c’è inflazione di buoni cristiani, mentre il mondo ha bisogno di santi.
Saper accettare l’instabilità, mettersi nelle condizioni di tanto in tanto di dover dire il “dacci oggi il nostro pane quotidiano” con un po’ di ansia, perché la dispensa è vuota; avere il coraggio, per amore di Dio e del prossimo, di dare senza misura, e, soprattutto, mantenere aperta sul povero cielo dell’anima nostra la grande finestra della fede viva nella Provvidenza di un Dio Onnipotente: questo occorre.
* * *
So che ciò che ho detto sulla povertà è grave e so che anche nel mondo non ho saputo attuarla.
Chi ha cambiato il vecchio tavolo di casa sua per un altro insignificante sono io; chi ha vissuto per anni dietro la maschera del “piacere agli altri” sono io; chi ha speso denari e non solo suoi per le cose “non vere” sono io.
Eppure, nonostante questo, non posso tacere; e ai vecchi amici debbo dirlo: badate alla tentazione delle ricchezze. È molto più grave di quanto appaia oggi ai cristiani benpensanti e semina strage nelle anime, proprio perché si sottovaluta il pericolo o perché “a fin di bene” tutto diventa lecito.
La ricchezza è un veleno lento, che colpisce quasi insensibilmente, paralizzando l’anima nel momento esatto della sua maturità. Cono le spine che crescono col grano e che lo soffocano proprio quando comincia a mettere la spiga. Quanti, uomini o donne, anime religiose che pur hanno superato il duro scoglio dell’impurità, si lasciano irretire nella maturità della vita da questo demone vestito bene e di gusti borghesi.
Ora che la solitudine e la preghiera mi hanno aiutato a vedere più chiaro, comprendo perché contemplazione e povertà sono inseparabili.
Non si può giungere alla intimità con Gesù a Betlemme, con Gesù esule, con Gesù operaio a Nazaret, con Gesù apostolo che non ha ove posare il capo, con Gesù crocifisso, senza aver operato in noi quel distacco dalle cose, da Lui così solennemente proclamato e vissuto.
Non si giungerà di colpo a questa dolcissima beatitudine della povertà. La vita non ci basterà a realizzarla in pieno; ma è necessario pensarci, riflettere, pregare.
Gesù, il Dio dell’impossibile, ci aiuterà; compirà, se necessario, il miracolo di far transitare il cammello della parabola attraverso la cruna stretta e arrugginita della nostra povera anima malata.
Purificazione dello spirito
C’è uno slogan che ha fatto il giro del mondo e che dice: “Mettendo insieme i denari che si spendono per le cure dimagranti o per tentare di guarire gli organi rovinati dal troppo mangiare nei due continenti benestanti dell’Europa e dell’America, si otterrebero largamente i mezzi per dare pane ai popoli miseri e denutriti d’Africa e d’Asia”.
Il che significa che la voracità è una ben chiara qualità dell’uomo, ivi compreso l’uomo spirituale, l’uomo colto, l’uomo raffinato e – troppo sovente – l’uomo religioso.
Gesù, a questo proposito, ci direbbe: “Non avete saputo fare con le cose piccole; chi vi confiderà le grandi?” (Lc 16, 10).
Se tale voracità abbiamo messo in atto alla tavola del corpo, immaginiamo come l’avremmo centuplicata alla tavola delle cose spirituali, se… se ci fosse il gusto a sentircene allettati! Avremmo dato addirittura l’assalto al Cielo, come fece Satana.
È inutile ripeterlo: siamo dei malati, degli squilibrati, dei sensuali, dei cattivi. E intendiamoci: tutti quanti.
Gesù, dando il giudizio su di noi, giudizio riassuntivo, autentico, scolastico, disse: “Voi che siete tutti cattivi” (Mt 7, 11).
E sulla croce completò il giudizio: “Padre, perdona loro perché non sanno che cosa fanno” (Lc 23, 34). Cattivi e pazzi!
Lo siamo nelle piccole cose e lo siamo nelle grandi. Lo siamo facendo indigestione e lasciando morir di fame il vicino e continuiamo ad esserlo nella preghiera e nelle cose spirituali.
Ma per fermarci, per bloccare il nostro assalto al Cielo, per impedire l’indigestione e l’impinguamento nelle cose dello spirito, Dio ha avuto una trovata radicale: la fede nuda, la speranza senza memoria, la carità senza sdolcinamenti.
L’uomo che dopo i primi passi nella vita spirituale si lancia nelle battaglie della preghiera e nell’unione con Dio, si stupisce dell’aridità del cammino.
Più avanza e più si fa buio attorno a lui; più cammina e più il tuttodiventa amaro o insipido. Deve addirittura, per avere un po’ di conforto, richiamarsi alle gioie antiche, a quelle dei primi passi, quelle che Dio gli donava per attirarlo a sé.
A volte è perfino tentato di gridare: “Ma Signore, se tu ci aiutassi un po’ di più, avresti più seguaci alla tua ricerca”.
Ma Dio non ascolta tale invocazione; anzi, al posto del gusto, aggiunge noia; e invece della luce mette le tenebre.
Ed è proprio là, a metà del nostro cammino, che non sappiamo se andare avanti o indietro; meglio… sentiamo di andare indietro.
Ma solo allora incomincia la vera battaglia e le cose si fanno serie. Sì; si fanno serie, innanzitutto perché si fanno vere. Incominciamo cioè a scoprire ciò che valiamo: nulla o poco più. Credevamo, sotto la spinta del sentimento, di essere generosi; e ci scopriamo egoisti. Pensavamo, sotto la falsa luce dell’estetismo religioso, di saper pregare; e ci accorgiamo che non sappiamo più dire “Padre”. Ci eravamo convinti di essere umili, servizievoli, ubbedienti; e constatiamo che l’orgoglio ha invaso tutto il nostro essere, fino alle radici più profonde. Preghiera, rapporti umani, attività, apostolato: tutto è inquinato.
È l’ora della resa dei conti; e questi sono molto magri.
Tolta qualche anima privilegiata – che ha capito fin dal principio dove stava il problema e, senza lasciarsi ingannnare né dagli uomini né da Satana, si è subito messa sul cammino aspro e vero dell’umiltà e dell’infanzia spirituale – la maggior parte degli uomini è chiamata a fare una dura e dolorosa esperienza.
Normalmente ciò capita sui quarant’anni: grande data liturgica della vita, data biblica, data del demonio meridiano, data della seconda giovinezza, data seria dell’uomo:
Per quarant’anni fui disgustato con questa generazione
e dissi: – Sempre costoro son traviati di cuore. (Sal 94, 10)
È la data in cui Dio ha deciso di mettere con le spalle al muro l’uomo che gli è sfuggitofino ad ora dietro la cortina fumogena del “mezzo sì e mezzo no”.
Coi rovesci, la noia, il buio; e più sovente ancora, e più profondamente ancora, la visione o l’esperienza del peccato. L’uomo scopre ciò che è: una povera cosa, un essere fragile, debole, un insieme di orgoglio e di meschinità, un incostante, un pigro, un illogico.
Non c’è limite a questa miseria nell’uomo; e Dio gliela lascia ingoiare tutta fino alla feccia.
E anche per coloro che in questa situazione non peccano perché aiutati dalla Grazia si apre tremenda davati agli occhi, la visione delle cose vere: Dio, l’uomo, il peccato.
L’anima avverte di camminare su un filo; e sotto il filo vede l’inferno meritato le cento volte e le cento volte richiuso dalla misericordia di Dio.
Non c’è peccato che non abbia commesso o che non senta intimemente di essere capace di commettere.
Ma non basta.
Nel profondo è riposta la colpa più decisiva, più vasta anche se nascosta, appena o forse mai erompente in singole opere concrete, in cui si spinge verso la superficie del mondo, ma che dal profondo, dagli strati interni del nostro essere – come dice Welte – imbeve con linfa venefica e danneggia strati molto estesi della nostra vita: colpa che consiste più in atteggiamenti generali che in singole azioni, ma che per lo più determina la vera qualità del cuore umano, meglio delle azioni; colpa che è nascosta, anzi camuffata, perché noi a mala pena e spesso solo dopo lungo tempo possiamo coglierla con lo sguardo, ma tuttavia abbastanza viva nella coscienza da poterci contaminare e che pesa assai più di tutte le cose che noi abitualmente confessiamo.
Io intendo gli atteggiamenti che avvolgono la nostra vita intera come un’atmosfera, e che sono presenti, per così dire, in ogni nostra azione e omissione; peccati di cui non possiamo sbarazzarci, cose nascoste e generali: pigrizia e viltà, falsità e vanità, delle quali neppure la nostra preghiera può essere interamente libera; che gravano profondamente su tutta la nostra esistenza e la danneggiano.
È finito il tempo dei giochetti, della commedia, dell’eloquenza, del “come se…”. Si è arrivati infine a conoscere la propria ignoranza sull’orlo dell’abisso che separa la creatura dal Creatore.
Là, non si vive se non di elemosina, della grazia sconosciuta, inafferrabile.
Tutti i mezzi si son dimostrati impotenti, tutte le vie troppo corte. La notte divina, impenetrabile, ci avvolge; la solitudine spaventosa, se pur necessaria e inevitabile, ci accompagna.
Ogni parola di consolazione ci appare menzogna: si ha l’impresione che Dio ci ha abbandonati.
In questo stato davvero doloroso, la preghiera diventa vera e forte, anche se arida come la sabbia.
L’anima parla al suo Dio con la sua povertà, col suo dolore; più ancora, con la sua impotenza e abiezione.
Le parole si fanno sempre più scarse, più nude. Si giunge al silenzio, che è un passo innanzi nella preghiera; perché è senza limiti, mentre ogni parola ha un limite.
E la golosità spirituale?
Oh, essa c’è sempre! Cova sotto la cenere; ma è meno violenta, più prudente, più dominata.
Dio ora interviene di nuovo con le consolazioni, dacché sarebbe impossibile vivere in quello stato di abbandono. È Lui che torna a sollecitare l’anima col tocco della sua dolcezza. E l’animaaccetta con gratitudine; ma è talmente resa paurosa dai colpi ricevuti, che non osa chiedere altro.
In fondo ha capito che deve lasciar fare, che deve abbandonarsi al suo Redentore, che da sola non può nulla, che Dio può tutto…
E se sarà ferma e immobile, come fasciata dalla fedeltà di Dio… oh! s’accorgerà presto che le cose son cambiate, e che la marcia, pur sì pesante ancora, è nella buona direzione.
È la direzione dell’amore; ed esso verrà come la luce viene dopo le tenebre, il meriggio dopo l’aurora.
Ciò che conta è lasciar fare a Dio.
Settarismo
Anche stasera è Abdaraman che m’accompagna all’eremitaggio per l’adorazione: duecento metri che percorriamo insieme, tenendoci per mano e conversando del più e del meno.
Ma sapete chi è Abdaraman? È un ragazzino mussulmano di forse otto anni. Dico “forse”, perché qui non esiste l’ufficio di stato civile, e nessuno prende nota della nascita di un bimbo; così pochi conoscono la loro età con precisione.
Abdaraman non va a scuola, pur essendovi una scuola al di là dell’Oued, frequentata dagli Europei e da qualche “mosabit”, figlio di commercianti del luogo. Non va a scuola, perché suo padre Aleck non lo lascia andare.
“Aleck – gli chiedo – perché non mandi i tuoi figli a scuola?”.
Aleck mi guarda profondamente e mi dice: “Fratel Carlo, non mando i miei figli a scuola, perché diventano cattivi. Guarda i ragazzi che vanno alla scuola: non pregano, non ubbidiscono più e cercano solo di vestir bene”.
Abdaraman è completamente nudo: sembra una bella statuetta d’un color grigio scuro, risultato d’infiniti incroci tra l’Africa nera deportata schiava qui, e l’Africa bianca delle tribù del nord: Arabi, Berberi e Tuareg.
Abdaraman è mussulmano, ha subito la circoncisione come tutti i figli d’Ismaele ed è della stretta osservanza. Suo padre Aleck è un bravo uomo, rico di fede e di figli. Quando viene il mese del Ramadan digiuna dall’alba al tramonto, pur continuando a lavorare il suo campo lungo la sponda dell’Oued di Tamanrasset. Aleck è veramente religioso e ogni anno ricorda il sacrificio di Abramo con l’uccisione di un montone e in tale occasione compera un vestito chiaro di cotono a tutti i suoi piccoli. La sua fiducia in Dio è totale; e, anche se povero povero, non ruba, ma vive del suo lavoro, che consiste nello scavare per mesi e mesi nella sabbia dell’Oued un canale sotterraneo chiamato “seghia”e per altri mesi coltivare il suo campetto che ha bisogno d’acqua almeno tre volte la settimana.
Una volta arrivò la Legione straniera e si accampò lungo la “seghia”scavata nella sabbia e che porta l’acqua al grano di Aleck.
Naturalmente l’acqua venne a mancare e il grano di Aleck incominciò ad appassire.
“Aleck – gli dico, – se continua così, il tuo grano secca. Va’ a dire al capitano che la “seghia” è tua, e che metta il campo altrove”.
Aleck mi risponde: “Allah è grande e provvederà per i miei figli”; e lascia morire il grano, mentre i legionari lavano i camion e si gettano l’acqua addosso per scherzare.
Dunque: Abdaraman mi accompagna stasera all’eremitaggio. Il sole è tramontato e l’aria si è fatta fresca, propizia al passeggiare. Abbiamo sempre molte cose da raccontarci, perché ci vogliamo veramente bene. Ogni mattina me lo trovo davanti alla cella in attesa ch’io finisca la meditazione. Sovente prendiamo il the assieme; ed egli mi dice che gli piace molto il pane che faccio io. Abdaraman ha sempre appetito; ma non mi chiede mai nulla: sono io che debbo indovinare.
Questa sera è serio e risponde a stento alle mie domande. Capisco che ha qualcosa di importante da dirmi e non osa.
Ma so che non tarderò a sapere, perché tra me e lui non ci sono segreti.
“Che cos’hai, Abdaraman, stasera? Perché non parli?”.
Silenzio.
“Non hai mangiato il ‘couscous’?”.
Silenzio.
“Ti ha picchiato il babbo?”.
Silenzio.
“Il fenek è scappato dalla gabbia?”.
Silenzio.
“Ma parla, Abdaraman; apri il cuore al tuo amico fratel Carlo”.
Abdaraman scoppia a piangere e il suo corpo nudo si agita e si contrae.
È uno spettacolo vederlo piangere: ce la mette tutta; e le lacrime, dopo aver irrigato il volto, continuano la marcia sul petto e sul ventre.
Ora sono io che faccio silenzio. Debbo attendere la pacificazione degli elementi.
Gli serro più forte le mani in segno di affetto.
“Allora, Abdaraman, che cosa ti fa piangere?”.
“Fratel Carlo, piango perch’` tu non ti fai mussulmano!”.
“Oh – esclamo io – e perché mi debbo fare mussulmano? Abdaraman, io sono cristiano e credo in Gesù. Io prego il Dio che creò il cielo e la terra come te, e le nostre preghiere vanno nello stesso Cielo, perché di dei ce n’è uno solo. E il mio Dio è il tuo Dio. È Lui che ci ha creati, ci nutre, ci ama. Se tu farai il tuo dovere, non ruberai, non ucciderai, non dirai menzogne; se tu seguirai la voce della tua coscienza, andrai in Paradiso; e sarà lo stesso Paradiso del mio, se anch’io avrò fatto ciò che Dio mi comanda. Non piangere più”.
“No, no – mi grida Abdaraman; – se tu non ti fai mussulmano, vai all’inferno come tutti i cristiani”.
“Oh, questa è bella, Abdaraman! Chi t’ha detto che andrò all’inferno se non mi darò mussulmano?”.
“Me l’ha detto il Taleb (maestro della scuola coranica) che tutti i cristiani vanno all’inferno; e io non voglio che tu vada all’inferno”.
Siamo giunti vicino all’eremitaggio e Abdaraman si ferma. Più avanti non è mai venuto. S’è sempre fermato a una decina di passi da quella costruzione, e per tutto l’oro del mondo non entrerebbe, come se là dentro ci fosse una misteriosa diavoleria interdetta ai piccoli mussulmani.
L’amore che ha per me, ed è molto, s’è sempre urtato contro questo muro che ci divide e che stasera prende addirittura il nome così tremendo: “inferno”.
Gli dico: “No, Abdaraman; Dio è buono e ci salverà tutti e due; salverà tuo padre, e tutti andremo in Paradiso. Non credere che per il solo fatto ch’io sono cristiano andrò all’inferno, come io non credo che tu ci andrai perché sei mussulmano. È così buono Iddio! Forse non hai capito bene che cosa voleva dire il Taleb; forse ha detto che i cattivi cristiani vanno all’inferno. Sta’ tranquillo; va’ a casa a recitare la tua preghiera mentre io reciterò la mia; e prima di terminare, di’ questo a Dio, come dirò io: – Signore, fa’ che tutti gli uomini si salvino. – Va’ …”. Ed entro triste nell’eremitaggio, in questa piccola costruzione di fango, costruita dallo stesso Charles de Foucauld, che volle farsi chiamare Piccolo Fratello universale e che qui morì trucidato per ignoranza e fanatismo dai figli della stessa tribù di Aleck e Abdaraman.
Ma stasera mi sarà difficile pregare! Quale tumulto di pensieri ha suscitato in me il mio piccolo amico!
Povero piccolo Abdaraman! Anche tu vittima del fanatismo, dello zelo intempestivo dei cosiddetti “uomini di Dio”, dei religiosi che manderebbero all’inferno metà del genere umano, solo perché “non sono dei loro!”.
Quanto è doloroso tutto ciò! Come è possibile che ciò avvenga? Che il filo d’amore che mi unisce ad un fratello sia spezzato dal presento “zelo per Dio”! Che la religione, invece di essere motivo di unione, divenga trincea di morte o per lo meno di odio inconfessato. Meglio non averla questa religione che divide. Meglio brancicare nel buio che possedere una simile luce!
* * *
Dopo un’ora di sforzo per raccogliere la mia povera anima dinanzi al silenzio dell’Eucaristia, mi sono accorto che le lacrime rigavano la mia “grandura”bianca. Ero io ora che piangevo. E sapete perché?
Facendo l’esame di coscienza per purificare la mia anima e non quella di Abdaraman dal settarismo mi era tornata alla memoria una scena che risaliva alla mia infanzia. Avevo allora otto anni, proprio otto anni come Abdaraman. Vivevo allora in un villaggio all’ombra di un antico campanile. Non era molto religiosa la popolazione, ma era chiusa e tradizionalista all’eccesso.
Un giorno venne un uomo a vendere libri, passando di casa in casa. Non capivo molto, allora, ma fu la prima volta ch’io intesi la parola “Bibbia”.
Si produsse nel villaggio un’agitazione strana. Prima nelle donne, poi in tutti; chi per zelo, chi per rispetto umano.
Si sentirono nell’aria grida isteriche d’una donna. Da una finestra gridava:
“Barbet, barbet. Non abbiamo bisogno della tua religione. Va’ via di qui”.
L’agitazione raggiunse i ragazzi.
L’uomo camminava in mezzo alla strada, pallido. Aveva i libri in una grande borsa scura, pesante.
Una donna gli tirò dietro un libro che aveva avuto poco prima. L’uomo s’abbassò a raccoglierlo senza voltarsi. Una pietra scagliata da un ragazzo lo colpì nella schiena. Accelerò il passo, seguito dai ragazzi a distanza. Ciascuno aveva in mano una pietra. Tra quei ragazzi c’ero anch’io.
La sera, alla benedizione eucaristica del mese mariano, il parroco ci lodò, perché avevamo difeso la trincea della parrocchia.
Sembra nulla; ma a distanza di quarant’anni, e particolarmente stasera, quella scena acquista un valore ed una gravità tutta nuova.
Non mi sono mai confessato d’aver tirato un sasso dietro ad un uomo indifeso, e per zelo religioso. L’episodio si iscrive in un mondo che accettava simili cose, senza vederne tutta la malvagità.
Ma a distanza di mezzo secolo le cose sono cambiate.
C’è nell’aria qualcosa di nuovo. Un soffio dello Spirito anima l’universo intero. Un mondo vecchio muore e un altro nasce. Altra sensibilità, altre esigenze, altre forze. Siamo all’alba di un’epoca marcata da un gran desiderio d’amore e di pace tra i popoli e tra gli uomini.
La verità e la carità sono in marcia di nuovo per incontrarsi; e il rispetto della persona umana è diventato il rritornello, il canto di tutte le genti.
Un senso ecumenico scioglie i nodi più complicati; e un desiderio di conoscerci e di capirci supera di gran lunga la tentazione di rimanere chiusi nella vecchia cittadella della nostra presunta verità.
L’uomo, forse, per la prima volta esce in campo senza difese e con la speranza di incontri fecondi.
L’amicizia sta diventando la normale via dei rapporti umani e le guerre di religione sono confinate nella storia del passato.
* * *
Abdaraman, mio piccolo e caro Abdaraman, non temere; ci ameremo ancora e ci incontreremo; e… non solo in Paradiso.
Nazaret
Charles de Foucauld era un nobile visconte. Nelle sue vene correva sangue altero e abituato al comando.
Innamoratosi di Cristo con la forza di un S. Francesco, ne ricercò nel Vangelo la personalità, il carattere, la vita.
È raro trovare un uomo più passionatamente impegnato a scoprire i dettagli della vita di Gesù per imitarne l’atteggiamento, i gesti, le intenzioni recondite.
Ebbene: in questa ricerca amorosa, fatta per trovare materia di imitazione fedele e vivente, Charles de Foucauld si stupisce soprattutto di una cosa: Gesù è un povero e un operaio.
Nessuno può contraddire questo fatto. Il Figlio di Dio, che liberamente poteva scegliere – ciò che non capita a nessun altro, – scelse non solo una madre e un popolo, ma una situazione sociale, e volle essere un salariato.
Bisogna dire che questa parola “manovale”, “operaio”, “salariato”, ha un suono ben diverso nelle orecchie di un nobile da quello che può avere nelle mie. Per Charles de Foucauld, scegliere la situazione sociale di un operaio, significa l’abiezione, l’annientamento di se stesso.
Ed è appunto questa posizione volontaria di Gesù di perdersi in un borgo anonimo del Medio Oriente, di annientarsi nella monotonia quotidiana di trent’anni di lavoro rude e misero, di scomparire dalla società “che conta”, per morire in un anonimato totale, che maggiormente sconvolge il nobile convertito.
Perché Gesù non fu scriba? Perché non volle nascere in una di quelle famiglie destinate al comando, alle responsabilità, all’influenza sociale e politica?
Ed eccolo alla ricerca appassionata delle intenzioni che guidarono il Maestro divino nella scelta della sua vita, di tutta la sua vita.
E non tarderà ad uscire in quella esclamazione che resterà, in fondo, la guida ascetica della vita del grande esploratore del Marocco e del mistico Sahariano:
“Gesù ha talmente cercato l’ultimo posto, che ben difficilmente qualcuno potrà strapparglielo”.
Nazaret era l’ultimo posto: il posto dei poveri, degli anonimi, di coloro che non contano, della massa degli operai, degli uomini piegati alle dure esigenze della fatica per un po’ di pane.
Ma c’è di più. Gesù è il “Santo di Dio”. Ebbene, il “Santo di Dio” realizza la sua santità con una vita non straordinaria, ma tutta impregnata di cose ordinarie, di lavoro, di vita familiare e sociale, con attività umane oscure, semplici, possibili a tutti gli uomini.
La perfezione di Dio è colata su una materia che gli uomini quasi disprezzano, che in ogni caso non ricercano per la sua semplicità, per la “mancanza di interesse”, perché è comune ai più.
Una volta scoperta la realtà spirituale di Nazaret, Charles de Foucauld ne cercherà l’imitazione, la più fedele possibile.
Cercherà di avere un convento piccolo come la casa di Nazaret, cercherà di perdersi, annientarsi nel silenzio di un borgo sconosciuto, imiterà Gesù lavorando manualmente, e vorrà i suoi piccoli fratelli alla ricerca sempre dell’ultimo posto, là dove ci sono i poveri, là dove il clima è più rude, il salario più piccolo, la fatica più grande. Nazaret vorrà dire tutto questo; ma non solo.
* * *
L’imitazione di Nazaret non è piccola cosa. Quando penso che una porta, un assito, un muro può dividere una famiglia santa come quella di Gesù da quella di un vicino che, pur vivendo con lo stesso ritmo, la stessa fatica, la stessa giornata, ne è agli antipodi come tristezza, odio, impurità, cupidigia, e a volte disperazione, mi convinco della immensa ricchezza interiore portata dal messaggio evangelico. Le stesse azioni, compiute sotto la luce di Dio, trasformano radicalmente la vita di un uomo, d’una famiglia, d’una società.
Gioia o tristezza, guerra o pace, amore o odio, purezza o adulterio, carità o cupidigia sono tremende realtà che fanno il loro spartiacque sul crinale dell’interiorità dell’uomo. Vivere le cose comuni, i rapporti con gli uomini, il lavoro quotidiano, l’amore dei nostri in un determinato modo può generare santi; in un determinato altro modo, può generare demoni.
Gesù a Nazaret ci ha insegnato a vivere da santi tutte le ore del giorno. Tutte le ore del giorno sono valide e capaci di contenere l’ispirazione divina, la volontà del Padre, la contemplazione della preghiera: la santità, insomma. Tutte le ore del giorno sono sante; basta viverle come Gesù ci ha insegnato a viverle.
E per questo non è nemmeno indispensabile chiudersi in un convento o stabilire alla nostra vita orari strani e qualche volta disumani. Basta accettare la realtà che viene dalla vita. Il lavoro è una di queste realtà; la maternità, l’educazione dei figli, la famiglia con tutti i suoi impegni è un’altra di queste realtà.
Queste realtà devono essere santificate; e non dobbiamo pensare che si è santi solo perché abbiamo fatto dei voti.
Questa strana mentalità di considerare come sola materia di vita spirituale le ore di lettura o di preghiera e di non tenere in nessun conto le ore di lavoro e di rapporti sociali, quindi le ore più numerose, è motivo di gravi deformazioni, di vere storture, e, nei migliore dei casi, di personalità religiose anemiche o rachitiche.
Tutto l’uomo deve essere trasformato dal messaggio evangelico; non c’è azione in lui che possa essere indifferente; tutto contribuisce a santificarlo o a dannarlo.
Nazaret è la vita d’un uomo, d’una famiglia in tutta l’ampiezza dell’attività umana; è la maniera di vivere per trent’anni, quindi per il più lungo tempo a disposizione per realtà umane destinate a passare nel crogiolo della fede, della speranza e della carità.
Pochi hanno così bene riassunto la santità delle cose comuni come Gandhi nei suoi scritti.
Ecco che cosa dice il grande mistico indiano:
“Se quando s’immerge la mano nel catino dell’acqua,
se quando si attizza il fuoco col soffietto,
se quando si allineano interminabili colonne di numeri
al proprio tavolo da contabile,
se quando, scottati dal sole, si è immersi nella melma della risaia,
se quando si è in piedi davanti alla fornace del fonditore,
non si realizza la stessa vita religiosa
proprio come se si fosse in preghiera in un monastero,
il mondo non sarà mai salvo”.
* * *
Ma c’è ancora un aspetto di Nazaret che vorrei tratteggiare soprattutto per coloro che pensano che non sia possibile portare il messaggio evangelico senza strumenti, senza mezzi, senza denari.
Gesù era Lui il portatore del messaggio; ed era ancora Lui l’intelligenza somma, capace di escogitare il modo migliore per farsi capire e per realizzare il piano divino.
Ebbene; che cosa fece?
Non aprì ospedali, non fondò orfanotrofi: si incarnò in un popolo e visse con lui per primo il messaggio nella sua interezza:
“coepit facere“: incominciò a fare.
Questo far precedere alla parola l’esempio, questo presentare il “tipo” prima di spiegarlo agli uditori, è stato il modo di procedere di Gesù, che troppo facilmente dimentichiamo.
In molti casi la catechesi è ridotta a “parole”più che a un “fatto”, a conferenze più che a preoccupazione di santità personale.
E qui forse sta il motivo degli scarsi risultati, e più ancora della tristezza e noia dei cristiani.
Non c’è efficacia perché non c’è vita: non c’è vita perché non c’è esempio; non c’è esempio perché parole vuote han preso il posto della fede e della carità.
“Voglio gridare il Vangelo con la vita” ripeteva sovente Charles de Foucauld; e si convinse che il più efficace metodo di apostolato era il vivere da cristiano. Specialmente oggi, in cui la gente, diventata scaltra, non vuol più intendere sermoni: vuol vedere.
Nazaret è, prima dell’azione, il lungo tempo della preparazione, della preghiera, del sacrificio; il tempo del silenzio, della vita intima con Dio; il tempo della lunga solitudine, della purificazione, della conoscenza degli uomini, dell’esercizio del nascondimento: di ciò che conta, insomma, per dirsi cristiano.
Da Nazaret uscirà l’apostolo.
* * *
Ma quale apostolo?
Su questa parola di “apostolo” s’è prodotta una delle più grandi inflazioni dei nostri tempi. Si parla di apostolato a dritta e a rovescia; tutti son diventati apostoli e… anche il trasportare una sedia è qualificato come attività apostolica.
Forse s’è presa l’abitudine di usare parole grosse per imprimere alla vita parrocchiale o diocesana un ritmo un po’ più celere ma, detto questo, le cose non cambiano e le parole rimangono parole.
Non ho qui nessuna intenzione di analizzare il significato autentico della parola “apostolo”, né di far problemi su l’ampiezza reale del così detto “campo dell’apostolato”. Dio me ne guardi!
Ma ciò che vorrei dire a tale proposito è che meditando a lungo su Nazaret ho sentito scaturire dal profondo di questo mistero una chiarificazione tra la vita del laico e la vita del sacerdote, tra l’apostolato dei laici e l’apostolato dei sacerdoti.
La mia generazione ha vissuto un periodo un po’ speciale, qualche volta caotico e molte cose si debbono giustificare sia a motivo dell’infantile incompetenza e preparazione nostra, sia per l’eccezionale periodo della storia. In fondo quando una acsa brucia anche una donna può fare il pompiere ed un laico dar ordini a un Vescovo.
Ma normalmente non dovrebbe essere così. È una stonatura vedere un laico che fa il viceparroco ed è una stonatura vedere un sacerdote preparare le liste elettorali.
E perché è una stonatura? Qui davvero si potrebbero scrivere molti libri per rispondere a tale domanda e certamente si scriveranno perché l’esperienza ci ha insegnato molte cose. Quanto a me, preso alla sprovvista qui in mezzo alla sabbia che mi rende arido il cervello e alle termiti che mi divorano i libri nella cella, mi accontento di pensare a Nazaret e di trovare nella maniera di vivere di Gesù, Maria e Giuseppe l’ispirazione fondamentale della cosiddetta spiritualità dei laici.
Questa – la spiritualità dei laici – non dev’essere una brutta o bella copia di quella dei sacerdoti, ma un’altra cosa, autentica e genuina in sé, vera dinanzi a Dio e agli uomini. Altra è l’attività di un sacerdote, altra quella di un politico; altra è l’attività di un parroco, altra è l’attività di un lavoratore o di un padre di famiglia.
Se è vero che per spiritual;ità noi intendiamo il modo di pensare, vivere, sublimare, santificare gli atti della nostra vita, se ne deduce che il pensare, vivere, sublimare, santificare gli atti d’un sacerdote è cosa profondamente diversa da quella di pensare, vivere, sublimare, santificare gli atti di un lavoratore, d’uno sposo, di un sindaco.
È la materia che cambia. Sulla spiritualità del sacerdote, s’è fatta della strada: basta pensare ad un Curato d’Ars o a un Cafasso.
Non atrettanto si può dire per la spiritualità dei laici, anche se molti sentono che la nostra è esattamente l’epoca che affronterà il problema.
Il laico non deve fare il “quasi prete”, ma deve in virtù del suo stato santificare il suo lavoro, il suo matrimonio, i suoi rapporti sociali così vari, complessi ed impegnativi.
S. Pietro nella sua prima lettera al cap. II, al versetto 4, dice rivolgendosi ai laici: “Voi come pietre vive siete edificati sopra di Lui (il Cristo) per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo per offrire vittime spirituali gradite a Dio per mezzo di Gesù Cristo”.
Tutti qui sono concordi nel dire che esiste per il battezzato un vero ed autentico sacerdozio, ben diverso naturalmente dal sacerdozio conferito dal Sacramento dell’Ordine, ma un sacerdozio reale che pone il laico in faccia alla creazione per interpretarla, vivificarla, liberarla, rappresentarla.
Ciò è estremamente importante e il laico che non sente ciò ha tradito la sua vocazione.
Il lavoratore è un sacerdote davanti al suo lavoro; il padre di famiglia è sacerdote davanti alla sua sposa e ai suoi figli; il capo di una comunità è sacerdote dinanzi ai suoi congregati; il contadino è sacerdote dinanzi al suo podere, il suoi animali, i suoi campi, i suoi fiori.
Io penso che troppo poco è stato sviluppato in questi ultimi secoli il concetto di sacerdozio regale di cui parla S. Pietro nella sua lettera ai cristiani e di ciò che significhi questo “offrire vittime spirituali gradite a Dio da parte del battezzato”, e ciò ha creato in fondo l’aridità che noi sentiamo nel trattare l’argomento dell’apostolato dei laici e – direi di più – della posizione dei laici nella Chiesa.
Cosa volete parlare di spiritualità dei laici se omettete questa fondamentale prerogativa di sacerdote delle cose create, di voce della natura, di consacratore dei beni della terra, di santo della città terrena?
Non sentendo parlare di queste cose, il giorno in cui il laico vuol diventare “buono” finirà per copiare il parroco che gli sta di fronte e che sente “spiritualmente più avanti di lui” e diventerà mezzo laico e mezzo prete ad edificazione dei buoni parrocchiani, ma non certo di coloro che ne hanno più bisogno, “i lontani”.
Questi – ed a ragione – non possono sopportare il profumo di questo ibridismo e continuano a pensare che il cristianesimo non sa risolvere i problemi del mondo.
Rimane da fare molto cammino, ma siamo a buon punto, perché sacerdoti e laici hanno preso coscienza della loro posizione nella Chiesa.
È ciò che mi auguro perché vorrei fosse evitata a coloro che entrano oggi nell’arengo dell’azione apostolica la stonatura del mio tempo in cui sacerdoti furono trascinati a fare da galoppini elettorali ed i laici a dar consigli ai Vescovi sul governo della Chiesa.
L’ultimo posto
Sono diventato piccolo fratello di Gesù perché Dio l’ha voluto. Mai ho dubitato della chiamata; anche perché, se non fosse stata la volontà di Dio a mettermi su questa strada, non avrei potuto resistere a lungo.
Il dormire all’addiaccio, il vivere in climi estenuanti, il frequentare tribù veramente povere e il sopportarne il fetore, è ancora piccola cosa in confronto allo svuotamento della personalità, al taglio col passato, all’accettazione radicale di civiltà e patrie diverse dalle nostre.
E mi spiego.
Come sapete, il piccolo fratello non può avere opere sue. Non può fare scuola, organizzare ospedali, creare dispensari, distribuire aiuti. Deve venire qui, scegliere un villaggio, una bidonville, una tribù nomade, installarsi in essa e vivere come vivono tutti gli altri, specie i più poveri.
È il capovolgimento totale del sistema europeo in vigore fino a ieri.
Qui l’europeo che arrivava: militare, missionario, tecnico o funzionario, si costruiva una casa all’europea e viveva da europeo tra indigeni. Il suo standard di vita non era quello del luogo, ma quello del paese di origine.
Il compito era quello di evangelizzare, elevare, aiutare, organizzare, sorreggere; ma sempre all’europea, con cultura, metodi, finalità europee. La fede di questi uomini aveva la sua testimonianza nel dono.
E non è piccola cosa! Miracoli di amore e di eroismo furono scritti in terre d’Africa e d’Asia: chiese, ospedali, dispensari, scuole, opere sociali furono create per recare sollievo, allontanare la morte, accelerare il processo di evoluzione dei popoli sottosviluppati.
Fu la grande ora missionaria della Chiesa, fu la provvidenziale attività di colonizzazione, giustificata pienamente dai tempi e dalle realtà di allora.
In ogni caso fu l’inserimento della stirpe dei bianchi in quella degli uomini di colore, fu l’andata dei ricchi verso i poveri, dei cristiani verso i pagani. Non sempre tutto camminò liscio, non sempre missionario fu sinonimo di uomo di Dio e funzionario sinonimo di generosità e gratuità.
Troppo lunga sarebbe la storia; e, continuando, finiremmo per fare il processo al passato.
Ciò che c’interessa è il constatare che in pochi anni tutto è cambiato.
Le chiese africane prendono coscienza della loro autenticità e non vogliono più essere copie delle chiese francesi o italiane o olandesi; i popoli di colore non solo non sopportano più il colonialismo; ma, per reazione, chiudono il loro cuore ai bianchi, non han più la confidenza di una volta, e sovente disprezzano od odiano tutto ciò che viene dall’antica razza dominatrice.
Com’è naturale, in questi casi, si passa il limite, si diventa ingiusti; e del passato si finisce di vedere solo il male.
È davvero l’ora in cui è necessario rivedere radicalmente le posizioni, tutte le posizioni.
* * *
In questa luce e più ancora dinanzi alle future attività della Chiesa in terra di missione va vista come profetica l’opera di Charles de Foucauld.
Questo uomo di Dio, ignaro di tutti i problemi, spinto solo dalla forza e dalla luce dello Spirito, va in Africa in pieno tempo di colonizzazione. Nell’aria non c’è ancora il minimo sentore di ciò che avverrà su così vasta scala. Preoccupato solo di portare il Vangelo ai Berberi o ai Tuareg, capisce ciò che gli altri non capiscono e lavora come se il processo di decolonizzazione fosse già avvenuto.
Non doni, non ospedali, non dispensari, non scuole, non denaro.
Si presenta solo, indifeso, povero.
Ha capito che la potenza dell’europeo, anche se espressa in ospedali, scuole, non dice quasi più nulla su un piano religioso al povero africano; non è più una testimonianza come una volta.
Ha capito che l’indigeno, anche se molto sottosviluppato, non è più disposto ad accettare dall’alto, come un tempo, un messaggio che gli sembra troppo legato ad un dato popolo e a una data civiltà.
Occorre battere un’altra strada; ed è quella di sempre, perché è scritta nel Vangelo, ma con una purezza e forza nuova: è la strada della piccolezza, del sacrificio, della povertà, del nascondimento, della terstimonianza.
È un fatto indiscutibile, e non solo per i paesi poveri: si ha paura della potenza. Una Chiesa potente, ricca, dominatrice, oggi spaventa.
L’occhio dell’uomo, terrorizzato dalle possibilità della tecnica, si posa con gioia su ciò che è piccolo, indifeso, debole. Si ha perfino paura di un oratore che gridi troppo forte.
Sta proprio qui il segreto della popolarità acquistata da Charles de Foucauld. Si è presentato tra assassini come erano i Tuareg, indifeso; è entrato nel mondo arabo vestito da arabo, ha vissuto tra coloro che erano i servi degli europei come se fossero suoi padroni, ha costruito i suoi eremitaggi non copiando le architetture romane o gotiche, ma imitando la semplicità e la povertà delle moschee sahariane.
* * *
Questo presentarsi povero, questo vestire “come loro”, questo accettare la loro lingua, i loro costumi, di colpo ha fatto cadere il muro e ha permesso il dialogo, l’autentico dialogo: quello tra uguali.
Mai dimenticherò una scena che nella sua semplicità esprime plasticamente il pi`no di amore di questo nuovo “andare verso coloro che non conoscono ancora il Cristo”.
Percorrevo a cammello la pista tra Geriville e El Abiod, ed ero diretto ad una zona desertica, per qualche giornata di solitudine.
Ad un certo punto della pista m’imbatto in un cantiere di lavoro. Una cinquantina di indigeni, guidati da un sottufficiale del genio, faticava a sistemare la strada rovinata dalle piogge invernali. Sotto il sole sahariano, non macchine, non tecnica: solo la fatica dell’uomo nel caldo e nella polvere a maneggiare per tutta la giornata la pala e il piccone.
Rimonto la fila del manovali disseminati sulla pista, rispondo al loro saluto, offro la mia “gherba” di 30 litri di acqua alla loro sete.
Ad un certo punto, tra le bocche che si avvicinano al collo della “gherba” per bere, vedo schiudersi un sorriso che non dimenticherò più.
Povero, stracciato, sudato, sporco: è frère Paul, un piccolo fratello che ha scelto quel cantiere per vivere il suo calvario e mescolarsi a quella pasta come lievito evangelico.
Nessuno avrebbe scoperto l’europeo sotto quegli abiti e quella barba e quel turbante ingiallito dalla polvere e dal sole.
Io conoscevo bene frère Paul, perché avevo fatto il noviziato assieme.
Ingegnere parigino, lavorava in una di quelle commissioni destinate a preparare la bomba atomica di Reganne, quando sentì la chiamata del Signore.
Lasciò ogni cosa e fu piccolo fratello.
Ora era lì; e nessuno sapeva che era un ingegnere: era un povero come gli altri.
Ricordo sua madre quando venne in occasione dei voti al noviziato.
“Mi aiuti, fratel Carlo, a capire la vocazione di mio figlio. Io l’ho fatto ingegnere, voi l’avete fatto manovale. Ma perché? O almeno vi serviste di mio figlio per quel che vale! No: dev’essere un manovale. Ma dite, alla Chiesa non ne verrebbe più decoro, più efficacia a farlo agire come intellettuale?”.
“Signora, rispondevo io, ci sono cose che non si possono capire con l’intelligenza e il senso comune. Solo la fede ci può illuminare. Perché Gesù volle essere Lui povero? Perché volle nascondere la sua divinità e la sua potenza e vivere tra noi come ultimo? Perché, signora, la sconfitta della croce, lo scandalo del Calvario, l’ignominia della morte per Lui che era la Vita? No, signora; la Chiesa non ha bisogno di un ingegnere di più, ma ha bisogno di un chicco di grano di più da far morire nei suoi solchi. E più questo chicco è turgido di vita e sapido di cielo e di sole, e più sarà gradito alla terra che lo deve accogliere per la futura messe”.
Quante cose non si possono capire su questa terra! Non è tutto un mistero ciò che ci circonda?
Che Paul sacrifichi se stesso, la sua cultura, la sua possibilità per amore di Dio e per amore dei suoi fratelli più abbandonati io lo capisco; ma capisco pure le reazioni di sua madre, e non solo di sua madre.
Quanti direbbero: peccato! una sì bella intelligenza, finire in un solco della pista sahariana. Avrebbe potuto costruire una rotativa per diffondere la buona stampa… E avrebbero anche ragione.
È difficile cogliere il punto giusto del mistero dell’uomo che è una parte del grande mistero di Dio. C’è chi sogna una Chiesa potente, ricca di mezzi e di possibilità, e c’è chi la vuole povera e debole; c’è chi dà vita e cultura e studio per arricchire di pensiero la filosofia cristiana, e c’è chi rinuncia anche a studiare per amore di Dio e del prossimo.
Mistero di fede!
A Paul non interessava “avere influenza” sugli uomini; gli bastava “pagare”, “scomparire”. Altri cercheranno altre vie e realizzeranno la loro santità in modo differente.
Posso dubitare della fede di mia madre che avrebbe desiderato tutta la ricchezza in mano alla Chiesa per il decoro dell’altare, le opere missionarie e la dignità del culto?
Ed io, suo figlio, che ero esattamente all’opposto e sognavo un culto più spoglio, una povertà più sentita, e soprattutto un apostolato fatto con “mezzi poveri”, non avevo anch’io le mie ragioni?
È tanto difficile giudicare! Tanto difficile che Gesù ci pregò di non insistere sull’argomento.
C’è però una verità, alla quale attaccarci sempre, disperatamente sempre: l’amore!
È l’amore che giustifica le nostre azioni, a volte così contrastanti. È l’amore la perfezione della legge.
Se è per amore che frère Paul ha scelto di morire su una pista del deserto, da questo è giustificato.
Se è per amore che Don Bosco e il Cottolengo costruirono scuole e ospedali, da questo sono giustificati.
Se è per amore che S. Tommaso passò la sua vita sui libri, da questo è giustificato.
Rimane solo il problema di stabilire la gerarchia di questi amori; e qui è Gesù stesso che ci insegna in modo inequivocabile: “Chi di voi vuol essere il primo, sia l’ultimo e come colui che serve” (Lc 22, 26).
E ancora: “Nessuno ama di più l’amico di colui che dà la vita per esso” (Gv 15, 13).
O tu che passi per via…
La pista di Taifet è semplicemente orribile.
Tutte le volte che l’ho potuto l’ho evitata con gioia. Preferivo allungare di qualche chilometro il tragitto passando per Ideles e Irafok piuttosto di transitare tra quelle gole impervie, bisognava farsi strada col piccone e la pala nei tratti rocciosi e sprofondare poi nella sabbia molle degli oued tortuosi e bizzarri che non finivano mai.
Ma quella volta non avevo avuto altra scelta e mi ero ingaggiato in essa raccogliendo tutto il coraggio di cui disponevo, che non era molto dopo una settimana di vento caldo del sud e la fatica di rilievi meteorologici diurni e notturni.
Il cielo era, come al solito, senza nubi, e implacabile il sole fin dal mattino. Ma non ci facevo caso: la mia preoccupazione, l’unica mia preoccupazione era il motore della jeep che dava segni di stanchezza e che non voleva più saperne di sradicare la macchina quando affondava nella sabbia fino al telaio.
Eppure bisognava avanzare. Chi sarebbe venuto ad aiutarmi su quella pista?
La sera prima, al pozzo di Tazrouk avevo caricato sì tutta l’acqua possibile, ma anche quella finita… e poi?
E poi, cosa avrei fatto in quella landa deserta, immagine della morte e del perpetuo silenzio?
Sì, tutte le mie speranze erano nel motore; quel motore che conoscevo così bene nel fremito e nelle voci e che non mi aveva mai tradito fino allora.
Ma ora? Sarei riuscito ad attraversare i ventidue chilometri dell’oued di Taifet così soffice nelle sue sabbie lucenti, così caldo nelle sue gole selvaggie?
Le nove… le dieci… le undici… , tra pause per lasciar raffreddare il motore e strappate fortunate su banchi di sabbia più compatta ero giunto finalmente in vista di Taifet, piccolissimo villaggio di ex schiavi sui bordi dell’oued omonimo.
Mi lanciai sulla pista deciso a vincere con la velocità la presa della sabbia che si faceva sempre più molle e insidiosa. Il caldo era soffocante e l’acqua bolliva nel radiatore.
In quelle condizioni non avrei certo fatto molta strada! Difatti, in un ultimo sforzo per sostenere l’andatura, il motore che ronzava a tutto gas, ebbe un gemito stroncato e si fermò.
Ero sprofondato nella sabbia.
Scesi dalla jeep ma ebbi paura di un colpo di sole.
Non mi sentivo di prendere la pala per liberare la macchiana dalla sabbia.
Cercai un po’ d’ombra.
Nell’oued, qua e là c’erano cespugli di etel. Mi diressi al più vicino e mi gettai aterra alla sua ombra.
Non so come, ma in quel momento mi tornò alla mente il profeta Giona seduto sotto l’ellera che lo riparava dal sole davanti a Ninive infuocata.
Ma ebbi poco tempo per considerazioni bibliche e mi addormentai subito.
* * *
Quando ripresi i sensi sentii attorno a me un parlare sommesso intercalato da risatine.
Ero immerso in un bagno di sudore e la testa mi faceva male.
Aprii gli occhi e vidi attorno a me gli uomini di Taifet che mi guardavano sorridendo.
Com’erano bianchi i loro denti e come brillava la loro pelle scura!
Erano forse una ventina e avevano interrotto il loro lavoro al mio arrivo.
Sotto l’etel vidi che avevano già preparato il fuoco per il the. Quella bevanda calda ed eccitante mi ristorò alquanto.
Mi invitarono a mangiare con loro il “couscous” ed io offrii tutto ciò che avevo sulla jeep.
Soprattutto il tabacco li rese loquaci e la siesta ebbe momenti di particolare gaiezza.
Ma fu così breve!
Era il lavoro che li attendeva e che lavoro!
Dovevano scavare nell’oued un canale sotterraneo, chiamato “fogara”, capace di raccogliere l’acqua di cui era imbibita la sabbia come una spugna e condurla ai campetti vicini dove il grano seminato e ormai adulto aveva una gran sete. Il solito temporale fuori tempo aveva distrutto la vecchia “fogara” e bisognava rifare il lavoro senza perdere tempo.
Una settimana di ritardo sarebbe bastata per compromettere tutto il raccolto, il che voleva dire fame per tutto l’anno.
Mi offrii a lavorare con essi per qualche giornata pur sapendo che il mio aiuto non era dei più validi.
Fu così che vissi per una settimana con uno dei più poveri gruppi umani che esisteva sulla terra.
Il lavoro cominciava all’alba e durava fino al tramonto.
Con rudimentali strumenti si scavava la galleria che correva a circa tre metri sotto il livello dell’oued in un materiale sabbioso, ma compatto. La sabbia scavata veniva spinta verso i pozzi che intercalavano la galleria e gettata fuori con l’aiuto di pale.
Chi lavorava nella galleria aveva il vantaggio di soffrire di meno il caldo, ma in posizione scomoda, chi lavorava fuori soffriva meno il mal di schiena, ma soffocava dal caldo. Nei due casi, si stava molto male e si sospiurava la sera, il cibo e il riposo.
La sera si magiava atorno ai fuochi e se fossero stati presenti gli studiosi americani di dietetica avrebbero fatto con facilità il calcolo delle calorie ingoiate e sempre al di sotto del minimo vitale. In compenso però si mangiavano cose rarissime per gusti e piatti europei.
La prima sera venne servito con un po’ di “couscous” un piatto di cavallette arrostite; il giorno dopo, alcuni topolini delle sabbie chiamati “gerboise” e per due altre volte pezzetti cotti di un lucertolone chiamato “dobb” molto gustoso e che conteneva – a detta dei Tuareg – ben quaranta medicamenti preziosi.
La notte, avvolto in una coperta, vicino alle capanne, guardavo il cielo lungamente prima di addormentarmi.
Quale rapporto poteva avere tutto quello scintillio di stelle con quella miseria, in cui ero piovuto; quella infinitezza della materia profusa nel cosmo senza limiti e l’indigenza mortale di quegli uomini?
Era il mistero del male, del dolore; il mistero degli uomini che muoiono di fame, che vivono abbrutiti da un lavoro disumano, condannati ad una vita in cui la perpetua angoscia di trovare un po’ di pane avvelena la gioia del sogere del sole in ogni giornata.
Ma ero troppo stanco per pensare al perché Dio non interveniva, Lui così potente e così buono. Ripiegavo con facilità sugli “dei della terra”, sugli uomini che avrebbero potuto aiutarci con tanta facilità.
Che costa scrivere una lettera in Italia a tanti amici? Mi avrebbero subito mandato un “buldozer” per scavare la trincea in pochi giorni; mi avrebbero spedito con urgenza almeno dei grossi tubi di cemento per rendere la galleria stabile e sicura onde impedirne i crolli al primo scorrere dell’acqua nell’oued. Ed io restavo lì immobile a guardare le stelle!
Era giustificata questa mia inattività o almeno questa mia poco intelligenet attività?
A che cosa potevano servire queste mie povere braccia davati a tanto lavoro, questo mio vecchio cuore dinanzi a tanta fatica?
Non era meglio cercar dei mezzi e molti?
* * *
È questo il problema che mi son posto sovente, anzi così sovente da diventare una tentazione continua allo slancio della mia stessa vocazione.
Basta deflettere per un istante dal clima di fede nel quale cerco di vivere per vedere subito trionfare in me il “buon senso” umano.
Il buon senso dlla madre di frère Paul che non riusciva a capire l’inutile sacrificio del figlio sulle piste sahariane, il buon senso mio che cerca di convincermi che sarò più utile alla gente di Taifet portando qui qualche autocarro di materiale; il buon senso degli uomini che credono che coi soldi si può tutto risolvere e che la sofferenza è inutile spreco.
Ma c’è il buon senso del Vangelo? O c’è il mistero?
Forse che Gesù quando venne su questa terra, Lui, l’Onnipotente, Lui l’Amore, non poteva guarire tutti i malati, sfamare tutti i poveri, lenire tutte le piaghe, risuscitare tutti i morti?
Perché non l’ha fatto? Perché ha lasciato il mondo come l’ha trovato, bisognoso, sofferente, ingiusto, cattivo?
Ha risuscitato Lazzaro e la figlia di Giairo e il figlio della vedova di Naim è vero, ma solo per provare che non intendeva risuscitare tutti gli altri ed eran molti. Ne ha guariti sì parecchi, ma per lasciarli riammalare alla prima occasione non certo rara per l’uomo sulla terra.
No, le cose non sono così chiare come il buon senso umano le vorrebbe, e resta, piaccia o non piaccia, un grande e buio mistero che solo la fede mi può illuminare e illuminare con una luce che non è di questo mondo e che ha bisogno per essere utilizzata di occhi ben avvertiti e penetranti.
* * *
Il mistero è Gesù stesso. Ed è mistero non solo nella sua trascendenza divina, ma anche nel momento in cui si avvicina a noi con la sua Incarnazione. La perfezione di Dio, l’onnipotenza di Dio, l’amore infinito di Dio si sono fatti uomo nel Cristo che “abitò tra noi”.
Sempre, ma soprattutto in due momenti questo “abitare tra noi” sono veri nella loro sfolgorante bellezza: a Betlemme e sul Calvario.
A betlemme Dio diventa l’impotenza assoluta, sul Calvario diventa la sofferenza stessa.
Mai Gesù fu così uomo come in quelle due posizioni perché l’impotenza e il dolore sono le più cospicue eredità dell’uomo sulla terra come creatura e come peccatore.
C’è però una differenza sostanziale tra l’impotenza e la sofferenza dell’uomo e l’impotenza e sofferenza del Cristo: le prime sono d’obbligo, le seconde sono volontarie; le prime nella rivolta, le seconde nell’amore. Gesù si mette accanto all’uomo e gli insegna a vivere l’impotenza ed a sopportare la sofferenza con l’amore, nell’amore.
È quindi l’amore la grande finestra aperta sul mistero dell’una e dell’altra eredità dell’uomo, e solo l’amore.
Accanto all’uomo immerso nella sua indigenza o soffocato dal suo dolore Gesù passa.
Aveva mille modi per aiutarlo, ma sceglie il più duro, il più radicale: imitarlo, mettersi al suo posto, somigliargli il più possibile. “In tutto si fece simile all’uomo meno che nel peccato“. Invece, accanto a Giobbe che si guarda le ulcere e piange sul letamaio della vita, gli amici teologi fanno delle discussioni e conversano sui “perché”.
Arrivano fino a giudicarlo e ad accusarlo: “Se tu soffri, è perché hai peccato” gli dicono, e lasciano il povero uomo nel pianto e con parole amare in bocca: “Perisca il giorno in cui nacqui e la notte in cui si esclamò: È concepito un uomo“(Giobbe 3, 3).
È per questo che, per chi soffre, non basta la teologia. Bisogna fare qualche altra cosa.
* * *
Quando ero partito la prima volta per l’Africa per farmi piccolo fratello di Gesù, avevo vissuto qualche tempo ad Algeri ospite di un vecchio amico.
Avevo il cuore in tumulto in quei giorni e il mondo mi appariva sotto una luce nuova, che scaturiva a fiotti da quella intuizione nata nel cuore di colui che ora volevo seguire sulle piste del deserto: Carlo de Foucauld.
Vedevo tutto alla rovescia rispetto alla prospettiva dell’europeo, dotato di mezzi e di cultura, desideroso di dare, di fare qualcosa per gli altri.
Avrei voluto nascondermi senza portafoglio in tasca e vestito da arabo tra la folla anonima dei mussulmani poveri che brulicavano nelle viuzze della Kasba.
Mi ricordo che sul mezzogiorno avevo notato il formarsi di una lunga fila di straccioni accanto al marciapiedi di un caseggiato solido come una fortezza…
Ogni povero aveva la gavetta. Vidi aprirsi una porta e comparire una suora tutta bianca con le due grandi cornette bianche, e vicino una enorme marmitta fumante.
Era l’ora della distribuzione quotidiana dell’elemosina ed ogni povero partiva con una pagnotta e una minestra calda.
Io fissavo quella processione come allucinato e considerando quegli uomini e quelle donne segnate dalla miseria, le lacrime mi scendevano dagli occhi, velando la scena sotto il cielo luminoso della città africana.
Cercavo il mio posto in mezzo a tutta quella povertà.
Avevo abbandonato la mia patria spinto dal desiderio di svuotarmi per darmi al mio Dio, di cercare tra i poveri il volto crocifisso di Gesù, di fare qualcosa per i miei fratelli più derelitti e disprezzati, per trovare in essi e nell’amore per essi più rapidamente l’unione vitale con l’Eterno.
Che cosa dovevo fare dunque? Dovevo anch’io aprire dei dispensari e dare, dare pane e cultura e medicine a quella povera gente? Qual era il mio posto nella grande opera evangelizzatrice della Chiesa?
Cercai il posto di colui che mi aveva attirato in Africa, il Padre de Foucauld. Tutto piccolo, tutto umile con la gavetta in mano, lo trovai in fondo alla fila. Sorrideva con discrezione come se volesse scusarsi di essere anche lui lì ad imbrogliare il terreno ed a complicare le cose.
Indubbiamente, in quel momento, anche con tutta la mia paura di soffrire, con tutta la mia debolezza a sopportare il peso degli altri, il mio terrore a montare sulla croce, capivo che anche il mio posto era là e che avrei cercato di seguire la turba restando mescolato ad essa.
Altri nella Chiesa avrebbe avuto il compito di evangelizzare, costruire, sfamare, predicare: a me il Signore chiedeva di essere povero tra i poveri, operaio tra operai.
Sì, soprattutto operaio tra operai, dacché il mondo di oggi non era più il mondo in cerca di elemosina come al tempo di Francesco, ma il mondo in cerca di lavoro e di giustizia.
Il mondo verso il quale camminavo era il mondo in cui la povertà è espressa dal proletariato di tutte le razze e di tutti i popoli, per il quale il lavoro è il duro cilizio quotidiano in quanto lavoro non scelto e in più doloroso, sporco e mal retribuito.
* * *
Dopo una settimana trascorsa a Taifet, ripartii per Tamanrasset.
Sentivo che non avrei resistito più a lungo a quella fatica ed a quella indigenza. In questo ero più povero io di quei poveri, perché non riuscivo a sopportare ciò che essi sopportavano da sempre.
Avevo bisogno di preghiera. Avevo sete di trovarmi solo nel mio eremitaggio dove Gesù era esposto giorno e notte per sfogarmi con Lui, supplicare Lui, perdermi in Lui.
Soprattutto volevo chiedergli di farmi più piccolo, più svuotato, più trasparente.
E rendermi capace di tornare a Taifet.
Sì, tornare a Taifet per vivere gli ultimi anni della mia vita. Avere una capannuccia “come loro”, un corredo ridotto ad una stuoia ed una coperta “come loro”, sulla sponda di quell’oued, a cui strappare un po’ d’acqua con quelle crudeli “fogare” che crollavano continuamente come se ridessero della nostra fatica!
Ma “più di loro” avere Gesù nell’Ostia, nascosto nella capanna per adorarlo, impetrarlo, amarlo e attingere da Lui la forza per non ribellarmi, per non maledire, per accettare amando la indigenza di ogni ora.
E così, fino al giorno in cui sulla sponda di quell’oued si sarebbe alzata una piccola croce di etel che come sentinella avrebbe vigilato sulla solitudine di quegli uomini in attesa che altri, altri, altri fossero venuti per amarli e aiutarli ad amare.
La rivolta dei buoni
Ch’io abbia scelto l’ultimo posto come impegno vocazionale non significa proprio nulla: ciò che conta è sfrorzarmi di restar a quel posto, ogni giorno della mia vita.
E questo è terribilmente difficile!
C’è nel fondo del cuore umano un bubbone che cresce con l’andar degli anni: è il bubbone del vittimismo. Nessuno è esente da questo male; e solo molto tardi l’anima riesce ad individuarlo e, Dio voglia, ad estirparlo!
Il vittimismo è l’attegiamento classico dell’uomo rimasto al Vecchio Testamento e che invoca nei rapporti col prossimo la sola giustizia.
Guardiamo una famiglia qualunque. Sovente il peso della fatica è mal distribuito e grava in particolare su qualcuno dei membri; il più sovente sulla madre.
Per anni ed anni le spalle che portano quel peso si piegano allo sforzo; e, per quel sacrificio, il resto della piccola compagine riesce a marciare in pace.
Ma eccoti che sotto quelle spalle c’è un cuore; e in quel cuore, poco alla volta, il bubbone del vittimismo si sviluppa, cresce nelle lunghe, silenziose personali meditazioni.
Un giorno, un brutto giorno, o a causa di uno sforzo maggiore o per effetto di un colpo di spillo in profondo, il bubbone scoppia e spande nel corpo il suo sottile veleno!
– Basta, ora basta! Ho fatto finora la vostra serva, e non ve ne siete nemmeno accorti. Ho sacrificato la mia vita, mentre voi vi siete divertiti… ecc., ecc.
Quando le stesse cose capitano – e capitano – in una comunità religiosa o in un’associazione di pie persone, la tempesta è molto più grande; e sovente gli stessi muri dell’edificio corrono il pericolo di cadere sfasciati. È il momento dello scandalo; e il veleno diffuso è così forte che ha il potere di paralizzare la stessa carità.
Eppure dobbiamo dire che quella madre ha ragione. Sul filo della giustizia, dobbiamo ammettere che essa si è sacrificata per i suoi cari. Gli altri si sono concessi molte libertà; ella no: ha lavorato, accumulato, difeso, potenziato.
C’è poi una cosa più grave, quella che veramente fa soffrire: non è stata capita: si è passati accanto al suo sacrificio senza tenerne conto, ecc., ecc.
Ognuno di noi, a questo punto, può raccontare la sua storia; e – caso strano – ognuno di noi si sente sull’esatta posizione di quella madre, ognuno di noi si sente vittima di qualcuno o di qualcosa. Chi ha avuto una infanzia senza affetti, chi è stato mal ricompensato dall’ufficio, chi non è stato giustamente valutato nel passaggio di categoria, chi non è diventato ministro, chi è stato arrestato innocente, chi sente d’esser diventato tisico per lo starnuto di un vicino, chi non è stato capitto dal Vescovo, chi è stato obbligato a dare le dimissioni da presidente e chi è stato mandato in cucina invece di essere nominato superiore del convento.
Ma il caso più strano è che ciascuno di noi ha ragione e che ciò che ho detto è vero.
È difficile che nella lunga vita di un uomo, data la giungla in cui si è piombati, non si riceva da qualcuno uno sgarbo, un torto, una zampata o magari un colpo di rivoltella. Allora, sotto il peso di questo torto o stesi sul letto per il male che altri ci hanno procurato, incominciamo a gustare la delizia del vittimismo.
È un dolore insopportabile; ed è tanto più insopportabile in quanto non colpisce una parte di noi stessi, ma tutto il nostro essere fino nelle radici più profonde, fino ai rapporti con Dio, fino ai rapporti col prossimo.
Come posso amare, veramente amare il fratello che vive ogni giorno alle spalle della mia fatica e mi ripaga con la sua indifferenza e sovente col disprezzo? Come mi posso sentire a mio agio in un convento dove i miei simili non han tenuto conto della mia vera identità e non han capito i miei meriti? Come posso lavorare ancora con entusiasmo in un’impresa che ha promosso un inetto e relegato me nel nascondimento della monotonia quotidiana?
No, non è possibile; e di fatto non amo più, non posso più amare.
Ma non amare più, non poter più amare non è cosa da poco, una faccenda che mi lasci indifferente.
Amare, piaccia o non piaccia, è il fine della mia vita, è il perché della mia esistenza, è l’unica vera gioia a cui attingere senza mai saziarsi.
Difatti, da quando non amo più, la gioia se n’è andata da me, e la stessa pace è in gioico.
Nelle notti insonni sento il tarlo roditore che mi distrugge, sento il veleno che sale nei meandri dello spirito e mi paralizza. Provo a pregare; ma la stessa preghiera mi è diventata amara, vuota di senso.
Si direbbe che il cielo non mi risponde più. Al mio grido invocante giustizia il silenzio più assoluto ne è l’eco abissale. Si direbbe che qualcosa è cambiato lassù e che gli stessi canoni che reggevano l’antica legge non commuovono più il Dio giusto.
* * *
Sì, è proprio così. Il Dio della giustizia ha voltato per sempre la pagina della giustizia. Era bella, era vera, ma non era completa quella pagina; soprattutto non aveva l’esplosività di Dio. All’uomo finito nel vicolo cieco del peccato i canoni della giustizia e della verità erano incapaci di offrire salvezza. Ci voleva qualche altra cosa; ed era il segreto nascosto nei secoli in Dio.
E venne Gesù!
E i suoi non lo ricevettero. Non solo, ma lo spinsero fuori della sua dimora, come capro espiatorio, verso il deserto.
Tutta l’umanità gli fu addosso per colpire, sputare, odiare.
E Gesù, l’unico innocente, il vero innocente, piegò il capo sotto i colpi; non invocò la giustizia e pagò sulle sue carni e nel suo spirito il peccato di tutti.
Era da quell’istante e per sempre instaurata la legge del perdono, della misericordia, dell’amore che va al di là della giustizia.
Dopo l’episodio del Calvario, la pace sarebbe passata non più nel rasoio della verità o nel tribunale della legge, ma nel cuore squarciato di un Dio che s’era fatto per noi «peccato» in Cristo Gesù.
Era finita l’epoca del vittimismo e incominciava, con Gesù, la dinastia della «vittima».
La vera vittima, silenziosa vittima, vittima che si paragona all’agnello, vittima che accetta di essere vittima e che distrugge nel fuoco del suo amore gli sterpi dell’ingiustizia.
«Dio ama l’ilare donatore» dirà S. Paolo; e la vittima è l’ilare donatore.
Dio sarà l’ilare donatore nel suo Cristo; il suo dono sarà irreversibile; perdonerà, e per sempre, tutti i peccati; rifarà la verginità perduta, ridarà vita alle ossa stanche del peccatore, trasformerà una prostituta in Maria Maddalena e un gaudente qualsiasi in S. Francesco. La vita trionferà sulla morte e la primavera troverà forza e bellezza dallo stesso letame della terra.
«Io ho vinto il mondo» griderà il Cristo nel suo sacrificio; e la gioia tornerà a fiorire nel nostro cuore angosciato.
* * *
Sì, al di là della giustizia anche per me.
Per vincere la cancrena del vittimismo debbo andare al di là di questa aspra montagna. Come Gesù, ad imitazione di Gesù, debbo risalire faticosamente il versante del mio dolore e gettarmi con coraggio nella discesa verso i fratelli, tutti i fratelli, e in primo luogo verso coloro che la miopia dei miei occhi malati vede come causa dei miei mali.
Non c’è altra soluzione. È il sine qua non della vera pace e dell’intimità con Gesù.
Finché perdo tempo a difendermi, non concludo nulla e resto fuori dal vero cristianesimo, cioè dalla conoscenza profonda del Cuore di Gesù. Non debbo nemmeno più elencare le mie ragioni, perché dinanzi a me troverò sempre un fratello che elencherà le sue; e la dialettica andrà all’infinito.
Perdonare, veramente perdonare significa, in fondo, convincersi che il male che ci han fatto ce lo meritavamo. Più ancora: che è bene soffrire in silenzio. Più ancora: che è riservata la beatitudine a coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, come insegnò Gesù; e che è stolto perdere la preziosità di simili istanti per un po’ di vanità o di orgoglio umano.
Che cosa direbbe l’umanità se, seguendo Gesù sul Calvario, lo vedesse improvvisamente voltarsi adirato verso un uomo che gli ha datop un calcio e gridargli: «Sai chi sono io?».
No. Gesù non s’è voltato, per difendersi, verso coloro che lo insultavano; non ha gridato i suoi meriti o la sua identità alla folla che lo crocifiggeva; soprattutto non li ha odiati interiormente, pensando che li avrebbe condannati all’inferno quanto prima.
La novità dell’amore di Gesù sta tutta qui; ed Egli l’aveva così ben insegnato e Luca così ben raccolto.
«Ma a voi che ascoltate dico: Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano; benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi calunniano. A chi ti percuote su di una guancia, porgi anche l’altra; e a chi ti prende il mantello, non impedire di toglierti la tunica» (Lc 6, 27ss).
È inconfondibile lo spirito di Gesù, è talmente unico!
E Paolo, che fu senza dubbio il migliore interprete di tale spirito, nel profondo del cuore di Cristo, quando vorrà dare la linea programmatica della posizione del cristiano dinanzi a Dio e al mondo, dirà nella lettera ai Filippesi: «Abbiate in voi quel sentire che era in Gesù, il quale, sussistendo in natura di Dio, non considerò questa sua uguaglianza con Dio come una rapina, ma vuotò se stesso assumendo la forma di schiavo e, facendosi simile all’uomo, umiliò se stesso fattosi ubbidiente sino al punto di morire su una croce» (Fil 2, 5).
Qui sta il sunto di tutte le virtù e di tutte le perfezioni.
«Abbiate in voi il sentire di Gesù».
Questo «sentire di Gesù», questa sua «sete di abbassarsi» per obbedire al Padre e per salvare l’uomo, resterà per sempre il capolavoro dell’amore del Cristo.
Ecco perché non è sufficiente la verità e la giustizia; ecco perché siamo invitati ad andare oltre.
Più avremo in noi questa «spinta verso il basso ad imitazione di Gesù», più l’umiltà regnerà nel nostro cuore e la pace inonderà la nostra vita.
In fondo, in queste poche righe c’è in gioco la santità dell’uomo sulla terra.
Il Dio dell’impossibile
Un incidente in pieno deserto mi ha paralizzato una gamba. Quando è arrivato il medico – otto giorni dopo – era troppo tardi e forse resterò zoppo per tutta la vita.
Steso su una stuoia, in una cella d’un vecchio fortino sahariano, considero le macchie del tempo sul muro di fango intonacato a calce dai soldati della legione straniera.
I 45 gradi di calore rendono difficile ogni ragionamento. Preferisco pregare; ma anche pregare non è facile in certi momenti.
Taccio e cerco di portarmi coll’anima al di là del muro, nella piccola Kuba di stile arabo dove so che c’è l’Eucarestia.
I fratelli sono lontani al lavoro, chi nei campi, chi nell’officina.
La gamba mi duole terribilmente e debbo farmi coraggio, per non disperdere i pensieri nel vuoto.
Mi ricordo bene una frase che ci diceva Pio XI durante l’udienza: «Che fa Gesù nell’Eucaristia?» e attendeva da noi studenti la risposta.
Ancora oggi dopo tanti anni non saprei cosa rispondere.
Che cosa fa Gesù nell’Eucaristia?
Eppure quante volte ci ho pensato su.
E Gesù non solo una gamba, ma tutt’e due ha immobilizzate nell’Eucaristia e in più le mani. È ridotto a un po’ di pane bianco.
Il mondo ha tanto bisogno di Lui e Lui non parla. Gli uomini hanno tanto bisogno di Lui e Lui non si muove!
L’Eucaristia è davvero il silenzio di Dio, la debolezza di Dio.
Ridursi a pane, ridursi a silenzio mentre il ritmo del mondo è così chiassoso, così convulso, così possente.
Si direbbe che il mondo e l’Eucaristia marciano in senso inverso.
E si allontanano l’un l’altro quasi all’infinito.
Occorre essere coraggiosi per non lasciarsi portare dalla marcia del mondo, occorre della fede e della volontà per andare contro corrente verso l’Eucaristia, per fermarsi, per tacere, per adorare.
Ed è necessario una fede ben pura per credere all’impotenza, alla sconfitta dell’Eucaristia che è oggi ciò che fu ieri l’impotenza e la sconfitta del Calvario.
Eppure, questo Gesù impotente, inchiodato, annientato è il Dio dell’impossibile, è l’alfa e l’omega, il principio e la fine e, come lo descrive Giovanni nell’Apocalisse, «il fedele e verace che con giustizia giudica e guerreggia. I suoi occhi sono come fiamma di fuoco e sul suo capo stan molti diademi. Ed è ravvolto in un manto tinto di sangue e si chiama il nome di Lui ‘Verbo di Dio’. E gli eserciti che sono nel Cielo lo seguono su cavalli bianchi, vestiti i bisso bianco e puro. E dalla sua bocca esce una spada affilata perché con essa percuota le genti e le governi con bastoni di ferro. Ed egli stesso pigia nel tino il vino dell’ardente collera di Dio onnipotente. E sul manto e sulla coscia un nome scritto ‘Re dei re e Signore dei signori’» (Ap. 19, 11ss).
Gesù è il Dio dell’impossibile e l’impossibile è una caratteristica di Dio.
E la mia impotenza mette in evidenza la sua potenza, la mia piccolezza di creatura il suo Essere creatore.
Già davanti a Giobbe, pensoso e in polemica con Lui perché ridotto all’impotenza e all’abiezione, Dio chiedeva un atto di confidenza appellandosi, per ottenerlo, alla grandezza della creazione.
“Ov’eri tu quand’io gettavo i fondamenti della terra?
Chi fissò le sue dimensioni che tu sappia?
Ovvero chi stese sovr’essa la livella?
Su che cosa stanno infisse le sue basi e chi gettò la sua pietra angolare mente m’innalzavano lodi in coro gli astri del mattino?” (Gb 38).
A me oggi più di questo famoso discorso sulla potenza del Creatore e sull’assoluta impotenza della creatura a dare qualche consiglio a Dio, fa effetto un detto di Gesù nel Vangelo:
“È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli” (Mt 19,23).
Mi ritorna alla mente questa espressione di Gesù tutte le volte che vedo sulla pista un cammello e mi vien da sorridere.
Avesse detto “un cavallo, un bue…”, no: un cammello, con tutta quella gobba!
Sì, veramente è impossibile farla transitare per la cruna di un ago.
Creare il firmamento è certamente un segno di grande potenza, ma far passare un cammello nella cruna di un ago mi sembra più grande ancora: qui sta veramente l’impossibilità.
Difatti agli apostoli attoniti e perplessi che esclamarono: “Allora è impossibile salvarsi”, Gesù rispose tranquillamente: “Ma ciò che è impossibile all’uomo è possibile a Dio”.
“A te tutto è possibile”, dirà Gesù al Padre nella preghiera del Getsemani. L’onnipotenza è davvero l’attributo di Dio.
***
Al contrario, c’è una cosa ch’è veramente mia: la piccolezza, la debolezza, la miseria, l’impotenza.
E ne ho in sì gran copia che è impossibile che non serva qualcosa.
Occorre pensarci, occorre sfruttare questo immenso capitale. Possibile che l’onda di fango, chiamato peccato, che ha invaso il mondo quasi all’origine dell’uomo e che prende in certi istantiproporzioni sì gigantesche e spaventose, sia materiale inutilizzato dall’onnipotenza di Dio?
Possibile che la debolezza nelle sue forme così generali di stanchezza, vecchiaia, malattia, incapacità, errore, morte sia solo qualcosa che mi schiaccia senza avere in sé qualche potere nascosto?
I detriti del mondo non servono più a nulla?
Il male resterà una sconfitta di Dio Amore?
Quando penso ai miei esami di coscienza serali li vedo come elencazione di cose non fatte o fatte male che il sunto di cose positive.
E anche ammettendo, per un momento, un certo equilibrio raggiunto dalla mia anima, una esclusione positiva dell’offesa volontaria a Dio, nulla mi dà più il senso della mia infinita piccolezza e miseria che la constatazione tremenda della mia impossibilità a dilatare il mio amore.
Mi ritorna sempre il ricordo bruciante della coperta negata a Kadà e la sensazione quasi fisica di essere incapace di fare un atto di amore perfetto.
La stessa cosa l’ho provata nella preghiera.
Abbandonato a me stesso con le mie sole forze, ho sentito fino allo spasimo la realtà che, senza l’aiuto di Dio, non possiamo nemmeno dire una sola volta “Abba, Padre”.
Ci sono degli istanti in cui Dio ci conduce sull’estremo limite della nostra impotenza ed è allora e solo allora che comprendiamo fino in fondo il nostro nulla.
Per tanti anni, per troppi anni, mi son battuto contro la mia impotenza, contro la mia debolezza. Il più sovente l’ho nascosta preferendo apparire in pubblico con una bella maschera di sicurezza.
È l’orgoglio che non vuole l’impotenza, è la superbia che non accetta di essere piccolo; e Dio, poco alla volta me lo ha fatto capire.
Ora non mi batto più, cerco di accettarmi, di considerare la mia realtà senza veli, senza sogni, senza romanzi.
È un passo innanzi, credo; e se l’avessi fatto subito, quando imparavo a memoria il catechismo, avrei guadagnato quarant’anni.
Ora, l’impotenza mia la metto tutta in faccia all’onnipotenza di Dio: il cumulo dei miei peccati sotto il sole della sua misericordia, l’abisso della mia piccolezza in verticale sotto l’abisso della sua grandezza.
E mi pare essere giunto il momento di un incontro con Lui mai conosciuto fino ad ora, uno stare assieme come mai avevo provato, uno spandersi del suo amore come mai avevo sentito. Sì, è proprio la mia miseria che attira la sua potenza, le mie piaghe che lo chiamano urlando, il mio nulla che fa precipitare a cateratte su di me il suo Tutto.
E in questo incontro tra il Tutto di Dio e il nulla dell’uomo sta la meraviglia più grande del creato.
È lo sposalizio più bello perché fatto da un Amore gratuito che si dona e da un Amore gratuito che accetta.
È, in fondo, tutta la verità di Dio e dell’uomo.
E l’accettazione di questa verità è dovuta all’umiltà ed è per questo che senza umiltà non c’è verità e senza verità non c’è umiltà.
«Respexit humilitatem ancillae suae», disse Maria quando vide precipitare sul suo nulla l’amore sostanziale di Dio e sentì che le sue carni divenivano dimora e nutrimento del Verbo Incarnato.
Quale meraviglia il Nulla di Maria attirare il Tutto di Dio.
Quale dolcezza nella sua preghiera, avendo essa totale la consapevolezza di trovarsi al polo estremo di Dio, là dove l’esser piccoli diventa non solo un’accettazione, ma è una esigenza d’amore.
Quale pace nell’abbandono totale di sé a “Lui” senza ritorni “egocentrici”, senza movimenti “introversi”, ma rapita in un solo radicale, saporoso sguardo contemplativo sulla grandezza e perfezioni dell’Amato.
Non esiste rapporto più perfetto, e Maria inaugura su un’altezza vertiginosa, irraggiungibile da noi, ma per noi esemplare, lo stap più assorbente dell’anima religiosa sotto la rugiada di Dio.
***
Mi par così d’aver trovato, dopo tanti anni, la soluzione del problema, di tutto il problema di quaggiù.
Ho toccato con mano la mia radicale impotenza e questo fu grazia.
Ho contemplato nella fede, nella speranza e nella carità, l’onnipotenza di Dio e anche questo fu grazia.
Dio può tutto, io non posso nulla. Ma se metto questo nulla a contatto orante, amoroso di Dio, il tutto diventa possibile in me.
Ritorno con la memoria sotto la grande pietra schiacciato dal mio egoismo, chiuso nel mio purgatorio per aver negata la coperta a Kadà.
È cosa certa: in me sento la totale incapacità a compiere l’atto di amore perfetto, a seguire Gesù sul Calvario ed a morire con Lui in croce.
Potremmo trascorrere millenni e millenni e la mia situazione non cambierà.
Però… Però ciò che è impossibile a me, perché sono ricco del Vangelo, è possibile a Dio!
E sarà Lui a darmi la grazia di trasformarmi e rendermi atto a compiere l’impossibile e a rovesciare la pietra che mi separa dal Regno.
È quindi questione di attesa, di preghiera umile e confidente, di paziente esercizio, di speranza.
Ma il Dio dell’impossibile non mancherà all’appello del mio amore.
La notte amica
Quando venni nel Sahara, cinque anni fa, non amavo la notte. Essa era in me troppo legata al modo di vivere europeo, che non è certo il migliore e soprattutto è il meno adatto a farci conservare la calma e i nervi distesi.
Notte significa, per molti, fatica da aggiungere a quella del giorno; per altri dissipazione, per altri ancora insonnia, noia e cose del genere: il tutto sotto la grande insegna estenuante delle luci artificiali.
Qui è tutt’altra cosa.
La notte è innanzitutto riposo, vero riposo. Al tramontar del sole la natura si placa, si distende come sotto l’azione di un improvviso cenno divino.
Il vento che ci ha accompagnato col suo urlo e la sua rabbia quasi tutto il giorno, cessa, il caldo si mitiga, l’atmosfera si fa chiara e tersa, e ovunque si stende una grande pace, come se elementi e uomini volessero rifarsi dopo la gran battaglia del giorno e del sole.
Sì, la notte quaggiù è un’altra cosa; non ha perduto la sua verginità, il suo mistero: è rimasta come Dio l’ha fatta, creatura sua, apportatrice di bene e di vita.
Finito il lavoro, fermata la carovana, ti stendi sulla sabbia con una coperta sotto il capo e resti così a respirare lungamente e saporosamente la brezza che ha preso il posto di quel nemico, arido e infuocato vento del giorno.
Poi ti allontani dall’accampamento e vai sulle dune per la preghiera. Il tempo passa non turbato dalla fretta né dall’orologio. Nessun impegno ti assilla, nessun rumore ti disturba, nessun importuno ti attende; il tempo è tutto tuo. Ti sazi così di preghiera e di silenzio mentre nel cielo si accendono le stelle.
Chi non ha visto non può credere ciò che sono le stelle per il deserto! Sarà anche la mancanza assoluta di luci artificiali e la vastità immensa dell’orizzonte ad aumentarne il numero e il fulgore: è certo che è uno spettacolo impressionante.
Solo il fuocherello dell’accampamento sul quale bolle l’acqua per il the e sotto il quale cuoce il pane per la cena s’inquadra con una luce discreta e guizzante in tutto quello scintillio di cielo.
Mi sono bastate le prime notti vissute quaggiù per chiedere d’urgenza libri di astronomia e carte del cielo; e per mesi e mesi ho occupato il mio tempo libero a rendermi un tantino conto di ciò che mi transitava sul capo lassù, nelle profondità abissali del cosmo.
***
Tutto fu elemento di gioia e materia per la mia preghiera d’adorazione.
Inginocchiato sulla sabbia ho sprofondato per ore e ore gli occhi in quelle meraviglie, segnando come un fanciullo le nuove scoperte sul taccuino.
Ho capito ad esempio, che l’orientamento nel deserto, è molto più facile la notte che il giorno, che i punti di riferimento sono infinitamente più numerosi e sicuri.
In cinque anni, di cui quattro in pieno deserto, per motivo di lavoro, non mi sono mai smarrito, grazie alle stelle.
Quante volte alla ricerca di un accampamento Tuareg o di una stazione meteorologica sperduta, la luce del giorno, il vento di sabbia, il sole troppo alto mi facevano smarrire la pista.
Ebbene: attendevo la notte, e la strada perduta era ritrovata sull’orientamento preciso delle stelle.
La notte Sahariana, con suo firmamento, non è solo un fantastico quadrante di orientamento, ma è anche una dimora riposante per l’anima.
Dopo la giornata – con tutta quella luce – l’anima è ridotta a una casa con finestre senza gelosie, scardinate dal vento o bruciate dal sole.
Ma la notte!
A poco a poco le finestre dell’anima sono di nuovo sistemate, rinchiuse; megli, socchiuse dal buio; e gli occhi spalancati attraverso quelle fessure possono, senza sforzo e tensione, fissere pacatamente le cose attorno.
No; non dimenticherò mai le notti sotto le stelle del Sahara. Mi sento un punto fasciato dal buio amico trapuntato di stelle.
Sì; un buio amico, una oscurità affettuosa, tenebre riposanti, necessarie, vitali.
In esse la mia attività interiore non viene mortificata, ridotta; ma, al contrario, può distendersi, realizzarsi, accrescersi, gioire.
Mi sento come in casa, al sicuro, senza paura, fasciato da questa fedeltà amorosa della notte amica, desideroso solo di restare così per ore e ore, preoccupato solo della sua brevità e avido di leggere inme e fuori di me quei caratteri e quei simboli di un linguagio divino.
***
La notte amica è un’immagine della fede, cioè di quel dono di Dio definito da San Paolo «Realtà delle cose sperate e convincimento delle cose che non si vedono» (Ebr 11, 1).
Mai ho trovato un paragone più adeguato al mio rapporto con l’Eterno: un punto perduto nello spazio infinito, avvolto dalla notte fonda sotto la luce discreta delle stell.
Questo punto sperduto nello spazio sono io; il buio necessario, amico insostituibile, la fede; le stelle, la testimonianza di Dio.
Quando la mia fede era debole, non provata dallo sforzo né dall’esperienza religiosa, mi poteva apparire incomprensibile, quasi paurosa come la notte per il bimbo. Ma ora che l’ho conquistata, che è mia, provo gioia a vivere in essa, a navigare in essa come sul mare; non la sento più nemica, non mi fa più paura; anzi, mi dà gioia, proprio per la sua oscurità e trascendenza divina.
A volte amo perfino chiudere gli occhi per vedere più buio. Tanto, lo so che le stelle sono là, al loro posto, al giusto posto a testimoniarmi il cielo; ed io per poco tempo posso gustare il perché sia necessario il buio.
Necessario il buio, necessaria l’oscurità della fede per non essere feriti dalla troppa luce di Dio.
Per la mia natura d’uomo, non c’è altra possibilità e comprendo sempre più che la fede non è una misteriosa e crudele astuzia di un Dio che si nasconde senza dirmi il perché, ma è un velo necessario e insostituibile perché la mia scoperta di Lui avvenga gradualmente rispettando le tappe dello sviluppo della vita divina in me.
«Nessuno può vedere Dio senza morire» dice la Scrittura nel senso che il vederlo faccia a faccia è solo una possibilità per coloro che sono passati attraverso lo stadio della morte.
Per lo stadio terreno – che è il primo – tale è la luce, tale l’infinitezza del mistero e tale è l’inadeguatezza della natura umana, che debbo penetrarlo poco alla volta. Prima attraverso i simboli, poi nell’esperienza, poi nella contemplazione che mi può essere anticipata su questa terra se resto fedele all’amore di Dio.
Ma sarà solo un inizio, un abituare gli occhi dell’anima a sopportare tanta luce; ma il processo continuerà senza fine; e sempre rimarrà il mistero tanto ci sovrasta l’infinitezza di Dio.
In fondo, che cos’è la nostra vita quaggiù se non lo scoprire, il prendere coscienza, il penetrare, il contemplare, l’accettare, l’amare questo mistero di Dio, unica realtà che ci circonda e nella quale siamo immersi come meteoriti nel cosmo senza fine? «In Deo vivimus movemur et sumus!» (Atti 17, 28). Non ci sono molti misteri; ce n’è uno solo da cui tutto dipende e da cui non si può sfuggire, ma è talmente immenso da riempire tutto lo spazio.
Le scoperte umane non spostano di un dito il problema: i millenni che passeranno non scriveranno nulla di più di ciò che diceva già Isaia con la sua potente espresione sul «Deus absconditus» e Dio stesso dichiarava a Mosè in adorazione dinanzi al roveto ardente: «Ego sum qui sum» (Es 3, 14).
Forse il cielo era meno oscuro per Abramo e per gli uomini della tenda che per l’uomo moderno; e la fede era più facile per i poeti medioevali che per i tecnici di oggi; ma la situazione è la stessa e il rapporto con Dio è identico.
Capita forse all’umanità intera ciò che capita all’uomo singolo, al quale, più avanza verso la maturità, più è richiesta una fede nuda di sentimento e spoglia di poesia. Ma la via rimane la stessa fino all’ultimo uomo che nascerà su questa terra. «Questa è la vittoria che vince il mondo: la fede» (1Gv 5,4).
Dio chiede all’uomo un atto di confidenza in Lui; e questo atto è la vera, l’autentica sottomissione della creatura al Creatore, un atto di umiltà, d’amore.
Questo «confidare in Dio», questo «far credito all’Onnipotente», questo appagare la nostra sete di sapere nell’infinito mare della sua paternità, questo accettare il suo misterioso piano, questo entrare alla scuola per ascoltare la sua Parola, questo «saper attendere» è l’atto di adorazione degno dell’uomo su questa terra.
Ma se per orgoglio non vogliamo metterci sul sentiero della fede e voltiamo le spalle alla realtà divina e chiudiamo gli occhi dinanzi alla testimonianza delle stelle, che cosa risolviamo noi? Aumenta forse la nostra conoscenza del mistero? Troviamo altrove più luce alla nostra notte? In fondo che cosa sappiamo noi?
Senza giungere a parlare di Dio e della Incarnazione del Verbo e dell’Eucaristia, che cosa sappiamo noi dello stesso mondo fisico che ci circonda? Di ciò che capita dopo la nostra morte? Del dolore degli animali e del destino delle cose? Di ciò che capita su Andromeda e di ciò che avviene alla gazzella che muore?
Ciò che sappiamo è poco più di nulla; e quel poco che sappiamo è tutto instabile e relativo, se non veniamo a scoprire le cause prime.
Un senso di sgomento dovrebbe coglierci ad ogni scoperta, che è là per dirci: «Solo oggi arrivi?».
Come rimane vera e preziosa la raccomandazione di Gesù: «Se non vi farete piccoli… non entrerete…».
* * *
Ciò che ho cercato di dire sulla fede vale per tutti; nessuno può sfuggire a questa realtà che è un dono di Dio, ma che ha bisogno, per realizzarsi, del nostro sforzo.
Dio ci dà la barca e i remi, ma poi ci dice: «tocca a te remare». Fare «atti positivi di fede» è come allenare questa facoltà; e l’allenamento sviluppa la facoltà come la ginnastica il muscolo.
Davide sviluppò la sua fede accettando di battersi con Golia, Gedeone si esercitò nella fede non solo domamdando al Signore la prova del vello sotto la rugiada della notte, ma andando alla battaglia con pochi soldati contro un nemico più forte.
Abramo diventò un gigante della fede accettando fino all’estremo limite il buio di una obbedienza che gli chiedeva il sacrificio del figlio.
S. Paolo dirà nella lettera agli Ebrei: «Nella fede i nostri Padri ricevettero buona testimonianza» e continua «per la fede molti furono messi alla tortura, non accettando la liberazione per ottenere una risurrezione migliore; altri ebbero a provare scherni e sferze e anche ceppi e prigione; furono lapidati, sottoposti a dure prove, segati; morirono di spada, andarono in giro in pelle di capra, mancanti in tutto, perseguitati, maltrattati. Di essi non era degno il mondo e andarono errando per i deserti e i monti e le caverne e le spelonche e le grotte della terra» (Eb 11,2ss).
Ma su tutti gli uomini e tutte le donne, che vissero di fede, due creature giganteggiano, raggiungendo una maturità quasi sovrumana.
Esse sono poste sullo spartiacque del Vecchio e del Nuovo Testamento e chiamate da Dio ad una vocazione talmente unica e grandiosa che fa restare il cielo in sospeso ad attendere la loro risposta: Maria e Giuseppe.
Maria deve divenire la Madre del Verbo, deve dare carne e ossa al Figlio di Dio; e Giuseppe deve velare il mistero mettendosi accanto a Lei, per far credere a tutti che Gesù sia suo figlio.
Per queste due creature la notte della fede non fu solo buia; fu dolorosa.
Un giorno Giuseppe, fidanzato a Maria, s’accorge che Ella deve dare alla luce un figlio e sa che quel figlio non è suo.
Ci sono parole capaci di convincere un fidanzato che il mistero di quella nascita è dovuto nientemeno che alla paternità di Dio?
Nessun ragionamento poteva dar pace e serenità a Giuseppe. Solo la fede; ma essa era così buia da obbligare l’anima ad altezze vertiginose.
E sarà proprio questa fede nuda e dolorosa a sostenere questo gigante, a metterlo accanto alla Madre di Dio, ad accompagnarla nel suo destino, a partecipare in pieno alla sua missione.
Oh, non sarà facile mettersi sulla scia d’un uomo destinato a soffrire e sposo di una donna che sarà chiamata madre dei dolori.
Il Bimbo è nato.
Qualche Angelo è venuto, sì, a fugare un po’ di tutto quel buio; ma subito il cielo si richiude su un buio più grande ancora; i bimbi d’un intero villaggio sono trucidati a causa del loro bimbo; e Giuseppe e Maria, fuggendo, sentono il pianto e l’ululato dele donne di Betlemme.
Perché? Perché l’Onnipotente tace? Perché non uccide Erode? No; bisogna vivere di fede. Fuggire in Egitto, divenire esuli e profughi, lasciar trionfare la crudeltà e l’ingiustizia. E così fino alla fine.
Dio non ha facilitato la via a coloro che ha messo accanto a Suo Figlio; ha chiesto loro una fede così pura e così tagliente che solo due anime d’una umiltà così abissale potevano sostenere.
Quale avventura vivere per trent’anni in una casa dove vive Dio nelle carni d’un uomo terreno, mangiare con Lui, sentirlo parlare, vederlo dormire, scorgere sul suo volto il sudore e sulle mani i calli della fatica!
E il tutto con semplicità, come cosa normale, di ogni giorno: così normale da perderlo in un pellegrinaggio, come può capitare ad ogni altra famiglia; così normale che nessuno, nessuno svelerà il mistero, nessuno s’accorgerà che il figlio del fabbro era il figlio di Dio, il Verbo fatto carne, il nuovo Adamo, il Cielo in terra.
Dio mio, quale grandezza di fede!
Maria, Giuseppe, voi siete davvero e per sempre i maestri della fede, gli esemplari perfetti a cui ispirare le nostre azioni, correggere la nostra rotta, sorreggere la nostra debolezza.
Come allora accanto a Gesù, siate ancora accanto a noi per accompagnarci verso l’Eterno, per insegnarci ad essere piccoli e poveri nel nostro lavoro, pazienti nell’esilio, umili e nascosti nella vita, coraggiosi nelle prove, fedeli nella preghiera, ardenti nell’amore.
E quando verrà l’ora della nostra morte, cioè spunterà l’aurora sulla nostra notte amica, possano i nostri occhi, fissando il cielo, scorgere la stessa stella che fu sul vostro cielo quando Gesù venne su questa terra.